Texts ︎









Collectible DRY Vol.15
Psychedelia




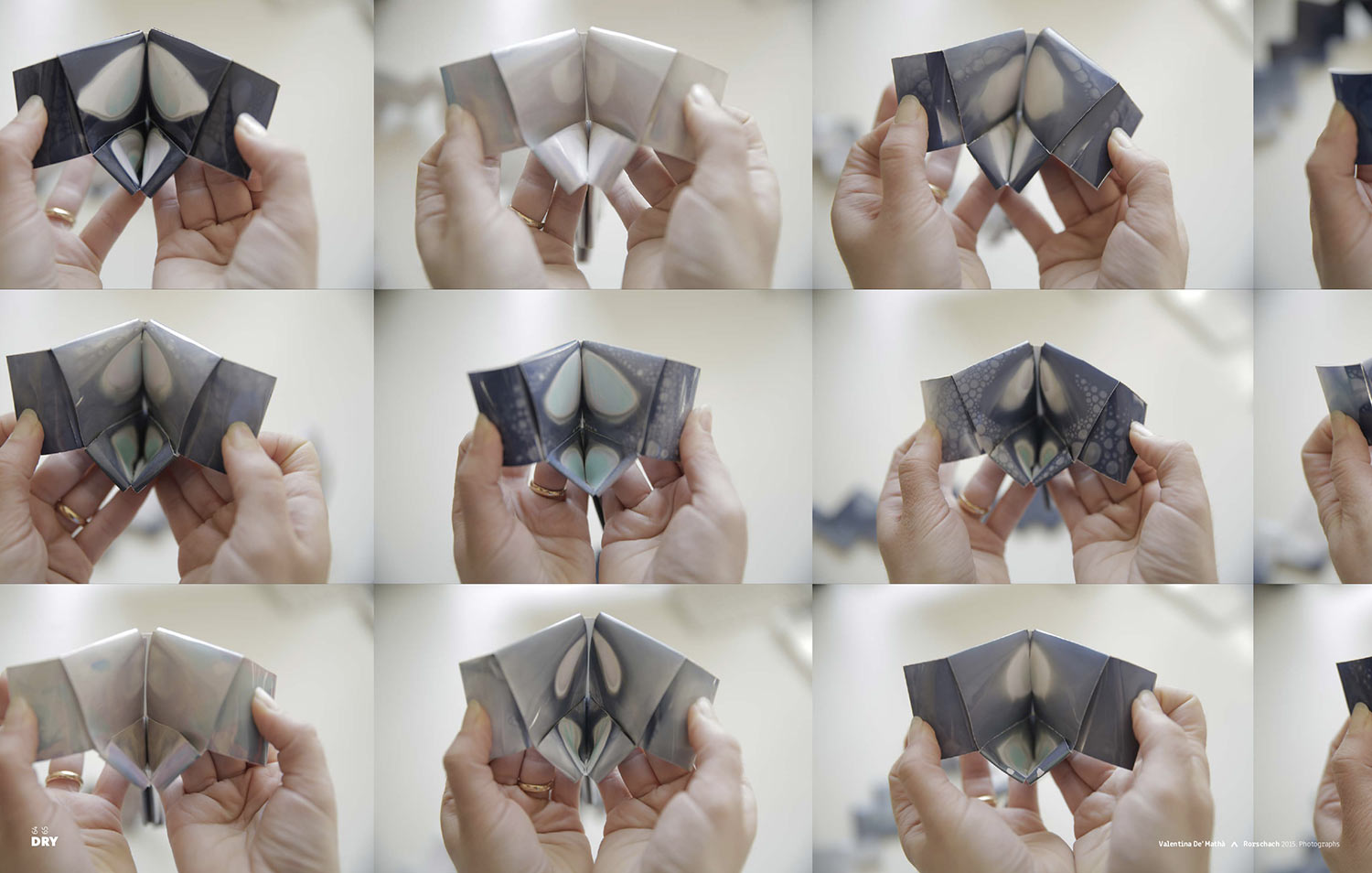
ALTERING
THE ORIGINAL CHEMISTRY
THE GODDESS OF SNAKES
Valentina De’Mathà
in conversation with
Gianluca Marziani
Weaving is a ritual, mesmerizing act. It leads to ever new tales that change and grow as they develop and are repeated. My tapestries are receptacles of desires and thoughts, psychedelic states that alter the perception and vision of things as well as my state of consciousness, the way a snake sheds its skin, with its movements evoking the thread of the weft as it weaves in and out of the warp. "An eternally undulating cosmic energy line" I belong to the land of the goddess Angitia, a chthonic, telluric deity, a goddess of fertility and the cult of snakes and healing herbs. But also a land of ancient weaving. It was there that I was born. Her pagan figure is nowadays evoked in the Christian ritual of St. Dominic, when the statue of the saint is draped with living snakes. Like medicinal herbs that have the gift of healing, expanding consciousness, or killing, the same properties are associated with the poison of this revered and archaic reptile.
Can an artist escape the limits of acquired categories, linear languages, the didactic theme? Valentina De'Mathà investigates in cross-cutting ways the chemical reactions of materials, the multiple natures that a physical element can embody, the deviations from a customary use that becomes a metaphorical, iconographic and replicable value. She acts by processes and combinations, altering the original chemistry, pressuring some frail element, recreating value through gestural action. A path where lightness becomes layered, where conceptual layers are combined in soaring and poetic weaves. An expressive quality that moves with a liquid awareness and revealing curiosity.
How would you define your authorial identity in such a mixed historical moment for art being an artist?
What I am and distinguishes me can be seen and recognized through the final result of what I do and the way I do it. I'm evolving, still in the making. I find it quite hard to label myself or my work in words to define my identity or role. When we speak of the visual arts in words, certain meanings and essences are often lost. I can't and won't circumscribe, enclose or limit my research and my experience in any way, regardless of the historical context I live in, though clearly I can't escape it, and whether I like it or not, it sometimes influences some of my works. I leave the task of decoding that to the experts. But I can say that what I attain is necessary to me, urgent, my totally subjective gaze on my experience of everyday life, on the elusiveness, undecidability, uncertainty, changeability and complexity of the multitude compared with desire and will. My works are the result of my way of living and feeling alive and free in certain of my places, passions and interests. They are a consequence. They're attempts to recount or respond to what I experience intimately and I can't contain or keep completely secret. It's what defines my identity.
Tell me about the relationship between work and process, an aspect of your artistic work that I find crucial.
I work almost exclusively with materials that I can't fully control. My works are full of "errors". I like the word, because the root meaning of "erring" is "wandering". I like the idea of wandering and finding myself somewhere I never expected, filled with wonder. The creative process and the concept of my work go hand in hand. They certainly complement each other. My research explores the ambivalences that inwardly dominate humanity and consequently interpersonal relationships, in all their endless variations. This is the constant need for adventure and innovation, the inner need to lose control and be swept away by passions. And the contrary impulse to try in every way to freeze certain moments and make things predictable, manageable and safe, to build something foreordained and bind myself to it. My working method and choice of materials are designed to best represent these contrasts. One day, during a discussion, the theoretical physicist Ignazio Licata told me: "For some reason we think of order, science, the regularity of our lives with very specific criteria, like some law or algorithm that keeps us safe from all uncertainty. But if we tried to think of law as a grid of possibilities, then the bond, the fusion, between law, cause and chance (which etymologically simply means "whatever happens"), appears natural."
I notice you pay close attention to the relations between material, resistance and frailty. Your every project questions something that exists between stable and unstable, hard and soft, permanent and temporary.Tell me about this, whether you feel it’s true of you and how you practise it in your artwork.
My works often grow out of an organized and structured idea, but, as I said before, what interests me most is partial loss of control over the materials during the working and the potential it offers. They're metaphors for life. My tapestries, for instance, are created out of this ambivalence. On the one hand there's the process of layering the liquids of the photographic chemicals, which I have difficulty capturing and fixing on paper. Symbolically we could associate them with passions and desires that overwhelm us, experiences and certain states of mind we're unable to rationalize. On the other there's the urge and the effort to endow things with an order, a narrative, blending and weaving together this disorganized material into a modular structure based on the golden proportions, and then holding it together by sewing it. And this part could be paired with interpersonal ties and the desire to make sense of certain experiences that we struggle to organize and order rationally. As Umberto Galimberti writes: "Unlike love, which seeks construction and stability, desire is a movement towards a point of loss and madness. It refuses to allow itself to be possessed by any logic."
I feel there are always layered traces, overlapping memories, juxtapositions. How do you see this?
Photography in itself is the supreme medium for capturing and fixing the image. And even though it does so in illusory ways, this mechanism enables the memory to endure. I mainly use photo- graphic materials and processes, though I do so in abstract, in- formal ways. I try to grasp a fleeting instant, a feeling, though I'm happy not to be able to do it fully. Things can't be stopped, it's unrealistic and against nature. In Andrej Tarkovsky's film Stalker, one of the protagonists quotes a poem that is half Hermann Hesse and half Lao Tzu. He says that what is tender and gentle lives, what is dry and hard dies, just like a tree. Everything is mutable, unceasingly, in an overlapping and layering of experiences and moods. And it is inexplicable why people, despite knowing that change is life itself flowing in and around them, always want to stop these natural processes.
Creating an institutional event in a museum can mean finding new interactions and synergies, as well as compromises inherent in the spaces, themes and working with other people. Tell me about your experience with the Macro Asilo in Rome.
Most of my works are made with transparent, translucent and iridescent materials. They generally need light and installations in bright settings to bring them out fully. The MACRO Asilo, Museum of Contemporary Art in Rome, suggested I should create an interactive project involving the viewers in an all black, dimly lit room: the Black Room. At first I thought the basic premises were all wrong, with everything going clean contrary to my work, so it made no sense to show it there. Then I started thinking about it differently, trying to break the mould I'd often unwittingly and automatically relaxed and enclosed the vision of my work in for years. I opened out to new prospects and outlooks, changing and totally flipping my viewpoint and certainties. So there aren't going to be any white walls? Okay, then the works won't be hung but rolled up on themselves. There isn't going to be any light? The public has to interact? Okay, I'll put mirrors in these "mouths" and ask the viewer to light up the works using the torch on their smartphones as they see fit, the way that intrigues them most. The viewers become the protagonists and explore the exhibits, choosing the lighting, the viewpoint and the angle. I just wanted to create the opportunity, but it was up to the viewers to seek new forms, to look and dwell on whatever they wanted to see and the way they wanted to see it. The project #INTHESPACE grew out of a reflection on the complexity and disorder of reality narrated in Italo Calvino's Invisible Cities, and on the graphs, relational structures and organized data we find in everyday life and virtual communication. What interested me was to dwell on the often superficial and illusory way of expressing and communicating in today's society mainly through the social networks. The installation included a series of emulsified polyesters, which I painted in the dark room using photographic chemicals. Then I rolled them up on themselves symbolically creating mouths and inside them I placed mirrors to illuminate them, creating unrepeatable kaleidoscopic images. The mouth is the supreme organ we use for verbal communication, but it can also be a means for looking inward and being surprised by going deeply into things. The etymology of the word "space" is in spatium, meaning "being open". The smoothness of the polyesters I used symbolically recalled the bright screens of smartphones we're accustomed to communicating with today. After this I made some incisions in them that intersect and symbolize the social networks and individual fragmentation through the breakdowns caused by the way facts are increasingly distorted, and the harvesting of data, voluntarily and involuntarily, that we provide on a daily basis. This was used to create a social network, posting the images and videos made by the viewers on the main social networks with the hashtag #INTHESPACE.

ALTERANDO LA CHIMICA D’ORIGINE
LA DEA DEI SERPENTI
Valentina De’Mathà
in conversazione con
Gianluca Marziani
in conversazione con
Gianluca Marziani
Tessere è un atto rituale, ipnotico, porta a narrazioni sempre nuove che cambiano e crescono nel loro divenire e ripetersi. I miei arazzi sono contenitori di desideri e pensieri indicibili, stati psichedelici che alterano la percezione e visione delle cose e il mio stato di coscienza, come il fenomeno che avviene durante l'esuviazione nella vita del serpente il cui movimento rimanda al filo della trama che scorre su e giù per l’ordito.
“Una linea di energia cosmica eternamente ondeggiante” (Cit.)
Appartengo alla terra della dea Angizia, una divinità ctonia, tellurica, dea della fecondità e del culto dei serpenti e delle erbe officinali. Ma anche terra di antiche tessiture. È lì che sono nata.
La sua figura pagana al giorno d'oggi viene portata avanti attraverso il rito cristiano di San Domenico, durante il quale, la statua del santo, viene ricoperta di serpenti. Come le erbe officinali che hanno la capacità di guarire, donare una coscienza espansa o uccidere, le stesse proprietà sono associate al veleno di questo venerato e arcaico rettile.
Un artista può sfugge ai limiti di categorie acquisite, ai linguaggi lineari, al tema didascalico? Valentina De’Mathà, indaga, in maniera laterale, le reazioni chimiche delle materie, le molteplici nature che un elemento fisico può incarnare, le deviazioni da un uso consueto che diventa valore metaforico, iconografico, replicabile. L’artista agisce per processi e combinazioni, alterando la chimica d’origine, esasperando un elemento fragile, ricreando valore attraverso l’azione gestuale. Il risultato la porta su terreni diversi ma complementari, su una qualità espressiva che si muove con coscienza liquida e curiosità rivelatrice. Un percorso dove la leggerezza diviene layer, dove gli strati concettuali si amalgamano in tessiture svettanti e poetiche.
Come definiresti la tua IDENTITÀ AUTORIALE in un momento storico così eterogeneo per l’arte e l’essere artista?
Ciò che sono e mi distingue, lo si può vedere e riconoscere attraverso il risultato finale di ciò che faccio e il modo in cui lo faccio. Sono in cammino, sono ancora in divenire, mi riesce un po’ difficile “etichettare” a parole me stessa o il mio lavoro per definire la mia identità o un ruolo. Quando si parla di arti visive attraverso le parole, spesso certi significati ed essenze vanno a perdersi. Non riesco e non voglio circoscrivere, racchiudere o limitare in qualche modo quella che è la mia ricerca e il mio vissuto, a prescindere dal contesto storico in cui mi trovo, ma a cui non posso sicuramente sottrarmi e che, in modo voluto o meno, a volte influenza alcune mie opere.Lascio il compito della decodificazione agli addetti ai lavori. Posso però dire che ciò che realizzo è per me una necessità, un’urgenza, il mio sguardo del tutto soggettivo sulla mia esperienza del quotidiano, sull’inafferrabilità, l’indecidibilità, l’incertezza, la mutevolezza e la complessità della moltitudine, a confronto con il desiderio e la volontà. Le mie opere sono il risultato del mio modo di vivere e sentirmi viva e libera in certi miei luoghi, passioni e interessi. Sono una conseguenza. Tentativi di risposta o di narrazione verso ciò che vivo intimamente e che non riesco a contenere o a tenere del tutto segreto. È questo quello che definisce la mia identità.
Raccontami la relazione tra OPERA e PROCESSO, un aspetto che trovo determinante nel tuo fare artistico.
Lavoro quasi esclusivamente con materiali attraverso i quali non posso avere del tutto il controllo, i miei lavori sono pieni di “errori”, mi piace questa parola, perché viene da “errare", mi piace l’idea di allontanarmi e trovarmi dove non mi aspettavo, di lasciarmi meravigliare. Il processo creativo e il concetto del mio lavoro, camminano a pari passo, sono sicuramente l’uno complementare dell’altro. La mia ricerca è un’indagine sulle ambivalenze che dominano intimamente l’uomo e, di conseguenza, le sue relazioni interpersonali, in tutte le sue infinite declinazioni. Ovvero il costante bisogno di avventura e di novità, dell’intima necessità di perdere il controllo e di lasciarsi travolgere dalle passioni, annientando ogni schema; a quella contrapposta di cercare in tutti i modi di fermare certi istanti e rendere le cose prevedibili, gestibili e sicure, di edificare qualcosa di prestabilito e di legarsi. La mia metodologia di lavoro e la scelta dei materiali, sono appunto studiati per rappresentare al meglio questi contrasti. Durante un confronto, il fisico teorico Ignazio Licata, un giorno mi disse: “Per qualche motivo noi pensiamo all’ordine, alla scienza, alla regolarità della nostra vita con criteri ben precisi, come a una qualche legge o algoritmo che ci mette al sicuro da ogni incertezza. Se noi invece provassimo a pensare alla legge come ad una griglia di possibilità, ecco che lì il legame, la fusione, tra legge, causa e caso (che etimologicamente vuol dire semplicemente “ciò che accade”), appare una cosa naturale.”
Noto una forte attenzione al rapporto tra MATERIALE, RESISTENZA e FRAGILITÀ.
Ogni tuo progetto si interroga su un qualcosa che vive tra stabile e instabile, duro e morbido, permanente e temporaneo. Mi parli di questa cosa, se la senti come tua e in che termini la pratichi nel tuo esercizio artistico.
Le mie opere partono spesso da un’idea organizzata e strutturata, ma, come dicevo precedentemente, quello che più mi interessa è la parziale perdita di controllo sui materiali durante la loro realizzazione e le possibilità che ne scaturiscono. Sono metafore di vita. I miei arazzi, ad esempio, sono realizzati sulla base di questa ambivalenza. Da una parte c’è il processo di stratificazione della materia liquida dei chimici fotografici, che io a fatica cerco di catturare e fissare sulla carta, e che potremmo simbolicamente associarlo alle passioni e desideri che ci travolgono, alle esperienze e a certi stati d’animo che non riusciamo a razionalizzare. Dall’altra c’è la volontà e il tentativo di dare un ordine alle cose, una narrazione, combinando e intrecciando questa materia disorganizzata in una struttura modulare basata su proporzioni auree, e poi tenendola insieme cucendola. E questa parte potrebbe essere associata ai legami interpersonali e alla volontà di dare un senso a certe esperienze che facciamo fatica a organizzare e catalogare razionalmente. Come scrive Umberto Galimberti: “Il desiderio, a differenza dell’amore che vuole costruzione e stabilità, è un movimento verso un punto di perdita e follia. Non si lascia possedere da alcuna logica.”
Sento che ci sono sempre tracce stratificate, memorie sovrapposte, giustapposizioni. Cosa ne pensi?
La fotografia in sé è lo strumento che per eccellenza cattura e fissa l’immagine e, anche se lo fa in modo illusorio, questo meccanismo fa perdurare la memoria. Io mi avvalgo principalmente di materiali e processi fotografici, anche se lo faccio in modo astratto e informale, cerco di fermare un attimo che fugge via, una sensazione, benché sia felice di non riuscirci pienamente. Non si possono fermare le cose, questa è un’utopia e va contro natura. Nel film Stalker di Andrej Tarkovskij, uno dei protagonisti cita una poesia che per metà è di Hermann Hesse e metà di Lao Tzu e dice appunto che ciò che è morbido e flessibile vive, ciò che è duro e secco muore, proprio come un albero. Tutto è mutevole, senza sosta, in una sovrapposizione e stratificazione di esperienze e stati d’animo ed è inspiegabile perché l’uomo, nonostante sappia che il mutamento sia la vita stessa che scorre dentro e intorno a lui, abbia comunque sempre voglia di fermare questi naturali processi.
Realizzare un evento istituzionale all’interno di un museo, può significare trovare nuove interazioni e sinergie, ma anche compromessi inerenti agli spazi, alle tematiche e alla collaborazione con altre persone. Parlami della tua esperienza con il MACRO Asilo - Museo d’Arte Contemporanea di Roma.
La maggior parte delle mie opere sono realizzate con materiali trasparenti, traslucidi e cangianti che hanno generalmente bisogno di luce e di allestimenti in ambienti chiari per essere valorizzate al meglio. Il MACRO Asilo - Museo d’Arte Contemporanea di Roma, mi ha proposto di realizzare un progetto interattivo, che coinvolgesse il fruitore, in una stanza completamente nera e in penombra: la Black Room. Inizialmente ho pensato che i presupposti fossero tutti sbagliati, che tutto fosse contrario al mio lavoro, che non avesse senso esporlo lì. Ma poi ho cominciato a ragionare diversamente, a rompere gli schemi in cui avevo spesso, involontariamente, e automaticamente, adagiato e racchiuso la visione del mio lavoro per tenti anni, e mi sono aperta a nuove prospettive e possibilità, modificando e capovolgendo totalmente il mio punto di vista, e le mie certezze: Non ci sono pareti bianche?Ok, le opere non verranno appese, ma arrotolate su se stesse. Non c’è luce? Il pubblico deve interagire? Ok, metto degli specchi in queste “bocche” e chiedo al fruitore di utilizzare la luce del proprio smartphone per illuminare le opere come meglio crede, come più lo incuriosisce. È il fruitore che si fa protagonista, che va alla scoperta, è lui che sceglie la luce, che sceglie la prospettiva e l’angolazione. Io ho voluto creare solo un’opportunità, ma è toccato al fruitore cercare nuove forme, vedere e fermare ciò che voleva vedere e come voleva vederlo. Di conseguenza il progetto #INTHESPACE è nato da una riflessione sulla complessità e sul disordine della realtà narrati ne “Le città invisibili” di Italo Calvino, e sui grafi, che sono delle strutture relazionali e organizzazione dati che troviamo nella vita quotidiana e nella comunicazione virtuale. Quello che mi interessava era soffermarmi sul modo, spesse volte superficiale e illusorio, di esprimersi e comunicare della società di oggi attraverso principalmente i social network. L’installazione comprendeva una serie di poliesteri emulsionati che ho dipinto in camera oscura attraverso chimici fotografici e che poi ho arrotolato su se stessi creando simbolicamente delle bocche; all’interno poi ho posto degli specchi che, illuminandoli, creavano immagini caleidoscopiche irripetibili. La bocca è per eccellenza lo strumento che utilizziamo per la comunicazione verbale, ma può essere anche un mezzo attraverso cui guardare all'interno e lasciarsi sorprendere andando in profondità. L'etimologia della parola "spazio", viene da Spatium, ovvero "essere aperto”. La levigatezza dei poliesteri che ho utilizzato, richiama simbolicamente gli schermi luminosi degli smartphone attraverso i quali siamo abituati a comunicare nei giorni d’oggi. Ho poi praticato su di essi delle incisioni che si intersecano a simboleggiare le reti sociali e la frammentazione dell’individuo attraverso le scomposizioni indette da una realtà dei fatti sempre più distorta, e dalla raccolta dati che, volontariamente e involontariamente, forniamo nel quotidiano. L’installazione è stata ospitata nella Black Room del museo e, il mio intento è stato quello di portare il visitatore, in maniera naturale, ad utilizzare la luce del proprio smartphone per illuminare l’interno di questi cilindri. Successivamente è stata creata una rete sociale postando le immagini e video realizzati dagli spettatori, sui principali social network con l’hashtag #INTHESPACE.
VENTIDUE +
Valentina De’Mathà
in conversazione con Yuri Catania
https://www.youtube.com/watch?v=NToOHMMYtUk&t=857s
![]()
Valentina De’Mathà
in conversazione con Yuri Catania
https://www.youtube.com/watch?v=NToOHMMYtUk&t=857s
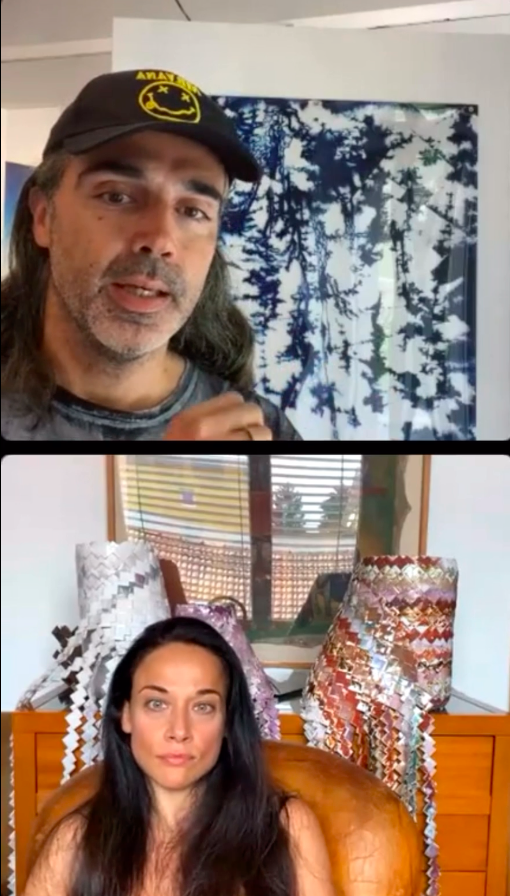
26 Agosto 2022
https://www.casagalleria.art/
https://www.casagalleria.art/
 L’Ambasciata d’Italia a Berna, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Zurigo, il Consolato Generale d’Italia a Lugano, il Consolato Generale d’Italia a Ginevra, il Consolato d’Italia a Basilea e l’Istituto Italiano di Cultura a Zurigo, è lieta di annunciare la collettiva UpCycle. Quando l’arte reinventa il mondo a cura di Silvio Mignano e Antonello Tolve, che sarà inaugurata il 5 maggio 2022 (ore 18:00) in Elfenstrasse 10, nell’ambito dell’ampio programma Residenza delle Arti.
L’Ambasciata d’Italia a Berna, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Zurigo, il Consolato Generale d’Italia a Lugano, il Consolato Generale d’Italia a Ginevra, il Consolato d’Italia a Basilea e l’Istituto Italiano di Cultura a Zurigo, è lieta di annunciare la collettiva UpCycle. Quando l’arte reinventa il mondo a cura di Silvio Mignano e Antonello Tolve, che sarà inaugurata il 5 maggio 2022 (ore 18:00) in Elfenstrasse 10, nell’ambito dell’ampio programma Residenza delle Arti. Valentina De’Mathà, artista italo-svizzera di origine abruzzese, tra i 20
talenti del 21° Premio Cairo
Valentina De’Mathà, artista italo-svizzera di origine abruzzese, tra i 20
talenti del 21° Premio CairoNata ad Avezzano, dopo aver vissuto a Roma per diversi anni, si trasferisce in Svizzera nel 2008 dove attualmente vive e lavora
Sono stati selezionati dalla redazione del mensile ARTE di Cairo Editore, diretto da Michele Bonuomo, i venti giovani artisti che parteciperanno al 21° Premio Cairo, il più autorevole appuntamento con l’arte contemporanea in Italia, voluto e sostenuto con passione e generosità dal Presidente Urbano Cairo. La mostra, che si terrà nelle prestigiose sale di Palazzo Reale a Milano, è stata posticipata al 2022, dal 17 al 23 ottobre, per permettere uno svolgimento della cerimonia di premiazione in linea con le edizioni scorse e una piena partecipazione del pubblico di appassionati.
Tra i talenti selezionati, Valentina De’Mathà, artista italo-svizzera nata ad Avezzano. Dopo aver vissuto a Roma per diversi anni, si trasferisce nella Confederazione Elvetica nel 2008, dove attualmente vive e lavora.
“Essere stata invitata ad un premio così prestigioso è sicuramente per me un’opportunità di cui sono molto grata” dice Valentina De’Mathà.
Artista multidisciplinare, spazia dalla pittura alla fotografia, alla scultura e installazioni. Una delle principali caratteristiche formali delle opere della De’Mathà è l’utilizzo di materiali della fotografia tradizionale (carte e poliesteri fotosensibili dipinti attraverso chimici fotografici) utilizzati non in modo convenzionale. Queste carte emulsionate spesso vengono intrecciate e cucite a mano dall’artista che dà vita ad arazzi/coperte, ma anche sculture morbide e mutabili che simulano la labilità e vulnerabilità della condizione umana. Corpi ripiegati su se stessi che cercano di tenere insieme i frammenti e sfaccettature della propria esistenza e dello scorrere del tempo.
La sua pratica artistica è un tentativo di cercare di fissare, simbolicamente, sulla carta emulsionata, quella materia dis-organizzata di cui fanno parte le emozioni; e l’atto di tessere, rimanda alla tradizione tessile delle coperte abruzzesi e alla volontà di tramandare (trama), di tenere insieme le cose, la famiglia, le relazioni, i ricordi, con un fare atavico e femminile.
“Vivo in Svizzera ormai da più di 10 anni, e questo, paradossalmente mi fa sentire sempre più forte il legame che ho con l’Italia e, soprattutto, con la mia terra d’origine: l’Abruzzo. È un vero piacere per me partecipare ad un premio nazionale così prestigioso e ambito” - aggiunge la De’Mathà - “La mia ricerca
artistica è un’indagine sulla perdita del controllo, sull’errore/errare, e possibilità che ne scaturiscono, e sul concetto di meraviglia. Di conseguenza sulla volontà e tentativi da parte dell’uomo di tenere insieme le cose e farle perdurare nella memoria. Un continuo alternarsi tra libero arbitrio e ineluttabilità degli eventi che caratterizzano la condizione umana.
Partendo da questi principi, per il premio ho voluto realizzare un’opera inedita, onesta e intima, una sorta di ritorno alle origini.”
La prestigiosa giuria che sarà chiamata a nominare l'opera vincitrice, al cui autore verrà assegnato il Premio
Cairo, è presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell’omonima Fondazione di Torino, ed è composta da Luca Massimo Barbero, direttore Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Mariolina Bassetti, Chairman Christie's Italia, Gabriella Belli, direttrice Fondazione MUVE - Musei Civici di Venezia, Ilaria Bonacossa, direttrice Fiera Internazionale d’Arte e Contemporanea Artissima di Torino, Lorenzo Giusti, direttore Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (Gamec) di Bergamo, Andrea Viliani, responsabile e curatore Centro di Ricerca Castello di Rivoli, ai quali si aggiunge il grande artista Emilio Isgrò.



Valentina De’Mathà, artista italo-svizzera, focalizza la sua ricerca sul concetto di connessione, di imprevedibilità degli avvenimenti derivanti dalle relazioni interpersonali, sulla meraviglia e l’inaspettato.
Ripartenza, riallineamento, ricalibrazione. Cosa significa e da dove nasce questo processo che accomuna tutti gli artisti?
Mi capita più spesso di desiderare il bordo e spingermi oltre, di mettermi in bilico e decentrarmi e poi cercare nuovamente il controllo. Non credo che sia davvero così importante calibrarsi nel centro, anzi, si rischia di stagnare e non evolversi. L'importante è farlo comunque mantenendo la disciplina. L’artista deve agire in totale libertà e follia assecondando i suoi moti, è compito del sistema dell’arte poi dare un senso più logico e concreto a certi processi. Per quanto mi riguarda, il mio centro è in continuo mutamento e volubilità. Voglio che sia così. Mi piace l’instabilità, anche nelle sue violente oscillazioni ed essere in balia della ciclicità degli eventi, se così non fosse non potrei creare e produrre. Ciò non significa che in questi ondeggiamenti io non riesca ad essere esatta nelle mie azioni o nel mio pensiero, anzi, mi sono di grande aiuto. Trovo che sia contro natura moderare o giustificare un lavoro artistico in ogni suo passo. Un’ opera d’arte ha bisogno dei suoi tempi e reagisce in funzione della percezione di chi la osserva. Tutto è molto relativo e mutevole. Credo che si debba lasciare che il lavoro sia quel che è e, semmai, essere pronti ad accettarne le sue imperfezioni. Io lavoro tutti i giorni tutto il giorno, ma ci sono dei periodi spesso lunghi in cui produco incessantemente cavalcando l’onda di un bisogno e sono totalmente assorbita in modo egoistico dal mio lavoro che mi risucchia completamente e richiede tutte le mie attenzioni ed energie. Il problema sta nel momento successivo, quando l’energia ha raggiunto il suo picco e ne consegue un vuoto devastante. Forse, proprio queste discontinuità così repentine e la capacità di sostenerle cercando di mantenere il controllo, sono la ciclicità naturale del vero equilibrio.
Nel suo percorso d’artista ha posto in essere cambiamenti di registro e passaggi da un medium artistico a un altro, ci racconta questo percorso e lo stato dell’arte della sua ricerca?
Da poco più di dieci anni la mia ricerca si è avvalsa principalmente dell’utilizzo di materiali chimici fotografici, in modo non convenzionale, cambiandone la funzionalità, ma sfruttando le loro caratteristiche e capacità e il concetto insito di fotografia. I motivi che mi hanno spinta sono molteplici, sicuramente per la loro immediatezza, per la loro mancanza di una totale prevedibilità delle reazioni chimiche e l’effetto meraviglia che ne consegue. Per la lucentezza di certi poliesteri che sommano l’ambiente circostante all’opera creando cangianti sovrapposizioni che relativizzano la fruizione del lavoro. Ma anche per il messaggio che la fotografia tradizionale, più di altre discipline, porta con sé, ovvero l’illusione di fermare un attimo e di far perdurare la memoria.
Quali sono le opere che ritiene più “riuscite”, “finite”, e quando le riconosce?
Quelle verso le quali ho un rigetto immediato, perché a distanza di tempo mi rendo conto che hanno rotto degli schemi, sono andate oltre e in quel momento io non ero preparata e non le capivo. Ma ogni lavoro ha una storia a sé. Non è detto che un’opera per essere valida e resistere nel tempo debba necessariamente suscitare in me immediate reazioni di inquietudini o al contrario, forte senso di soddisfazione. Ad esempio, nel 2014, ho realizzato una serie di lavori intitolati “Epiphany”. Ammetto che già la prima opera suscitò in me una certa esaltazione, perché ero riuscita a congiungere la parte pittorica dei miei lavori passati con quelli più recenti, ma solo a distanza di anni, adesso, ne sto davvero godendo a pieno. È una serie di lavori realizzati in camera oscura che narrano paesaggi fantastici e surreali, in una sovrapposizione di piani prospettici indefiniti che annullano la prospettiva in quanto tale, con chiazze di luce bruciata alternate a masse e frammentazioni di colore. Sono visioni oniriche, distorsioni della psiche, epifanie, stati estatici, meraviglie, déjà vu, flashback. Assecondando il più possibile questa visione, li ho realizzati in modo del tutto istintivo e gestuale, senza dare un ordine preciso alle cose, come era giusto che fosse, senza giustificare o calibrare ogni segno e prestabilire una narrazione o una lettura univoca. Ad oggi, più di prima, credo di aver centrato a pieno ciò che volevo dire. Se si analizza ogni minimo dettaglio da vicino, si possono notare un’infinità di microcosmi, di scene, di situazioni a sé che sommandosi compongono l’opera. Succede così quando si sogna, quando qualcosa ci offusca la mente, le prospettive si annullano e sovrappongono, le immagini e i loro significati si distorcono, le scene sembrano apparentemente non avere un filo logico. “Quando si sogna si smargina la causalità, si smargina il principio di non contraddizione, di spazio-tempo e si annulla il nostro Io”, dice Umberto Galimberti. Oltretutto ho notato che se capovolgessi le opere a testa in giù, il messaggio rimarrebbe sempre lo stesso, l’opera regge comunque, ma è come se si aggiungesse un’altra possibilità alla narrazione. Mi piace questa ulteriore lettura che va contro un’apparente logica.
Che cosa è la forma?
Le mie opere cambiano in continuazione ai miei occhi, ho uno sguardo piuttosto volubile ogni volta che le riguardo, sia per ciò che mi comunicano sia per l’aspetto concreto che assumono. La forma per me è un discorso sempre aperto. Faccio degli esempi. Una mia pratica quotidiana è quella di avvolgere, piegare, ammucchiare, srotolare e spostare i miei lavori. Oppure di lasciarli lì a sedimentare, così, dove li ho terminati, per giorni, a volte anni. Ho delle opere che rimangono sul tavolo dove finisco di cucirle per periodi incalcolabili o sul divano dove le ho intrecciate, sulle poltrone, sui tappeti, stratificate sui muri. Le sposto di continuo per fare spazio, per non sedermici sopra, per mostrarle, ogni volta cambiano piega e diventano altro. Per me è importante anche vedere come e dove le lascio, ripiegate in che modo, adagiate in che modo, seguendo quale ordine di stratificazione. Anche il modo e i luoghi in cui le ripongo mi sono di grande aiuto. È come se la materia trovasse la sua forma e mi suggerisse delle alternative. “#INTHESPACE”, l’installazione esposta al Macro Asilo, Macro Museo d’Arte Contemporanea di
Roma, mi venne in mente camminando intorno ai rotoli di poliestere arrotolati in camera oscura. Ho una scultura appesa alla finestra del mio studio da circa dodici anni, la luce diretta le ha fatto cambiare colore, il peso l’ha deformata, mi fu di ispirazione per “Silenzio”, l’installazione esposta al Padiglione Italia/Abruzzo alla 54esima Biennale di Venezia. Oppure, un arazzo arrotolato da due anni su una poltrona sferica di design all’ingresso di casa, ogni volta che entra qualcuno rischia di andargli contro. Quell’opera è lì da due anni, l’avevo poggiata per caso e la poltrona ne è diventata parte integrante. Spesso ci passo davanti e le cambio forma, ma non so più immaginarla senza quell’elemento sferico su cui si è sedimentata e che la completa.
A cosa sta lavorando?
Una delle mie ricerche attuali è sulla bocca, cosa simboleggia e qual è il suo ruolo nelle sue molteplici declinazioni, ma intesa soprattutto come apertura verso il mondo esterno. Da bimbi facciamo la conoscenza delle cose portandocele alla bocca. Attraverso di essa introduciamo al nostro interno il cibo, poi, invece, assume una valenza erotica quando facciamo l’esperienza dell’altro tramite il bacio, accendendo i sensi e tutte le terminazioni nervose che la caratterizzano. In qualche modo facciamo entrare, con estrema fiducia, qualcosa di sconosciuto al nostro interno. Non a caso, ho pensato che “Atti di fiducia” fosse il titolo migliore da cui partire. Ma la fiducia può essere tradita, possiamo anche essere avvelenati, in quel caso la bocca si trasforma in ferita, in ulcera oppure possiamo essere feriti a morte mirando alla gola. A nostra volta, anche l’incapacità di esprimerci o, al contrario, di ferire attraverso la comunicazione verbale o i morsi può trasformarsi in un dramma. È un atto di fiducia reciproco, sia da parte nostra che ci apriamo all’altro sia da parte dell’altro che si dà a noi senza timore di essere morso, risucchiato e poi sputato via o offeso. Ma questi accessi sono per eccellenza un’apertura verso un percorso di esperienze. La bocca si estende fino all’ano che è la sua parte terminale durante un percorso di assimilazione o possiamo far riferimento anche all’apertura della vulva, con la vischiosità dell’eccitamento, o all’utero che accoglie e genera nuova vita. Ma possono essere anche atti di iniziazione: la fuoriuscita del sangue mestruale, la rottura dell’imene e la perdita della verginità, la rottura delle acque prima del parto. Luogo da cui nasce ed emerge la vita e l’inconscio. Carnale, simbolo erotico di dipendenza sensuale. Sede del gusto, comunicatore di appetiti. Insomma, un mondo da scoprire.
Pier Paolo Scelsi
The Collector Magazine #05

Valentina De’Mathà, an Italian-Swiss artist, focuses her research on the concept of connection, on the unpredictability of events arising from interpersonal relationships, on wonder and on the unexpected.
Rebirth, realignment, recalibration. What does the process all artists share mean and where does it come from?
I often find myself looking for the edge and then going beyond it, putting myself in the balance and decentralising and then look for control again. I don’t think it’s all that important to set yourself at the centre of things as that can lead to stagnation and lack of development. The important thing is to maintain discipline. The artist must act in total freedom and madness according to his or her motion. It’s then up to the art system to give a more logical, concrete meaning to those processes. As far as I am concerned, my centre is constantly changing and fluctuating. And that’s how I like it. I like the violent swings of instability and being at the mercy of events. I couldn’t create or make anything if that weren’t the case. But this instability doesn’t mean that I am not able to be precise in my actions or thoughts - I certainly am. I find that it’s against nature to moderate or justify a piece of art at every stage of the process. An artwork needs a certain length of time and reacts according to how it is perceived. Everything is relative and changeable. I think the work has to be left to be what it is and we, if anything, must be prepared to accept it in all its imperfection. I work all day every day, but there are times when I produce incessantly, riding the wave of a need and I am totally absorbed egoistically in my work that it completely draws me in and requires all of my attention and energy. The problem comes later because this incredible high is always followed by a devastating slump. But maybe these peaks and troughs are just the natural cycle of real balance.
In your career you have been through some changes in register and artistic medium, can you tell us about this and about where your research is now?
For the last ten years or so I’ve been mostly researching the use of photographic chemicals in an unconventional way, changing their function and exploiting their characteristics and properties and the inherent concept of photography. There are a number of reasons for this. One is certainly their immediacy, the lack of predictability in the chemical reactions and the wondrous after-effects. Another is the sheen of certain polyesters, which bring the surrounding environment into the work creating iridescent overlaps that relativize the end result. And finally, the message that traditional photography, more than other disciplines, brings with it, i.e. the illusion of freezing a moment in time and making a memory last forever.
Which works do you feel are the most “successful” or “finished”, and when do you recognise them?
The ones that give me a sense of immediate refusal, because as time goes by I realise that they broke the mould somehow but at the time I wasn’t ready and didn’t understand them. But every piece of work has its own story. An artwork isn’t any more valid or can stand the test of time just because I feel unsettled or satisfied when I look at it. For example, in 2014, I created a series called “Epiphany”. I admit I was elated when I’d finished the very first piece because I had succeeded in joining the painterly style of my earlier work with more recent pieces, but it’s only now, years later, that I can fully enjoy it. It’s a series of pieces created in the darkroom that explores fantastical and surreal landscapes, overlapping indefinite perspectives that cancel out the concept of perspective by alternating burnt patches of light with colour masses and fragmentations. They are dream-like visions, distortions of the psyche, epiphanies, ecstatic states, wonders, déjà vu, flashbacks. Following this vision as much as possible, I made them in a completely instinctive and gestural way, without giving a precise order to things, which was the right thing to do, without justifying or calibrating each sign and prearranging a narrative. I think I have now managed to nail down what I wanted to say, more than before. If you analyse every little detail up close, you notice an infinite number of separate microcosms, scenes and situations that, added together, comprise the work. This is what happens when you dream, when something clouds our mind, perspectives are cancelled out and overlap one another, images and their meanings are distorted, scenes look as though they don’t tie together logically. “When you dream you lose causality, you lose the principle of non-contradiction, of space-time and you lose ego,” says Umberto Galimberti. I also noticed that if I tipped the works upside down, the message stayed the same, the work would still stand, but another possibility was added to the narrative. I like this aspect, even though it goes against apparent logic.
What is form?
My work changes all the time in my eyes. I have a rather fickle way of seeing it and I see different things and get different messages each time. Form to me is always an open discussion. I’ll give you some examples. My daily practice is to cover, fold, pile up, unroll and move my works. Other times, I just leave them to sit for days, or sometimes years. I have pieces left for ages on my table where I finish stitching them or on the sofa where I’ve woven them, on chairs, rugs, stacked up against the wall. I move them around to make space, so that I don’t sit on them or to exhibit them, and each time they change a little and become something else. For me it’s important to see how and where I leave them, the way I’ve folded or put them down, how I’ve ordered them. How and where I have put them is really helpful to me. It’s as though the material is finding its own form and suggesting alternatives to me. “#INTHESPACE”, the installation exhibited at Macro Asilo at Rome’s Macro Museum of Contemporary Art, came to me while I was walking around the rolls of polyester in the darkroom. I have had a sculpture hanging in the window of my studio for so long, about twelve years, that the light has changed its colour and the weight has deformed it. But it provided the inspiration for “Silenzio”, the installation exhibited in the Italy/Abruzzo section of the 54th Venice Biennale. Another example is a rolled up tapestry that’s been on a spherical designer armchair in my hallway for two years. Every time someone comes in they risk bumping into it. It’s been there for two years. I only put it there by chance, but it’s become part of the armchair now When I walk past it, I often change it a little bit, but I can’t imagine it now without that spherical shape underneath it.
What are you currently working on?
I’ve been doing some research into the mouth, what it means and what role it plays, but especially into the aspect of it being an opening to the outside world. As babies, we learn about things by putting them in our mouth. It’s how we feed ourselves and it also has erotic connotations because of kissing, the senses and all the nerve endings that it has. In some way, it’s about having the trust to put something from the outside into ourselves. That’s why I thought “Acts of faith” was the best title to start with. But trust can be broken, we can also be poisoned and in that case the mouth is turned into a kind of injury, an ulcer or we can be mortally wounded by aiming for the throat. We can also be incapable of expressing ourselves, or even hurt someone with words or by physically biting them. It’s a reciprocal act of faith, on our part opening ourselves up to the other and, conversely, the other giving themselves up to us without fear of being bitten, sucked in and then spat out or offended. But these accesses are a way of being open to new experiences. The mouth extends through assimilation to the anus, or to the vulva, to the wetness of arousal, or to the womb where new life grows. Acts of initiation also come into play here: menstrual blood, the hymen breaking and the loss of virginity, the waters breaking before birth. The place where life and the unconscious are born and emerge. A carnal, erotic symbol of sensual dependency. It is the seat of taste, the communicator of appetites. In short, a whole world to be discovered.
Pier Paolo Scelsi
The Collector Magazine #05
VALENTINA
DE’MATHÀ
Studio Visit Online
Hestetika Magazine
 https://www.youtube.com/watch?v=XaL4Wv7JvFM
https://www.youtube.com/watch?v=XaL4Wv7JvFM
......................................................
 Pasinger Fabrik
Pasinger FabrikMediterran
Das Mittelmeer als Brücke und Kluft zwischen den Kulturen gestern und heute
Ein Ausstellungs- und Diskussionsprojekt
Kuratoren: Luigi Viola und Thomas Linsmayer
Culture and civilization are born of compa- rison, of dialectical visions, of interpersonal exchanges and relationships.
Just from its ancient history Mediterranean Sea linked civilizations and peoples, marking their evolution through the encounter and the contamination between different traditions, religions and cultures that have been enriched and turned into something else.
Everything through interaction and mutual comparison.
The artistic technique I used for this artwork starts from this vision: I took emulsified papers and folded them into spirals to symbolize the DNA structure, then I painted them in the dar- kroom where all the aesthetic effects are reve- aled through the free interactions of chemical processes.
Then I unfolded them, creating another form that would bring with it the signs of the starting structure.
Through the folds of the spiral, the action of chemical agents has given rise to a kaleidosco- pic succession of anthropomorphic, primitive and alien faces, in a dreamlike and ancestral dimension composed of elements that are always new, often completely symmetrical, sometimes the negative of the other, but always generated from the contact and the interaction of two flaps.
Valentina De’Mathà
#INTHESPACE
 https://www.youtube.com/watch?v=31eSJg-xhV0
https://www.youtube.com/watch?v=31eSJg-xhV0
......................................................

Vol 36. Gennaio 2020



SPAZIO
Lo scorso ottobre ho inaugurato un progetto installativo al Macro Asilo, Macro Museo d’Arte Contemporanea di Roma, intitolato #INTHESPACE. Il progetto è nato da una riflessione sulla complessità e sul disordine della realtà narrati ne “Le città invisibili” di Italo Calvino, e sui grafi, che sono delle strutture relazionali e organizzazione dati che troviamo nella vita quotidiana e nella comunicazione virtuale. Quello che mi interessava era volgere poi, di conseguenza, l’attenzione sul modo di esprimersi della società di oggi attraverso principalmente i social network, sul concetto di spazio/luogo e sulle relazioni interpersonali. Attraverso la globablizzazione, le migrazioni di massa, e internet, c’è stato l’abbattimento di molte barriere con tutti i pro e i contro che ne sono susseguiti. I luoghi, i nostri spazi, sono il punto in cui viviamo e comunichiamo e, al giorno d’oggi, attraverso internet, possiamo avere costantemente una vita collettiva e pubblica ovunque ci troviamo; i confini sono diventati fluidi e relativi più che mai. L’installazione comprendeva una serie di poliesteri emulsionati che ho dipinto in camera oscura attraverso chimici fotografici e che poi ho arrotolato su se stessi creando simbolicamente delle bocche; all’interno poi ho posto degli specchi che, illuminandoli, creavano immagini caleidoscopiche irripetibili. La bocca è per antonomasia lo strumento che utilizziamo per la comunicazione verbale, ma può essere anche un mezzo attraverso cui guardare all'interno e lasciarsi sorprendere e accogliere. Si dice “rimanere a bocca aperta”, quando si prova meraviglia. Se pensiamo anche solo a ciò che introduciamo al suo interno, o al bacio con cui ci doniamo e accogliamo, sono atti di fiducia. Attraverso la bocca concediamo noi stessi all'altro, lo facciamo entrare a contatto con la parte più intima che abbiamo, il nostro interno, e, di rimando, noi facciamo la scoperta e la conoscenza dell’altro attraverso i sensi che ci pervadono grazie a questo varco. Le aperture sono un atto di amore e di fiducia. L'etimologia della parola "spazio", viene da Spatium, ovvero "essere aperto”. I poliesteri che ho utilizzato, sono levigati, perfettamente lisci, è un materiale asettico, inorganico, io ho voluto crearci sopra delle incisioni, delle sfumature, dei cambi di direzione, a simboleggiare le reti sociali e la frammentazione dell’individuo attraverso le scomposizioni indette da una realtà dei fatti sempre più distorta, e dalla raccolta dati che, volontariamente e involontariamente, forniamo nel quotidiano. Queste superfici riprendono proprio la levigatezza degli schermi luminosi su cui siamo abituati a comunicare nei giorni d’oggi: quelli dei pc e quelli degli smartphone. Questi ultimi, funzionano proprio attraverso il tatto, accarezzandoli, toccandoli, premendoci sopra. Ma sono asettici, non hanno calore umano, né odore. Ormai la comunicazione è quasi esclusivamente questa: a distanza e illusoria. Il messaggio era quello di utilizzare questi apparecchi cercando di andare a fondo, di non fermarsi alle apparenze, ma di prendersi il giusto tempo per conoscere e scoprire ciò che si nasconde all'interno delle cose e di lasciarsi meravigliare. L’installazione è stata ospitata nella Black Room del museo e, il mio intento è stato quello di portare il visitatore, in maniera naturale, ad utilizzare la luce del proprio smartphone per illuminare l’interno di questi cilindri. Il passo successivo è stato quello di realizzare una rete sociale postando le immagini e video realizzati attraverso la propria esperienza, sui principali social network con l’hashtag #INTHESPACE.
RIFLESSI
Molti dei miei lavori riflettono l’ambiente circostante, tutto si somma fino a diventare una forma altra. Sono opere dinamiche e cangianti, fluide. Mutano in base alla luce e all’ambiente che le ospita, anche il fruitore che le osserva si somma ad esse, le caratterizza e relativizza. Uso spesso materiali lucidi perché non sono mai definibili fino in fondo, ma aumentano la soggettività della percezione.
Viviamo di riflessi, ci specchiamo ovunque, la nostra immagine è sempre diversa, frammentata, parziale. Se pensiamo a quando camminiamo per strada, ad esempio, la nostra figura si moltiplica specchiandosi ovunque: nelle vetrine dei negozi, negli specchietti delle vetture, nei finestrini delle auto che passano... Ovunque ci sono occhi che ci guardano e ognuno vede cose di noi sempre diverse, continue sfaccettature e tasselli della nostra personalità. Anche quando ci specchiamo immobili a figura intera, diventa sempre tutto relativo perché lo specchio ritrae solo una porzione di noi, ritrae anche il fondo dell’ambiente, ritrae noi come siamo in quel preciso momento, con quella luce, ma anche solo respirando, la nostra immagine è in ogni istante inesorabilmente diversa.
Ad esempio, nella mia serie di lavori Se puoi guardare fuori, gli altri possono guardare all’interno, ho simulato delle vetrate a simboleggiare l'assenza di segreti e misteri. Il vetro frantumato scompone la nostra interezza, la frammenta, tutti possono guardarla a porzioni, ma non c'è mai una rivelazione totale della nostra intimità, anche quando viene violata. È un guardarsi a vicenda, ognuno con la propria percezione.
CORPI
Il corpo è il mezzo attraverso cui percepiamo e misuriamo il mondo. Come scrive Umberto Galimberti, “Non si accede al mondo se non percorrendo quello spazio che il corpo dispiega intorno a sé nella forma della prossimità o della distanza delle cose”. Io sono una donna molto fisica, tattile e olfattiva, e nel mio lavoro questa fisicità è sempre evidente in un modo o nell’altro, anche quando il corpo non è esplicitamente rappresentato. In Stretch Marks ad esempio, volevo parlare dei segni sulla pelle con cui convivo dall’adolescenza e di come continuano a mutare nella narrazione del mio stare al mondo. Nello specifico volevo parlare di smagliature, di linee, solchi e fratture, come anelli di un albero. Volevo parlare di come la pelle possa cambiare in base ad uno stress fisico, ormonale, in base all’alimentazione, alla luce, alla crescita o aumento e diminuzione improvvisa di peso; insomma, a quei cambiamenti improvvisi e inevitabili che tutti, in un modo o nell’altro, subiamo grazie allo svolgersi degli eventi. Quindi ho utilizzato delle carte emulsionate vergini, che sono poi sbiadite e hanno cambiato colore nel tempo in base a fattori esterni, come la luce.
SIMBIOSI
Vivo circondata da libri e opere in costruzione: sul tavolo della cucina, sul divano in biblioteca, sulla poltrona, sul pavimento della camera da letto, in studio, sul tappeto, in borsa. Ho bisogno di leggere e lavorare ovunque mi sposti, altrimenti mi sembra di aver buttato via il tempo, anche se si tratta solo di cinque minuti. Questi elementi si sommano alle opere avvolte su se stesse. Credo di avere addirittura migliaia di lavori arrotolati, impilati, archiviati, dimenticati o sbagliati. Avvolgerli mi viene naturale, è una pratica e una visione quotidiana. Paradossalmente alcuni lavori credo che abbiamo più forza quando sono appena imbastiti o chini su se stessi, credo che abbiano un senso e una naturalezza maggiore anziché dispiegati, e credo che suscitino maggiore rispetto durante la contemplazione. Nella realtà nessuno si rivela totalmente, tutti tuteliamo e proteggiamo parti del nostro vissuto che è comunque in continuo divenire. Quando li termino e li apro la narrazione viene rivelata totalmente, quasi in modo pornografico, senza misteri, un po’ come quello che stiamo vivendo oggi attraverso internet: è lì, tutti possono prendersi il proprio tempo per “leggerla”, ma quando sono arrotolati hanno un senso, non più misterioso, ma forse più umano. Penso che nella loro sedimentazione, abbiano una loro maggiore dignità.
FLUSSI
Quando cucio i miei arazzi, i nodi mi fanno perdere un sacco di tempo, anche se ammetto che sono un modo in più per stare china su me stessa a elaborare nuove idee mentre con ostinazione li sciolgo. Del resto anch’essi fanno parte della metafora della narrazione.
Fortunatamente c’è la cera d’api che li districa, tutela il filo e lo fa scorrere più velocemente.
La storia dei miei arazzi è un discorso in divenire. Taglio la carta, la intreccio, la dipingo in camera oscura, la passo al fissaggio, la riassemblo e poi la cucio a mano. È un rito, un mantra. Alcuni di questi lavori hanno una storia lunga anni. A volte li lascio lì, arrotolati, e me ne dimentico, poi li riprendo e il flusso continua a scorrere con idee diverse, diventando altro.
Posso affermare che hanno davvero un vissuto, alcune di queste opere occupano superfici del mio studio e della mia casa anche per anni, a volte sono come un libro importante che non vedi l’ora di scoprire come va a finire, ma nello stesso tempo, vorresti che non finisse mai perché i personaggi sono entrati a far parte della tua quotidianità. Tutto ciò che mi passa nella mente, è intrecciato e cucito lì. Sono contenitori di segreti indicibili. Mi siedo per ore, passando da una sedia all’altra, non accorgendomi che è già sera, spesse volte mi scopro a cucire al buio senza rendermi conto che il tempo si è dilatato in un alternarsi di sedie, pensieri e cambi di filo.
DIGRESSIONE
Mi piace molto la parola errore, perché viene da errare, vagare, perdersi.
I miei lavori sono pieni di errori. È sempre importante trovarsi dove non ci si aspettava.
CONFINE
Da più di 11 anni vivo in Svizzera, un luogo non luogo al centro dell’Europa benché non ne faccia parte. È un posto a sé, con le sue leggi e il suo modo di stare alle regole e di calcolare le cose con precisione. Questa nuova cultura ha influenzato enormemente la mia quotidianità e ha in qualche modo condizionato il mio modo di vivere. Di conseguenza il mio lavoro è diventato molto più asciutto e lineare, più pulito e ordinato, insomma, continua a vivere con coerente simbiosi ancorato a me. Faccio ancora un po’ fatica a stare dentro i limiti, ad organizzare meticolosamente tutto, ad essere più ordinata e sintetica, anche se a volte sembra che mi riesca bene, ma mi rendo conto ogni giorno che è contro la mia natura. Vivo costantemente in contrasto con ciò che sono e ciò che cerca di contenermi, di schematizzarmi. Io stessa tento di tenere a bada il mio lavoro, di dargli un ordine, anche se in realtà, vorrei che urlasse fuori in una serie di esplosioni. Non ho ancora capito perché io stessa continui a pormi tutti questi limiti. Ma una bestia rimane pur sempre una bestia, anche se ha imparato a stare composta e ritta su due zampe.
AMORE
Un discorso troppo complicato, intimo e segreto. Ma anche estremamente facile.
PAROLE
Le uniche parole che contino sono i fatti.
Tutte le frasi che finiscono con un “ma” o con un “forse”, sono prive di valore.
ELUCUBRAZIONE
Noi siamo processi in divenire. Tutto ciò che progredisce e si muove è vivo, tutto ciò che si ferma è morto. Questo è insito nella natura dell'uomo, eppure, paradossalmente, cerchiamo sempre di fermare il flusso delle cose: il tempo, un attimo felice, un addio, i nostri figli che vorremmo che rimanessero sempre cuccioli da accudire e stringere a noi. Anche per questo motivo scattiamo milioni di fotografie.
Ammetto che mi hanno sempre affascinato e terrorizzato l'imprevedibilità e la mutevolezza degli eventi e di come ciò influenzi gli stati d'animo delle persone, o viceversa, di come le volubilità emotive delle persone, cambino lo stato degli eventi.
Mi ha sempre affascinato e terrorizzato vedere come qualcosa che appare ai miei occhi in un modo, attraverso gli occhi di un'altra persona appaia con un significato totalmente diverso.
Io sono una donna molto concreta, credo fortemente nel potere decisionale di ogni individuo, nella sua volontà di andare per la strada che ha deciso di percorrere e di prendere ciò che vuole. Diciamo che non sono una donna che aspetta la provvidenza. Per me tutto è possibile e fattibile. Ma è anche vero che esistono dei meccanismi non deterministici, come vengono definiti dalla fisica quantistica, che non si possono controllare, avvengono e basta. Da qui l’utilizzo di materiali sui quali non posso avere del tutto in controllo. Da qui anche la volontà di creare sempre “forme altre”, opere che sono concepite in un modo, ma che possono diventare altro.
Ho sempre lavorato a strati: nella pittura, nelle sculture in papier-mâcché, con i chimici in camera oscura. Mi ha sempre affascinato la stratificazione degli eventi e della storia. Il nostro vissuto è un accumulo di cose a strati, dai vestiti che portiamo addosso, ai primi pavimenti, costruiti come atto di civilizzazione, ai mosaici, ai sampietrini, al cemento, alle resine, e poi i piani delle case, i tappeti, i tavoli sopra i tappeti, i libri sopra i tavoli, le tazze di tè sopra i libri, la polvere e così via.
In camera oscura lavoro per sovrapposizioni di chimici, di acqua e di luce, il mio intento è quello di fermare un processo, un istante, proprio come fa la fotografia tradizionale, ma io cerco di fermare un attimo astratto. Questa, ovviamente, è solo un’illusione, una possibilità che mi concedo. Io cerco di fermare un attimo per paure che vada via, ma sono felice di non riuscirci e che quell’attimo si sia già trasformato in questo preciso istante in qualcos’altro. Così come succede nelle relazioni interpersonali.
VALENTINA
Non posso dirlo, credo che nessuno mi abbia ancora intuita realmente. Lo lascio fare a chi avrà coraggio e la giusta cura e attenzione.
Marco De Crescenzo
Hestetika Magazine
Vol.36
gennaio 2020

VALENTINA DE'MATHÀ
#INTHESPACE
Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma
#INTHESPACE
Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma
1st - 3rd October 2019
The #INTHESPACE project arises from a reflection on the complexity and disorder of reality narrated in Italo Calvino’s "Invisible cities" - tales of imaginary and paradigmatic places that intersect and project themselves into contemporary society, where everything is seemingly "smooth”. In reality this smoothness often conceals an endless and shapeless decay. Another element of reflection are the graphs: relational structures and data organization found in everyday life and in virtual communication [from the Latin term communico = to put things in common, to make one feel part of something]; thus, paying attention to how today’s society expresses itself, to cultural exchanges, to interpersonal relationships, to the concept of space/ “place”, and to the stratification of great events and history.
The human being has always been torn between the desire to settle and put down strong roots, and that of turning elsewhere in a constant search for new motivation. According to the ancient Greeks, a city begins just beyond the walls of our own home, where our lives become accessible to all. Places are where we live and communicate and, today, we do no longer necessarily feel the need to get out of them: through the internet and social networks we can continuously and everywhere have a Community life; borders become fluid and relative more than ever before.
The reflections and the shine of the emulsified polyesters used for this installation project are, indeed, through a careful analysis by Korean philosopher Byung-Chul Han on today's society, a reference to the glossy and smooth smartphones screens through which we are used to communicate. The intersections of the incisions made on these surfaces symbolize social networks and the fragmentation of the individual through breakdowns proclaimed by an increasingly distorted reality, and from the data collection that, voluntarily and involuntarily, we provide in daily life. But these "invisible cities" as Italo Calvino explains "are also an investigation of the secret reasons that lead humans to live in certain places, beyond all crises. Cities are a collection of many things: remembrance, desires, signs of a language; places of exchange, not only of goods, but also of words, wishes and memories”.
The next step to the realization of these maps, "impossible cities", "nonplaces", in the sense and vision of Marc Augè, pavements, geopolitical borders, neuronal connections ... is to make them three-dimensional by wrapping them on themselves to create another shape: casings of experiences, and mouths, symbol par-excellence from which emerges verbal communication; but also, the medium through which one can let oneself be surprised by its content by looking inside.

These mouths / cylinders / trees will symbolically become a forest, element of obvious reference to the return to the most intimate human nature, a place where the viewer can explore and experience the work by projecting its gaze inside each "trunk", instead of remaining on the surface and wander in the dark.
The installation will be set in the Black Room of Macro museum. The semi darkness of the room will bring visitors to use the light of their smartphone flashlight: the physical extension from which we have become inseparable. In this regard, the intent is to invite the visitor to create a new social network, taking photographs and videos at these "openings", equipped with flash and posting the images on the various social networks, with the hashtag #INTHESPACE.
Spàzio s. m. [from lat. spatium, perhaps der. of patēre «to be open»]
Critical essays by
Pier Paolo Scelsi - Director GAD, Giudecca Art District, Venice
Ignazio Licata - Theoretical physicist Isem, Palermo (Italy) e RIIAM, Iran
1st 2nd October 2019 from 10:00 to 20:00
3rd October from 10:00 to 18:00
Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Black Room
Via Nizza 138 Rome
Free admission
Macro Asilo-Museo Macro
Museo d’Arte Contemporanea di Roma
IL SOGNO DI BORGES
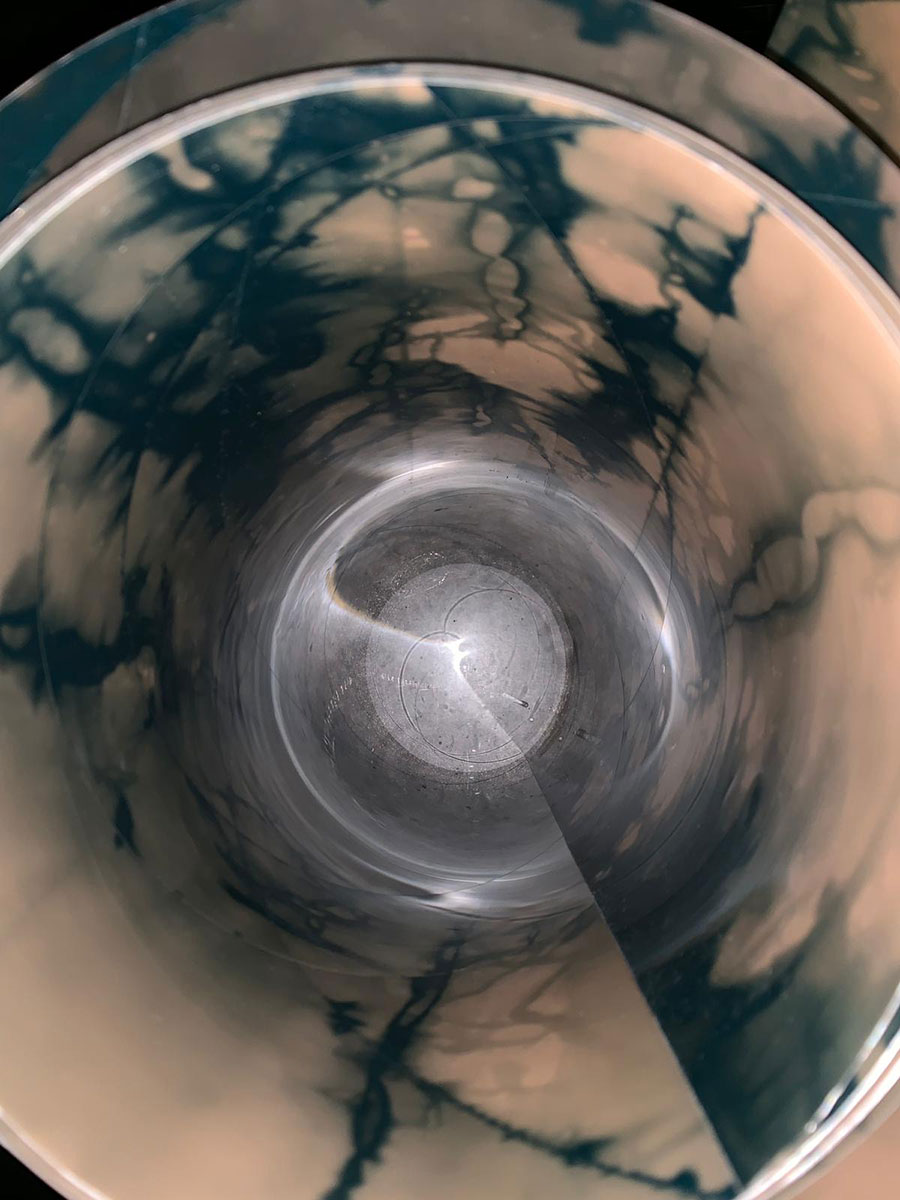
Il lavoro di Valentina De’Mathà è sempre stato caratterizzato da due direttrici complementari che guidano la costruzione delle forme. Da una parte c’è un’attitudine istintuale, la necessità e l’urgenza fisica di avere un rapporto sensibile con superfici e colori attraverso un’immersione gioiosa e caotica, una fase di simbiosi preverbale, quasi selvaggia, con la propria produzione. Sull’altro versante una natura concettuale e sottilmente analitica, attenta alla forma delle idee, ed alla loro universalità. Queste due curve tratteggiano lo spazio dell’opera, sono forze concorrenti che uniscono l’intuizione dell’artista medium con il suo lato sottilmente speculativo. #INTHESPACE, in una galleria ideale della sua storia, è il lavoro che intercetta tutte le esperienze precedenti, le pone in prospettiva, crea attorno a loro un labirinto. È la città invisibile della sua opera, la proiezione del suo metodo in forma d’arte, quasi un paradosso di sapore russelliano sul filo dell’appartenenza.
Si tratta di una riflessione sulla costruzione dei saperi, radicata fin nell' esperienza e nel concetto di “spazio fisico”, quello da noi quasi inconsapevolmente abitato e percorso, con la sua apparente semplicità di contenitore levigato in una tridimensionalità passiva di coordinate. Come sempre, le “semplicità” rivelano ad ogni tentativo d’indagine, una complessità vertiginosa. Dalla disputa tra Newton e Leibniz sullo spazio assoluto contro uno spazio relazionale definito dai rapporti tra le cose materiali, fino alle arditezze delle fisica quantistica, abbiamo imparato che lo spazio è prodotto dalle dinamiche sottili del mondo. Non è un caso se il pensiero di Leibniz è una delle più alte espressioni del Barocco, tutto teso a stipare ogni vuoto possibile di ideogrammi cinesi, monadi, macchine logiche. Ma è forse Cartesio ad aver fatto il passo decisivo con le sue architetture di coordinate. Come dirlo, questo spazio? Mentre pregava la Madonna di dargli segni della sostanza ontologica del mondo, osservando una mosca tra le pareti della stanza, Cartesio ci rivela che ogni conoscenza è costruzione di relazioni. La conoscenza non è mai conoscenza del mondo “in sé e per sé”, ma tessitura di rappresentazioni, reti di relazioni entangled, labirinti, modelli, mappe e dizionari. Ed ogni mappa è una prospettiva dell’osservatore che svela nella misura in cui costruisce. E’ questa la lezione ultima della complessità: non abbiamo l’occhio di Dio, siamo osservatori e costruttori, Il reale ci si rivela facendo resistenza alle nostre rappresentazioni. Diremmo che il reale è questa cosa tra noi e i modelli. Il valore di una rappresentazione o di un modello consiste proprio nel non essere isomorfo al territorio, ma piuttosto nel fornire un territorio. Per i punti del mondo passano infinite mappe.
Non è soltanto lo spazio dei saperi condivisi a scaturire dal rapporto relazionale e dialogico tra noi e l’indefinita ricchezza del mondo. Anche le storie personali passano per stratificazioni di mappe legate a contesti, periodi, scale: giochi di bambini, baci apposti in calce a lettere, tribù musicali, partiti politici, abitudini di consumo, pratiche artigianali, comunicazioni, transazioni finanziarie ad alta frequenza, identità plurali. La mente umana è un groviglio di mappe entangled scritto sui fogli volanti del labirinto neuronale.

Le bocche/colonne/alberi di poliesteri emulsionati di Valentina sono una foresta di mappe, un intrico di segni che vanno illuminati per rivelare parte dei loro tesori. Sempre assolutamente contemporanea, anche quando tratta i temi arcaici del sesso- corpo- sangue, la De’Mathà si rivela in questo lavoro sempre più vicina alle Lezioni Americane di Calvino. In equilibrio tra fiamma e cristallo, sceglie il tratto più breve per la leggerezza- rapidità-esattezza, visibilità e molteplicità. Riconoscendo all’Arte la sua dimensione relazionale, il suo ruolo di codice per decrittatori delle risonanze estetiche, si può pensare che nell’occhio di una di quelle emulsioni si possa vedere l’intero suo percorso, dalle mappe organiche ai misteriosi legacci della non località. L’artista è un sistema che si auto-osserva.
Ed è sulla “consistenza” incompiuta di Calvino che Valentina De’Mathà evita la trappola ontologica. Ogni rappresentazione infatti definisce un confine, un luogo altro da sé, un esterno che fissa i limiti di validità di quella specifica descrizione. I confini possono essere chiusi, aperti, più spesso sono porosi. Ci si chiede se questa porosità nella foresta di bocche/colonne/alberi possa essere la chiave per realizzare la mappa delle mappe, quella che le contiene tutte e che si può mettere in corrispondenza 1/1 con il mondo, e dire finalmente: “questo è il mondo, chiuso nei miei modelli”. Il punto d’accesso all’Aleph, il sogno di Borges. Ma l’arte è un fatto creaturale ed umanissimo, la foresta resta foresta, e il mondo inesauribile. La sua unità e consistenza reali risiedono nell’osservatore, nello sforzo certosino del suo essere costruttore e del decifratore. E’ nel gesto dell’arte la verità silenziosa delle cose.
di Ignazio Licata

VALENTINA DE'MATHÀ
#INTHESPACE
Macro Asilo-Museo Macro Museo d’Arte Contemporanea di Roma
01-03 Ottobre 2019

Il progetto #INTHESPACE nasce da una riflessione sulla complessità e sul disordine della realtà narrati ne “Le città invisibili” di Italo Calvino, i cui racconti di luoghi immaginari e paradigmatici si intersecano e si proiettano nella società contemporanea, dove tutto sembra apparentemente “levigato”, ma che in realtà, questa levigatezza, spesso cela disfacimenti senza fine né forma. Altro elemento di riflessione sono i grafi: strutture relazionali e organizzazione dati che troviamo nella vita quotidiana e nella comunicazione virtuale [dal latino communico = mettere in comune, far partecipe]; volgendo, di conseguenza, l’attenzione sul modo di esprimersi della società di oggi, gli scambi culturali, le relazioni interpersonali, il concetto di spazio/luogo e stratificazione degli eventi e della storia.
L’uomo è sempre stato diviso dal desiderio di stabilirsi e mettere radici, e quello di volgersi altrove per trovare stimoli sempre nuovi.
I Greci dicevano che la città inizia appena fuori dalle mura della nostra casa, dove la nostra vita diventa pubblica. I luoghi sono il punto in cui viviamo e comunichiamo e, al giorno d’oggi, non abbiamo più necessariamente bisogno di uscire fuori: attraverso internet e i social network, possiamo avere costantemente una vita collettiva ovunque ci troviamo; i confini diventano fluidi e relativi più che mai.
I riflessi e la lucentezza dei poliesteri emulsionati utilizzati per questo progetto installativo, sono, appunto, attraverso un’attenta analisi del filosofo coreano Byung-Chul Han sulla società di oggi, un rimando agli schermi lucidi e levigati degli smartphone attraverso i quali siamo abituati a comunicare.
Le intersezioni delle incisioni praticate su queste superfici, stanno a simboleggiare le reti sociali e la frammentazione dell’individuo attraverso le scomposizioni indette da una realtà dei fatti sempre più distorta, e dalla raccolta dati che, volontariamente e involontariamente, forniamo nel quotidiano.Ma queste “città invisibili” come spiega Italo Calvino “ sono anche un’indagine alle ragioni segrete che portano gli uomini a vivere certi luoghi, al di là di tutte le crisi. Le città sono un insieme di tante cose: memoria, desideri, segni di un linguaggio; luoghi di scambio, non soltanto di merci, ma anche di parole, desideri e ricordi”.
L’uomo è sempre stato diviso dal desiderio di stabilirsi e mettere radici, e quello di volgersi altrove per trovare stimoli sempre nuovi.
I Greci dicevano che la città inizia appena fuori dalle mura della nostra casa, dove la nostra vita diventa pubblica. I luoghi sono il punto in cui viviamo e comunichiamo e, al giorno d’oggi, non abbiamo più necessariamente bisogno di uscire fuori: attraverso internet e i social network, possiamo avere costantemente una vita collettiva ovunque ci troviamo; i confini diventano fluidi e relativi più che mai.
I riflessi e la lucentezza dei poliesteri emulsionati utilizzati per questo progetto installativo, sono, appunto, attraverso un’attenta analisi del filosofo coreano Byung-Chul Han sulla società di oggi, un rimando agli schermi lucidi e levigati degli smartphone attraverso i quali siamo abituati a comunicare.
Le intersezioni delle incisioni praticate su queste superfici, stanno a simboleggiare le reti sociali e la frammentazione dell’individuo attraverso le scomposizioni indette da una realtà dei fatti sempre più distorta, e dalla raccolta dati che, volontariamente e involontariamente, forniamo nel quotidiano.Ma queste “città invisibili” come spiega Italo Calvino “ sono anche un’indagine alle ragioni segrete che portano gli uomini a vivere certi luoghi, al di là di tutte le crisi. Le città sono un insieme di tante cose: memoria, desideri, segni di un linguaggio; luoghi di scambio, non soltanto di merci, ma anche di parole, desideri e ricordi”.
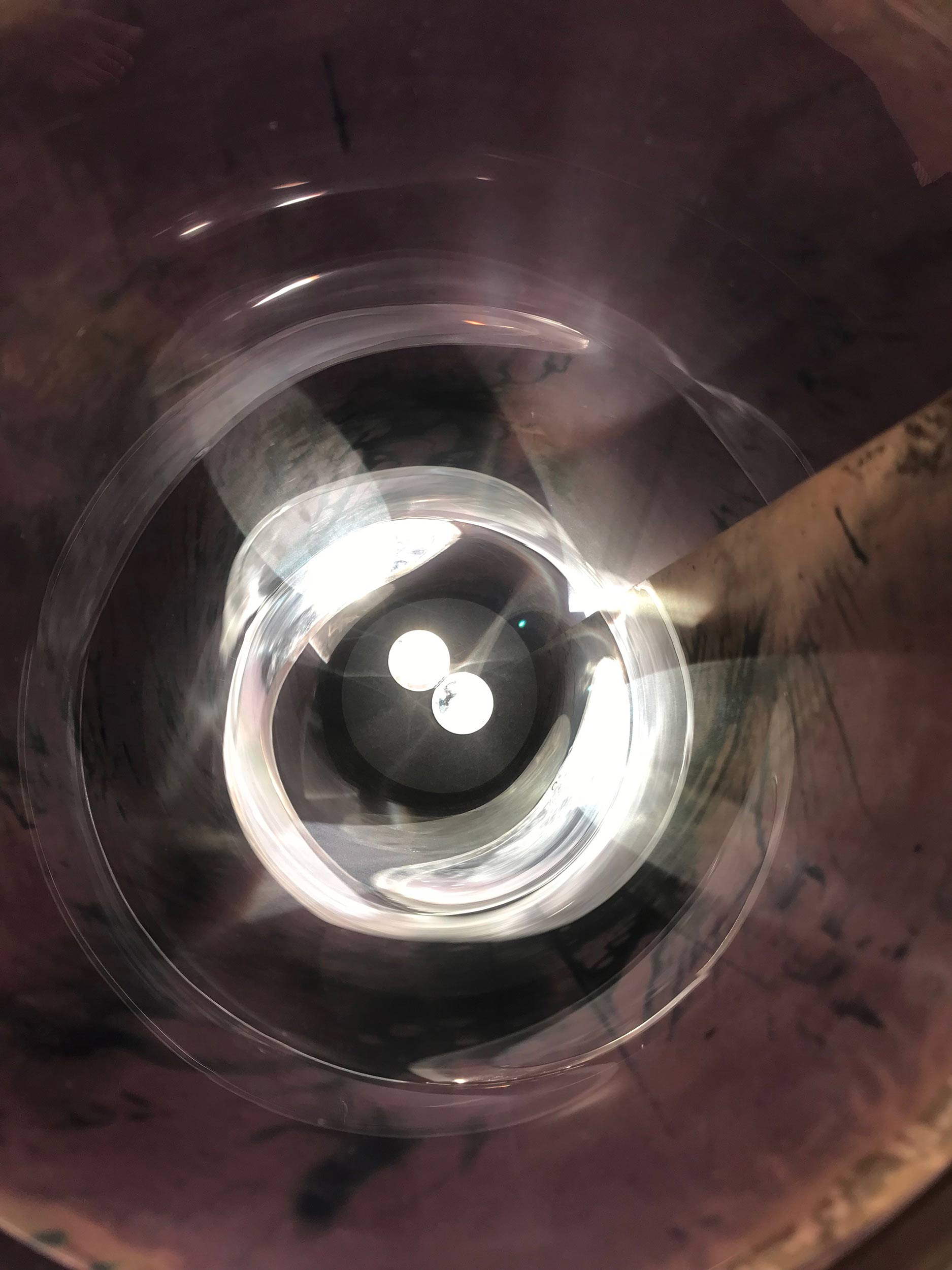
Il passo successivo alla realizzazione di queste mappe, “città impossibili”, “nonluoghi”, nell'accezione e nella visione di Marc Augè, pavimentazioni, confini geopolitici, collegamenti neuronali.... è stato quello di renderle tridimensionali avvolgendole su se stesse fino a creare una forma altra: involucri di esperienze vissute, e bocche, simbolo per antonomasia dal quale fuoriesce la comunicazione verbale; ma anche mezzo di apertura attraverso cui ci si può lasciare sorprendere dal suo contenuto guardando all’interno.
Queste bocche/colonne/alberi andranno a formare simbolicamente un bosco, elemento di evidente rimando ad un ritorno alla natura umana più intima, logo dove lo spettatore può esplorare ed esperire l'opera proiettando il suo sguardo all’interno di ogni “cilindro”, anziché rimanere in superficie e vagare nel buio.
L’installazione verrà ospitata nella Black Room del Museo Macro e, questo stato di penombra, porterà il visitatore, in maniera naturale, all’utilizzo della luce del proprio smartphone: estensione fisica ormai inscindibile da noi. A tal proposito, l’ intento è quello di invitare il fruitore a creare una nuova rete sociale, scattando fotografie e video a queste “aperture”, munito di flash e postando le immagini sui vari social network, con l’hashtag #INTHESPACE.
Spàzio s. m. [dal lat. spatium, forse der. di patēre «essere aperto»]
Con testi critici di
Pier Paolo Scelsi - Direttore GAD, Giudecca Art District, Venezia
Ignazio Licata - Fisico teorico presso Isem, Palermo (Italia) e RIIAM, Iran
01.02 Ottobre 2019 Ore 10:00 - 20:00
03 Ottobre ore 10:00 - 18:00
Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Black Room
Via Nizza 138 Roma
Ingresso Libero
Pier Paolo Scelsi - Direttore GAD, Giudecca Art District, Venezia
Ignazio Licata - Fisico teorico presso Isem, Palermo (Italia) e RIIAM, Iran
01.02 Ottobre 2019 Ore 10:00 - 20:00
03 Ottobre ore 10:00 - 18:00
Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Black Room
Via Nizza 138 Roma
Ingresso Libero
Zephyr and Maize
Studio Visit with VALENTINA
DE'MATHÀ
Curated and written by Varia Serova
Valentina De’Mathà, an Italian-Swiss artist, focuses her research on the concept of connection, on the unpredictability of events arising from interpersonal relationships, on wonder and the unexpected. Curator and art critic Varia Serova visited Valentina De’Mathà's studio in Switzerland to learn more about the artist's interdisciplinary practice, creative world and sources of inspiration.
![]()


in the balance and decentralising and then looking for control again."
- Valentina De’Mathà
Valentina De’Mathà (born 1981 in Avezzano, Italy) lives and works in Switzerland. Her artistic focus is on the interaction among man and nature, on the causality principle and the dialectic inquiry into metaphysical contradictions and their solutions, while her unique processes interconnect with non-deterministic mechanisms and the uncertainty of quantum mechanics. De’Mathà's artistic research is centred in human behaviour in moments of unpredictability of inescapable circumstances, focusing on the sentiments of emotional instability and loss of equilibrium.
In her own words, Valentina De’Mathà enjoys working with materials beyond her control, would it be painting, weaving or photography, all constituents of her multilayered experimental practice. While the artworks that De’Mathà creates usually reflect her personal experiences, from emotions coming from human interactions to life processes and parts of the human body, she also finds her inspiration in the fleeting, seemingly incidental, fragile things in the natural world: "I’ve been doing some research into the mouth, what it means and what role it plays, but especially into the aspect of it being an opening to the outside world. As babies, we learn about things by putting them in our mouth. It’s how we feed ourselves, and it also has erotic connotations because of kissing, the senses and all the nerve endings that it has. In some way, it’s about having the trust to put something from the outside into ourselves [...] The place where life and the unconscious are born and emerge. A carnal, erotic symbol of sensual dependency. It is the seat of taste, the communicator of appetites. In short, a whole world to be discovered."

Valentina De'Mathà's artistic practice deals with the chemical reactions of materials, the multiple natures that a physical element can embody, as well as the deviations from utilitarian into metaphorical and iconographic. She reenacts processes and media reactions, altering the original chemistry, readdressing value through gestural multilayered approach, following the path of curiosity towards new artistic revelations. As the artist explains very well herself: "For the last ten years or so I’ve been mostly researching the use of photographic chemicals in an unconventional way, changing their function and exploiting their characteristics and properties and the inherent concept of photography. There are a number of reasons for this. One is certainly their immediacy, the lack of predictability in the chemical reactions and the wondrous after-effects. Another is the sheen of certain polyesters, which bring the surrounding environment into the work creating iridescent overlaps that relativize the end result. And finally, the message that traditional photography, more than other disciplines, brings with it, i.e. the illusion of freezing a moment in time and making a memory last forever."
On her daily practice she notes: "My daily practice is to cover, fold, pile up, unroll and move my works. Other times, I just leave them to sit for days, or sometimes years. I have pieces left for ages on my table where I finish stitching them or on the sofa where I’ve woven them, on chairs, rugs, stacked up against the wall. I move them around to make space, so that I don’t sit on them or to exhibit them, and each time they change a little and become something else. For me it’s important to see how and where I leave them, the way I’ve folded or put them down, how I’ve ordered them. How and where I have put them is really helpful to me. It’s as though the material is finding its own form and suggesting alternatives to me."
On her daily practice she notes: "My daily practice is to cover, fold, pile up, unroll and move my works. Other times, I just leave them to sit for days, or sometimes years. I have pieces left for ages on my table where I finish stitching them or on the sofa where I’ve woven them, on chairs, rugs, stacked up against the wall. I move them around to make space, so that I don’t sit on them or to exhibit them, and each time they change a little and become something else. For me it’s important to see how and where I leave them, the way I’ve folded or put them down, how I’ve ordered them. How and where I have put them is really helpful to me. It’s as though the material is finding its own form and suggesting alternatives to me."

Valentina De’Mathà's interdisciplinary work employs a variety of methodologies, among which weaving withholds a very special place: "Weaving is a ritual, mesmerizing act. It leads to ever new tales that change and grow as they develop and are repeated. My tapestries are receptacles of desires and thoughts, psychedelic states that alter the perception and vision of things as well as my state of consciousness, the way a snake sheds its skin, with its movements evoking the thread of the weft as it weaves in and out of the warp."
On finding herself within the contemporary art world and on being an artist, Valentina De'Mathà says: "I don’t think it’s all that important to set yourself at the centre of things as that can lead to stagnation and lack of development. The important thing is to maintain discipline. The artist must act in total freedom and madness according to his or her motion. It’s then it's up to the art system to give a more logical, concrete meaning to those processes. As far as I am concerned, my centre is constantly changing and fluctuating. And that’s how I like it."
On finding herself within the contemporary art world and on being an artist, Valentina De'Mathà says: "I don’t think it’s all that important to set yourself at the centre of things as that can lead to stagnation and lack of development. The important thing is to maintain discipline. The artist must act in total freedom and madness according to his or her motion. It’s then it's up to the art system to give a more logical, concrete meaning to those processes. As far as I am concerned, my centre is constantly changing and fluctuating. And that’s how I like it."


Valentina
De’Mathà
e il suo progetto #INTHESPACE
al Macro


Letteralmente, la parola ”spàzio” deriva dal latino ”spatium”, nel significato di «essere aperto». Con l’installazione di Valentina De’Mathà #INTHESPACE, visitabile sino ad oggi e che ha animato la Black Room del Macro Asilo di Via Nizza per tre giornate intere, l’arte si è concettualmente aperta e adeguata ad un’ era digitalizzata: lo stato di penombra induce il visitatore, in maniera del tutto spontanea e naturale, ad utilizzare la luce del proprio smartphone, oggetto d’ormai imprescindibile uso quotidiano. L’artista invita addirittura a scattare fotografie e video servendosi del flash, a postare immagini sui social network usando l’hashtag che è il titolo stesso del suo lavoro, per un’esperienza di totale interazione e fidelizzazione con il pubblico. La genesi del progetto #INTHESPACE si è avuta dalla riflessione sulla complessità e sul disordine della società odierna così come profeticamente narrati ne Le città invisibili di Calvino, i cui racconti di luoghi immaginari e paradigmatici si intersecano e si proiettano nella società contemporanea: le strutture relazionali e organizzazione dati che troviamo nella vita quotidiana e nella comunicazione [dal latino communico = mettere in comune, far partecipe] influenzano modo di esprimersi della società di oggi, gli scambi culturali, le relazioni interpersonali, il concetto di spazio come luogo di aggregazione sociale, come agglomerato di persone. Attraverso i riflessi e la lucentezza dei suoi poliesteri emulsionati, De’Mathà crea la sua città invisibile ma reale, tangibile, perfettamente al passo coi tempi, un hortus conclusus di tecnologia: un chiaro rimando agli schermi lucidi e levigati degli smartphone attraverso i quali inevitabilmente siamo soliti comunicare. Le tramature generate dalle incisioni praticate sulle superfici in poliestere simboleggiano infatti apertamente le reti social e la conseguente frammentazione dell’Io di ognuno oltre una realtà sempre più rarefatta e distorta, che continuamente ci connette per sconnetterci dal vero.
Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci
03.10.2019
LA MERAVIGLIA NELLO SPAZIO ESTESO DI VALENTINA
DE’MATHÀ
“In un Paese delle Meraviglie essi giacciono, Sognando mentre i giorni passano, Sognando mentre le estati muoiono: Eternamente scivolando lungo la corrente.... Indugiando nell'aureo bagliore... Che cosa è la vita, se non un sogno?“
Alice in Wonderland - Lewis Carroll
L'installazione #INTHESPACE di Valentina De'Mathà per il progetto MACRO ASILO trascina il visitatore a un dialogo continuo con la “Meraviglia”.
La “Meraviglia” (dal latino Mirabilia, dal verbo Mirare, Guardare) è nodo focale del racconto artistico tout court; in questa circostanza, entrando nella sala della black-room del MACRO, è reazione e sensazione al percorso esperienziale visivo immaginato dall'artista tramite l'utilizzo del medium della fotocamera e della luce del telefono cellulare.
Una meraviglia personale, intima, un viaggio in uno spazio altro e alterato, una lunga caduta nella “Tana del Bianconiglio” di Lewis Carroll e un lungo e personale monologo con la “gatta Dina” nel quale lo spettatore da un lato è portato a confrontarsi con sé stesso, con le proprie reazioni, dall'altro diviene soggetto costituente di una rete relazionale composta dalle molteplici singole e uniche esperienze.

Un rapporto e una relazione con lo “stupore” termine che porta in seno il prefisso (s)tup, colpire, percuotere, sensazione fisica che nasce da un'esperienza visiva da una epifania; una commozione, (cum-movere) un muoversi assieme come concetto perfettamente calzante al lavoro di concerto che porterà alla creazione della suddetta comunità virtuale racchiusa dal hashtag scelto come titolo dell'installazione.
La meraviglia è una sensazione violenta nella sua leggerezza, che unisce l'inaspettato, l'improvviso, al riconoscimento di una parte di noi, della nostra identità personale traslandole e mischiandole con il sogno, la dimensione onirica, la proiezione dello spazio e del tempo che smettono di essere limiti fisici e divengono variabili duttili, modificabili.
Avviene ciò ne “Le città Invisibili” di Italo Calvino, quando le parole di Marco Polo diventano fonte di meraviglia, di sogni, di architetture e di città di pensieri nella mente del Gran Khan.
La meraviglia è ritmo costante, tambureggiante nel viaggio Dantesco. Ne “La Commedia” la metafora e il fantastico si uniscono nel più limpido e crudo racconto della specifica contemporaneità della storia della letteratura.
La meraviglia è spesso base, obiettivo e strumento dell'arte visiva. Le “sette meraviglie” dell'antichità sono i monumenti con i quali si può raccontare la storia dell'umanità.
La meraviglia meta e compimento artistico nelle favole sospese, nelle tiepide notti russe di Chagall come nella violenza del messaggio contemporaneo di Damien Hirst.
La meraviglia è elemento trasversale, comune alla produzione artistica di Valentina De'Mathà: è meraviglia della gestualità, studio formalmente ed esteticamente delicato ed ordinato, frutto di enorme e costante ripetizione in una virtuosa manualità, quando si esprime con il ciclo degli Entanglement laddove viene studiata indivisibilità dell’ umano co-esistere tramite riferimenti specifici alla teoria dell’”Aggrovigliamento" portata dalla fisica quantistica.
La gestualità della tessitura diventa strumento non solo del creare, ma anche medium del narrare e del tramandare il nostro vissuto.
E' volontà di racconto, strumento e insegnamento. laddove il filo tessuto e intrecciato si trasforma in stoffa. Materialità dell'oggetto che nasce da un elemento materno; fisico nell'atto di chinarsi, piegarsi, accovacciarsi e nell'affaticare e spingere al limite il senso della vista: è un ritorno alle origini, alla famiglia, al tenere insieme le cose: i legami, la cultura; è intreccio di fili e carta, paradigmatici e metafora di relazioni, dipendenze, sentimenti e tradizioni.
Similare ma arricchito da una riflessione sul “disordine umano” è il progetto che ha portato all' installazione del 2011 Hair and Wool nel quale l'artista raccoglie, aggroviglia, cuce e intreccia capelli insieme a lana di pecora.
Quello che si ottiene è una struttura complessa, fusa, confusa, non dipanabile che racconta la verità di un DNA meticcio, aperto e in continua trasformazione e addizione del quale è composto un mondo in cui la moltitudine di etnie vivono, e convivono.
La meraviglia diviene silenzio, meditazione, fiato trattenuto e sospiro; studio e produzione artistica violenta, forte, visivamente commovente, racconto della simbiosi e del provenire e ritornare dell'uomo alla Terra, nell'installazione del 2013 Silenzio.
Opera portata in mostra al Padiglione Italia regione Abruzzo nel 2013, Silenzio è un progetto installativo in memoria delle 308 vittime del terremoto di L’Aquila costituito da
308 corpi realizzati con la tecnica del papier-mâché con all’interno ritagli di giornali quotidiani dell'epoca i cui titoli e articoli trattavano questa catastrofe.
L'elemento umano nel suo vivere in aggregazioni sociali, l'introspezione e estroversione dell'esistere, su questi temi il percorso di Valentina De'Mathà affonda le sue radici e attorno a questi concetti arrivando fino allo studio intenso e preciso tramite il medium artistico dell'elemento urbano della città: come luogo fisico, incrocio e punto di partenza di “vie” ma anche come umano incrocio di desideri e sogni, regole e leggi, inganni e sentimenti, scambi e confronti.
L'arte di Valentina De'Mathà è sì “luce” ,ma anche prepotentemente “segno”: secondo elemento essenziale e primario della sua produzione e della sua identità artistica.
Dal concetto di segno come pura demarcazione e limitazione delle coordinate cartesiane in funzione del possesso, dell'identificazione in quanto comunità, della personalizzazione e della suddivisione dello spazio- vita. Il “limite”, il “confine”, l'accettazione di esso e il “de- lirare” nell'accezione latina del termine, strettamente legata alla terra, l'andare con l'aratro oltre il solco e superarlo, sono elementi evidentissimi e originali nella produzione di De’Mathà.
di Pier Paolo Scelsi

Nomadic Roaming – Collectible DRY Magazine Vol.5
Abruzzo is a land rich in traditions, history and authenticity. I discovered it in greater depth only when I moved away from it. When I lived there, in my place of birth, my work was packed with all kinds of things, riotous colors, overlapping materials, dissonance, the restless teenage desire to escape.
When I moved to Rome a whole world opened up for me. Matter became liquid and paper took the place of canvas. I began to work horizontally. When the paper is on the floor there is more contact, you can sense and experience the material more intensely, in a relationship of symbiosis between equals, of give and take, and you can see things from another perspective. Everything changes. I liked to go barefoot, my feet were always stained with ink, it made me feel good. I began to drink tea and lived without a schedule. Rome reflected my way of living, of feeling free. It clung to me and captured me with sunshine, beauty and the music of day and night, until the day returned. Everything became possible in a timeless city, suspended between an always present past and an instant in which anything can happen. In which everything happens.
When I came in Switzerland everything became the opposite of what it was. For almost 10 years I have lived in a non-place where time is stretched and nearly always adds up to the same sum. I work a lot. Always. Often with more patience, which is something I have learned to do by living here. My work speaks of the symbiosis of man, nature and change. It explores places and traditions, the cause and effect of events. Switzerland is at the center of Europe, yet it is outside of it. It is a place apart, near but far from everything, extraneous to the typical things of the south. People don’t sing in the square here; there is lots of silence. My studio is near the border, in a place where there are customs barriers and a forest that expands like a multitude, while paradoxically setting a boundary. I live with two passports in my pocket, always with a book in my hands. I like to watch the helicopters that transport trees in the spring. I still drink tea, and being here I feel increasingly anchored to the traditions of my motherland, the floor of my mother’s house, the sum of the silhouettes of the mountains that always surrounded me and of those that surround me now. In all these years I have taken millions of photos: of myself, my books, my works, my cups of tea, floors, forests, everything that surrounds me. I still do it. Every day.My work has gotten cleaner. The cotton paper has become emulsion paper, and the material has become even more liquefied. Everything has become more linear. I try to organize the material, with the illusion of putting it into some order. This is something new for me. I still work on the floor, in the darkroom, but maybe with a more mature, measured, calculated approach. At times. Maybe. But a passionate character never changes, even after learning that it’s best not to get one’s fingers into everything.
CH – 22nd Aug 2017
------------------------------------------------------------
L’Abruzzo è una terra ricca di tradizioni, storia e genuinità. Io l’ho scoperto più da vicino quando mi sono allontanata. Quando vivevo lì, lì dove sono nata, il mio lavoro era carico di tante cose, colori chiassosi, sovrapposizioni di materia, dissonanze, e l’inquieta voglia adolescenziale di fuggire via.
Quando mi sono trasferita a Roma mi si è aperto un mondo. La materia è diventata liquida e la carta ha preso il posto della tela. Ho iniziato a lavorare in modo orizzontale, quando il foglio è sul pavimento c’è più contatto, riesci a sentire e a vivere più intensamente la materia, si instaura un rapporto di simbiosi, alla pari, un dare e ricevere, e riesci a vedere le cose da un’altra prospettiva. Tutto cambia. Mi piaceva camminare scalza, avevo i piedi sempre sporchi di inchiostro, mi faceva star bene. Ho iniziato a bere tè e vivevo senza orari. Roma ha rispecchiato il mio modo di vivere, e sentirmi libera. Mi si è stretta addosso catturandomi con il sole, la bellezza e la musica di giorno e di notte, fino al giorno. Tutto è diventato possibile in una città senza tempo, sospesa tra un passato sempre presente e un attimo in cui tutto può accadere. In cui tutto accade.
Quando sono arrivata in Svizzera tutto è diventato il contrario di ciò che era. Da quasi 10 anni vivo in un luogo non luogo in cui il tempo si è dilatato e si somma quasi sempre uguale. Lavoro tanto. Sempre. Spesso con più pazienza, è una cosa che ho imparato stando qui. Il mio lavoro parla della simbiosi tra uomo, natura e mutamento, esplora luoghi e tradizioni, e la causa effetto degli eventi. La Svizzera è al centro dell’Europa eppure ne è fuori. È un posto a sé, vicino ma lontano da tutto, estraneo a quelle fattezze tipiche del sud. Qui non cantano nelle piazze, c’è molto silenzio. Il mio studio è vicino al confine, in un posto dove ci sono dogane e c’è un bosco che si espande in moltitudine ma che, paradossalmente, traccia un limite. Vivo con due passaporti in tasca e sempre un libro tra le mani. Mi piace vedere gli elicotteri che trasportano gli alberi in primavera. Bevo ancora tè e, stando qui, mi sento sempre più ancorata alle tradizioni della mia terra materna, al pavimento di casa di mia madre, e alla somma dei profili delle montagne che mi hanno sempre circondata, con questi che mi attorniano ora. In tutti questi anni ho scattato milioni di fotografie: a me, ai miei libri, ai miei lavori, alle mie tazze di tè, i pavimenti, i boschi e tutto ciò che mi circonda. Lo faccio ancora. Ogni giorno. Il mio lavoro si è pulito ulteriormente, la carta di cotone è diventata carta emulsionata e la materia si è liquefatta ancora di più. Tutto è diventato più lineare, cerco di organizzare la materia con l’illusione di darle un ordine. È una cosa nuova per me. Lavoro sempre sul pavimento, in camera oscura, ma con un approccio forse più maturo, più misurato e calcolato. A volte. Forse. Ma un passionale rimane pur sempre un passionale, anche se ha imparato a non poter toccare tutto con le dita.
Svizzera. 22 agosto 2017







Art on Paper
New York

Art on Paper Art Fair in New York
March 3rd-6th, 2016
RandallScottProjects – Baltimore
Booth 504
Poltrona Frau
La collezione









Imago Mundi Luciano Benetton
Collection
Flashback
intervista a
Valentina De’Mathà
Flashback è il titolo della nuova personale di Valentina De’Mathà accolta fino al 14 dicembre negli spazzi della Nellimya: light art exhibition di Lugano. Per l’occasione abbiamo scelto di fare un passo indietro e di affidare all’artista il racconto di questa esperienza.
YOG: Partiamo dal principio, se è il principio. Come maiFlashback?
VDM:Flashback è un’antologica che comprende una selezione di 34 opere “pittoriche/fotografiche” realizzate in camera oscura su carte emulsionate e che evocano paesaggi luminosi, fantastici, epifanie, causati da distorsioni della psiche, déjà vu, visioni oniriche e, appunto, flashback.
Queste tipologia di opere sono una costante nel mio lavoro e per la prima volta ho deciso di focalizzare l’attenzione solo e unicamente su di esse concentrandole in un’unica mostra.
YOG: Uno degli aspetti più potenti dell’arte è forse la capacità di esprimere aspetti dell’animo umano, altrimenti confinati a pure sensazioni. Nel tuo caso, se volessimo indagare i tuoi “grandi temi”, quali potremmo citare? Sei più interessata agli aspetti oggettivi o quelli più ambigui e nascosti, come le sensazioni e le emozioni?
VDM:La mia ricerca si basa sul legame tra l’uomo, la natura e tutto ciò che è in divenire e la causa-effetto degli eventi, lasciando però ampio margine soprattutto a quella percentuale di imprevedibilità che caratterizza e sorprende la vita di ognuno di noi e tutto ciò che ci circonda.
YOG: In ogni mostra proponi un progetto completamente diverso dai precedenti. In questi anni hai lavorato con molti materiali e con altrettante tecniche di lavorazione. Quali ti hanno più affascinato e perché?
VDM:I miei progetti espositivi sono diversi l’uno dall’altro perché comprendono installazioni, scultura, pittura, fotografia e video, ma sono tutti legati tra loro da un unico filo conduttore che è sempre quello su cui è bastata la mia ricerca.
I materiali che utilizzo sono quasi sempre gli stessi, solo lavorati ogni volta in maniera differente.
La carta in primis è per me uno degli elementi più importanti e la maggior parte delle mie opere sono realizzate con questo materiale arcaico e versatile: di cotone, Nepalese, papier-machê, carta emulsionata. Quest’ultima elaborata in camera oscura, incisa, strappata, corrosa, intrecciata…
La cosa che mi affascina maggiormente è la dimensione pittorica che ho introdotto in camera oscura attraverso sostanze chimiche, come nelle opere presenti in Flashback. La pittura impone una maggiore solennità e offre orizzonti più vasti e variegati sempre nuovi.
YOG: Le tue opere come in una fotografia fissano il momento. Quanto del processo tradizionale di sviluppo fotografico rimane in questi lavori?
VDM:In realtà ben poco, se non il concetto base di fissare un processo e l’utilizzo di alcune sostanze chimiche tipiche della fotografia tradizionale, sommate ad altri materiali.
YOG:Dall’organico all’inorganico, dalla deperibilità del cibo (penso alla tua mostra Entropia alla Limonaia di Villa Saroli del Museo d’Arte di Lugano, o Humus Vitae, opera finalista al Premio San Fedele) alla immutabilità del fissaggio fotografico come nelle opere proposte in Flashback: cosa guida le tue scelte artistiche? Da chi e da che cosa trai ispirazione?
Una delle componenti più importanti nei miei lavori è il concetto di mutamento e di imprevedibilità, per questo spesse volte mi avvalgo di materiali deperibili, o materiali non del tutto controllabili nelle fasi di lavorazione.
VDM:La mia ispirazione trae nutrimento dal quotidiano, gli incontri, i tempi della natura, i cambiamenti, la voglia di differenziare un giorno dall’altro, la freschezza, e le letture di testi importanti.
L’idea iniziale di Entropia è nata da un testo di Gabriel Garcia Marquez, Cent’anni di solitudine, Humus Vitaeha riferimenti biblici, Flashback è collegato a Dostoevskij.
Miriam Sironi
Your own guide
27 novembre 2014
Elle Decor
Italia
Febbraio 2016


Intrecci d’artista
Hestetika Magazine n°22 Luglio 2016
L’arte di Valentina De’Mathà tesse i fili di quei momenti chiamati vita. Un complesso lavoro a confine tra pittura, fotografia e scultura.
Storie di incontri predestinati e poi voluti, come quello tra me e Valentina De’Mathà davanti a un caffè a Milano un anno esatto di distanza dalla festa di compleanno di un amico comune. Giovane artista italiana, nata ad Avezzano nel 1981, vissuta a Roma e residente in Svizzera dal 2008, Valentina mi racconta come nasce la sua ricerca, quali campi indaga e dove si sta volgendo.
Il tuo più recente lavoro è legato al concetto di non-separabilità (entanglement), fenomeno della fisica quantistica che ha ispirato le tue riflessioni sulle relazioni e interazioni inevitabili tra gli esseri viventi e il mondo. Ce ne parli brevemente?
Attraverso questo lavoro analizzo simbolicamente le capacità reattive degli esseri umani di fronte a eventi inesplicabili che si svolgono nella loro quotidianità e il collegamento con il Tutto. Credo fortemente nel potere decisionale dell’uomo, nella causa-effetto degli eventi, ma è anche vero che esistono dei fenomeni non deterministici che scompongono e sconvolgono i nostri ritmi. Per questo mi avvalgo quasi sempre di materiali che non mi permettono di avere su di essi una padronanza totale. Infatti da un lato c’è la tecnica, la tessitura, la ritualità, l’esecuzione prestabilita, dall’altra una dose di imprevedibilità dovuta alle reazioni chimiche dei materiali impiegati. Queste opere simboleggiano in qualche modo una frammentazione, scomposizione e ricomposizione della natura, appunto, il collegamento con il Tutto. È un lavoro basato sulla simbiosi tra me e la materia, ancestrale, spirituale e pratico.
Sarebbe quindi lecito parlare anche di panteismo?
L’esistenza è perenni dubbi, ricerche, scoperte, incertezze, precarietà, conferme; perenni consapevolezze, fallimenti, messa in discussione di presunte verità che ti portano all’esigenza di altre ricerche e scelte. È un eterno cadere e rialzarsi. Ha un processo circolare, a spirale, e si arricchisce con il movimento, con il fare e con il ripetersi.
Il risultato della tua ultima ricerca ti ha portato a sviluppare un progetto che include l’utilizzo di diverse tecniche tra cui la fotografia e la pittura, intrecciate tra loro (è il caso di dirlo) da un’altra arte che avrebbe il diritto di essere ritenuta “nobile”, la tessitura. Per realizzare ogni singola opera impieghi molto tempo, passando dalla camera oscura alla luce del giorno per dare forma a un vero e proprio arazzo. Puoi illustrarci le fasi principali?
Utilizzo differenti tipologie di carte chimiche e diverse emulsioni. Le carte vengono tagliate e intrecciate rispettando le proporzioni auree, poi assemblate, dipinte in camera oscura attraverso una serie di passaggi e procedimenti chimici, scomposte, fissate e lasciate ad asciugare. In seguito vengono composte nuovamente e infine cucite a mano. Le combinazioni sono infinite, simbolicamente è la materia che si disaggrega e poi diventa una forma altra. Ogni arazzo può richiedere anche mesi di lavoro e più di 200 metri di carta.
Ti immagino nel tuo laboratorio a mischiare componenti chimici. Quanta affinità può esserci tra artista e scienziato?
Moltissima! Entrambi sono dei ricercatori, fondano la loro ricerca sul paradosso, letteralmente “contro” “opinione”, ed entrambi costruiscono e abbattono muri in nome di una più alta consapevolezza dell’Essere. L’opera d’arte vive nel dialogo con chi la contempla, diventa tale solo quando le restituiamo la sua unità, appunto, contemplandola. Secondo la fisica quantistica lo stesso vale anche per il mondo naturale.
Molte figure mitologiche sono abili tessitrici. Ricordiamo ad esempio l’astuta Atena, Anankè e le Parche impegnate a filare vita e conoscenza, la tenace e paziente Penelope, ma anche Calipso e Circe tramatrici di inganni, oppure Aracne attorno a cui si era costituita una piccola comunità di donne. L’arte del tessere può dunque essere considerata come espressione di affermazione e ingegno, ma anche di resistenza e complicità femminile. Quali caratteristiche trovi a te più affini?
Tessere significa creare, generare qualcosa della propria sostanza: intreccio di eredità ancestrali e storia individuale. Un filo sottile si può trasformare in un intero pezzo di stoffa, questa è la magia della vita, del tramandare. Ho letto che in una cerimonia nord-africana le tessitrici tagliano con solennità l’ultimo filo dell’ arazzo recitando la stessa formula di benedizione pronunciata quando viene reciso il cordone ombelicale di un neonato. Tessere è un lavoro molto femminile, ancestrale; è un ritorno alle origini, alla famiglia, al tenere insieme le cose, i legami interpersonali, la cultura, gli scambi, gli incontri; è l’intreccio di relazioni e dipendenze. Si tesse l’istruzione e la conoscenza dell’uomo, lo spazio e il tempo in cui si intersecano continuamente mondo invisibile e realtà inevitabile. Tessere è la somma delle nostre scelte. La ritualità, la ripetitività, invece, elavano e perfezionano lo spirito, come lo zen.
I tuoi arazzi oltre a ricordarmi le trame dei tessuti mi fanno pensare agli intrecci dei cesti atti a contenere oggetti, oppure ai nodi che si possono fare con le corde per tenere fermo qualcosa che altrimenti andrebbe perduto. Qual è il tuo rapporto con le cose, i ricordi, il passato?
I cesti accolgono come il ventre materno. Ogni persona che incontriamo fa parte della trama del nostro arazzo, anche se il filo continua a scorrere e tesse altro. Siamo tutti collegati, anche quando poi apparentemente ci perdiamo e non ci incontriamo più. Con le persone, gli eventi, le cose, si fanno dei percorsi. Tutto ha senso in un determinato attimo della nostra vita. Non trovo sia giusto trascinarsi dietro l’idea di qualcosa che era e che ora non è più. Guardo al passato con serenità e al futuro con curiosità, ma ciò che mi interessa davvero è il presente e l’attenzione, e le scelte che decido di compiere adesso. Il presente è la somma del passato e il seme del futuro.
Riflettendo sugli intrecci che si innescano tra persone, tra scienza, arte e filosofia, mi viene in mente Heidegger e il suo “Essere e tempo”. Senza entrare nei dettagli, l’esser-ci viene concepito attraverso l’incontro. Tendiamo cioè a condividere il mondo in atteggiamento di apertura e comprensione, prendendoci cura (nel significato latino di attenzione, premura, partecipazione anche emotiva) degli altri enti. Qual è la tua personale relazione col mondo, considerato anche l’utilizzo dei nuovi social network?
Sono una persona entusiasta e curiosa, mi nutro di incontri, scelgo con premura le persone con cui relazionarmi occhi negli occhi. Mi interessano gli scambi alla pari, la cura reciproca, l’educazione, il rispetto e la parola data. Se ci sono questi elementi posso davvero affermare di esser-ci, se mancano, l’incontro non ha senso di essere. Vivo in un luogo di confine separato da una dogana, un luogo non luogo. La Svizzera è al centro dell’Europa, eppure ne è fuori. La maggior parte del mio tempo lo trascorro in studio a lavorare. I social network sono una piattaforma di scambi, una finestra sul mondo, un modo di uscire fuori e di mantenere un contatto.
Ma ciò che fai ti rappresenta o ti rappresenti attraverso ciò che fai? Quanta consapevolezza ci può essere nell’identificazione dell’artista con la sua opera?
Rappresento me stessa attraverso ciò che faccio, quindi, automaticamente, ciò che faccio mi rappresenta. Per periodi, spesse volte lunghi, si lavora impulsivamente e ossessivamente a un’idea. Poi arrivano quei momenti di forte lucidità in cui metti tutto in discussioni, ti analizzi e raggiungi nuove consapevolezze segnando altri traguardi, scoprendo e riscoprendo te stessa. Le mie opere sono un’estensione di me e, benché riescano a stare in piedi da sole, provengono da me e rappresentano tutta l’autenticità della mia visione sul mondo.
Per concludere, so che sei alle prese con un nuovo progetto che in qualche modo ti riavvicina ancor di più al mezzo fotografico e al gesto pittorico, alla base della tua formazione artistica. Puoi svelarci qualche piccola anteprima?
È un progetto pittorico realizzato sempre in camera oscura e che prende spunto dalle “Quattro stagioni” di Cy Twombly (uno dei miei più grandi punti di riferimento nell’arte), ma con una realizzazione formale ampiamente diversa. È ancora work in progress, ma già i primi risultati mi soddisfano molto e mi entusiasmano. In questo momento della mia vita sento di aver raggiunto una maggiore maturità e consapevolezza sia come donna che come artista. Questo nuovo lavoro è formalmente più “leggero” rispetto a quelli precedenti per via della scelta di supporti trasparenti, e colori più evanescenti. In realtà non parlo di leggerezza, ma di chiarezza, lucidità e consapevolezza. È una necessità di tornare alla pittura senza troppe spiegazioni. La pittura basta a se stessa e, per me, rimane il mezzo espressivo primordiale più efficace. Contemporaneamente continuo a lavorare su nuovi arazzi per la mia prossima personale in autunno in America.
Laura Luppi
Hestetika Magazine N.22
Luglio 2016
Intrecci e attimi:
Valentina
De’Mathà

“La mia ricerca è basata sull’interazione fra uomo, natura e mutamento, nonché sul principio di causa-effetto e sulla dialettica tra la mia azione sulla materia e la reazione della materia ai miei input, lasciando però ampio margine ad una percentuale di meccanismi non deterministici e possibilità tipici della fisica quantistica.
Esamino il comportamento dell’uomo di fronte all’imprevedibilità delle circostanze ineluttabili o causate da egli stesso; di conseguenza esploro le sue instabilità emotive e reazioni di fronte agli imprevisti
e ai mutamenti improvvisi e inevitabili.”
Valentina De’Mathà
Ho conosciuto Valentina De’Mathà per caso, passeggiando in centro ad Avezzano, cittadina abruzzese in cui ho vissuto per diciotto anni, mentre parlavo degli intrecci.
Delle volte sono così puntuali e inequivocabili gli incontri che accadono in un determinato istante, che innescano delle vere e proprie reazioni inspiegabili, come se certe connessioni siano lì ferme e impercettibili in attesa di essere messe in moto.
Io vivo a Roma da dieci anni ormai.
Valentina vive in Svizzera con suo marito da diversi anni.
Entrambe ci siamo incontrate durante il periodo dell’anno in cui, generalmente, si sta con la famiglia e si torna un po’ indietro nel tempo per riscoprire e riassaporare un mondo di origini che hanno contribuito alla costruzione del nostro presente e di quello che comunque sarà un pilastro per il nostro futuro… è come entrare da una porta minuscola in un mondo pieno di ricordi, profumi e suoni che incastrano il presente ad un passato a volte quasi dimenticato.
L’intreccio tra me e Valentina è avvenuto così. E davanti ai nostri caffè abbiamo scoperto tantissimi pensieri e sensazioni reciproche che mi hanno portato a volerne parlare.
E’ proprio l’intreccio il filone centrale di “Entanglement”, la nuova serie di lavori di Valentina De’Mathà, già esposti a Milano e a Miami, che sarà possibile ammirare a marzo anche a New York.
Entanglement come non-separabilità, come intreccio. Si tratta di un fenomeno della fisica quantistica che coinvolge due o più particelle subatomiche che si condizionano e comunicano a distanza.
Tutto è connesso e inseparabile, tutto è in correlazione come al momento del Big Bang, tutto si sta ancora toccando.
Tutto ciò che esiste è composto da particelle subatomiche e da questo legame con il tutto scaturisce l’entanglement umano che dà luogo alla nostra quotidianità e alle proprie relazioni interpersonali.
Le opere di Valentina De’Mathà raccontano proprio questa intensità di emozioni e connessioni materiche, da lei definiti come dei “Cordoni ombelicali” creati intrecciando delle carte emulsionate “dipinte” in camera oscura attraverso dei procedimenti chimici. Si tratta di veri e propri tasselli perfettamente combacianti che poi sono stati incastrati e cuciti tra loro per dare luogo a degli arazzi che diventano delle meravigliose opere d’arte in cui sono racchiuse Pittura, Fotografia, Scultura e Tessitura.
– Le tue opere sono un concentrato di emozioni, di conoscenza minuziosa di tecnica e della consistenza materica vera e propria dei materiali che usi per realizzarle. Sono sicuramente frutto di relazioni tra corpo mente e anima. Ma esattamente quando crei la tua opera d’arte? Quando scegli che debba venir fuori con quei determinati colori e che debba dare luogo a quelle determinate forme? Come avviene la creazione di ogni tuo lavoro? Quando inizia e quando finisce, se finisce, la tua creazione?
-Esistono le 4 stagioni:
C’è la stagione delle idee, dell’entusiasmo, delle visioni, quella della progettazione, dell’analisi, del coraggio, delle aspettative, quella del lavoro, della realizzazione, della concretezza, della sorpresa e quella della contemplazione, del riposo, della sedimentazione, della consapevolezza e rigenerazione.
Anche se a volte si confondono e sovrappongono o vengono vissute tutte contemporaneamente in un unico frammento di tempo.
Non c’è un momento giusto per creare, ogni momento è quello giusto.
Io lavoro tutti i giorni, tutto il giorno.
Un’opera è completa quando è lei a dirtelo, uno dei compiti dell’artista è anche quello di saper leggere questo messaggio.
Van Gogh disse: “Le emozioni sono talvolta così forti che le pennellate si susseguono senza fine.”
A volte è necessario sapersi gestire senza però spegnere l’entusiasmo.
-Le tue opere di “EPIPHANY” sono sempre state realizzate in camera oscura. Sono lavori pieni di luci e colori, ricchi di movimenti e sfumature ambivalenti che trovo molto musicali, anche se probabilmente è un termine poco adatto, ma a me danno questo senso di musicalità e sogno insieme. Ma tu in camera oscura, senza luci e senza rumori, che rapporto hai con i tuoi cinque sensi e con la materia con cui stai lavorando in quel momento?
-Sono una persona molto tattile e olfattiva, quando sviluppo pellicole fotografiche ho le mani in una sacca nera, agisco attraverso il tatto, sto attenta a compiere i giusti movimenti.
Lo faccio a occhi chiusi, taglio gli angoli del negativo, lo avvolgo…. mi lascio coinvolgere dall’odore della chimica.
È lo stesso quando “dipingo” con i chimici, ovviamente in questo caso la vista è fondamentale e l’odore delle sostanze chimiche non è molto piacevole, infatti mi proteggo sempre meticolosamente con mascherine e guanti.
In realtà do molta importanza alla musicalità delle cose, crea forme, pesi e proporzioni, dà una metrica alla quotidianità.
Quando lavoro ho sempre musica nelle orecchie, ascolto brani molto variegati che influenzano in qualche modo il mio umore e di conseguenza, probabilmente, la mia visione sul lavoro che sto realizzando in quel momento.
Ogni opera ha una sua “colonna sonora”, così come ogni libro per me ha un suo odore.
Le “Epiphany” narrano paesaggi fantastici, a volte bruciati dalla luce, déjà vu, visioni oniriche, flashback, appunto epifanie, ma sono anche delle porte aperte su dei cantucci della mente.
– A proposito dei cinque sensi, mi viene in mente il progetto per la tua personale al Museo d’Arte di Lugano, ispirato a “Cent’anni di solitudine” di Gabriel Garcia Marquez e basato sull’Entropia e sul ciclo della vita. Su questa lunghissima tavolata hai posizionato del cibo, dei fiori , delle verdure e frutta e dei piatti pieni di terra e di semi.
L’esposizione consisteva nel permettere al pubblico di osservare per due mesi i mutamenti di ciò che era sulla tavola: mentre il cibo marciva e i fiori appassivano, dalla terra germogliavano i semi. Hai fatto incontrare a tavola la vita e la morte insieme, come in un eterno dialogo silenzioso. Anche l’entropia è un concetto legato alla scienza. Ti ha mai spaventato legare concetti così scientifici all’arte e alle tue emozioni? Questi concetti legati alla meccanica ti hanno mai frenata e/o condizionata pensando a quello che sarebbe stato il risultato finale di un tuo lavoro? Perché?
-Mi avvalgo della scienza come spunto “filosofico”: tutto è materia, tutto è in continua evoluzione, tutto è connesso con il Tutto, la coscienza è immortale, e questa è la quotidianità, è una delle realtà imprescindibili della vita.
Io parlo di ciò che tocca il nostro stare al mondo, lo faccio con gli occhi di un’artista, racconto la mia realtà ricollegando spesse volte eventi della vita a fatti scientifici.
-Guardando i tuoi profili sui social network non è difficile intuire il forte legame tra la materia e il tuo corpo. Si vede chiaramente dalle tue foto che hai bisogno di sperimentare, di sporcarti con quella stessa materia con cui plasmi i tuoi lavori e di creare un percorso tangibile che probabilmente fa parte anch’esso della stessa opera d’arte nella sua propria forma. Ti capita mai di riguardare queste foto a opera ultimata? Se si cosa provi mentre ti guardi?
-Amo molto la fotografia, è un mezzo fenomenale che mi permette di fermare ciò che reputo importante.
Ho iniziato a scattare all’età di undici anni, affamata di attimi, e da allora vivo in simbiosi con la macchina fotografica, ho cassetti interi di pellicole fotografiche e tera di scatti digitali.
Tra questi ho molte immagini di me mentre lavoro e mi capita di riguardarle nel tempo e riscoprire l’energia e tensione che hanno caratterizzato quel preciso momento.
A volte da lì nascono nuove idee.
Per me sono punti che delineano un racconto.
Sono molto fisica, mi piace sporcarmi le mani, camminare a piedi nudi, annusare le cose.
Eccetto quando cucio, in genere quando lavoro non lo faccio mai seduta o al muro, su un cavalletto, o su un tavolo, ma a terra.
Si ha un impatto più fisico con la materia, c’è una tensione muscolare diversa, posso camminarci intorno ripetutamente, sopra, a piedi nudi, sentirne la consistenza, guardarla da diversi punti di vista, sentirmi più dinamica.
Le immagini che posto sui miei social network parlano spesso di questo.
Non sono semplici ritratti di una ragazza, per me ognuna di esse ha un’importanza che va oltre la “bella foto”.
Anche le immagini che sembrano apparentemente fine a se stesse, in realtà per me hanno un messaggio ben definito, che siano foto di pagine di un libro, tazze di tè, il mio studio, i miei lavori, i miei appunti o i miei piedi macchiati d’ inchiostro, o semplicemente me stessa.
Ogni elemento che mi circonda prende parte, in qualche modo, di un percorso atto alla realizzazione delle mie opere, e io, spesso, ne rendo pubblica una parte attraverso le fotografie.
-C’è sempre un’evoluzione nelle tue opere che restano comunque legate ad un filo conduttore che è un qualcosa che le identifica immediatamente in un’appartenenza alla tua personalità artistica.
Questo cammino rappresentato dalla tua arte in cosa andrà a sfociare nei tuoi prossimi lavori, sempre se possiamo già parlarne?
-Ho lavorato tutto il 2015 quasi solo esclusivamente sugli arazzi (Entanglement) e sicuramente continuerò a dare ancora il giusto tempo all’evoluzione di questa tipologia di lavoro, scoprendo passo passo in che modo continuerà a sorprendermi.
Parallelamente sto lavorando alla realizzazione di nuovi progetti. In questo periodo sto studiando nuovi materiali e ho intenzione di ampliare gli “intrecci” su cui si basa la mia ricerca, coinvolgendo altri artisti non necessariamente visivi.
Mary A. Chiarilli
Entanglement
Intervista a
Valentina De’Mathà
Loom Gallery accoglie – fino al 16 gennaio – la personale di Valentina De’Mathà, artista di origine italiana che vive e lavora in Svizzera. Entanglement richiama l’attenzione sull’esistenza umana, sulla vita che scorre tra connessioni e incontri; abbiamo scelto di affidare alle parole dell’artista il racconto di questa esposizione.
 Photo © Roger Weiss
Photo © Roger Weiss
YOG: Partiamo dal titolo, per la tua ultima mostra accolta alla Loom Gallery di Milano, hai preso in prestito un termine dalla fisica quantistica: Entanglement.
Ci vuoi raccontare come mai?
VDM: Entanglement significa non-separabilità, intreccio, è un fenomeno che coinvolge due o più particelle subatomiche o “entità”, che si condizionano e comunicano a distanza.YOG: La meccanica quantistica è forse la branca, tra quelle sperimentalmente verificate, più bizzarra della fisica. Può essere considerata il corrispettivo nella scienza di Alice nel paese delle meraviglie (tanto da aver ispirato Robert Gilmore con la celebre variazione Alice nel paese dei quantiNdR).
Le particelle sono correlate, tutto è connesso e inseparabile, non esistono sistemi isolati.
L’umanità stessa è composta da particelle, quindi l’entanglement umano è naturale e questo legame, scaturisce la nostra quotidianità e le nostre relazioni interpersonali.
Credo nelle connessioni, negli incontri, nell’unione con il Tutto, nella costante trasformazione della materia, nell’immortalità della coscienza e questa consapevolezza mi affascina e stimola moltissimo.
Il progetto è incentrato su degli arazzi in carta emulsionata su cui intervengo pittoricamente in camera oscura attraverso procedimenti chimici e sintetizza il mio percorso artistico degli ultimi 7 anni racchiudendo in ogni singola opera, la pittura, la tessitura, la fotografia e la scultura.
Queste opere simboleggiano in qualche modo una frammentazione, scomposizione e ricomposizione della natura.
Sono sempre stata una persona molto dinamica, veloce, attraverso questo lavoro ho riscoperto l’importanza della ritualità, della dilatazione del tempo, l’importanza di scegliere come impiegarlo. È un lavoro molto femminile, mi riporta a quando ero bambina e cucivo con mia nonna, è un ritorno alle origini, alla famiglia, al tenere insieme le cose.
Ogni arazzo richiede anche mesi di lavorazione, e nelle opere di formato medio grande, utilizzo anche fino a 200 metri di carta.
È un lavoro molto lungo, di pazienza, intrecciare e cucire diventa come un mantra, mi apre la mente, mi fa pensare molto, in quei momenti mi passano per la mente immagini molto vivide, costruisco cose, nuove realtà, ho nuove intuizioni.
Prendo in prestito i colori della natura, li frammento, scompongo e ricompongo, alcune parti appaiono come i pixel di un’immagine fotografica ingrandita, un’indagine sul micro cosmo. In realtà parlo di atomi, tasselli, quantum, del legame con il Tutto, della materia che non perisce ma si trasforma in altro.
Negli ultimi 20 giorni prima dell’opening di Entanglementpresso la Loom Gallery di Milano, ho lavorato anche 16 ore al giorno. La notte intrecciavo e il giorno cucivo.
È stato un periodo molto “elettrizzante”.
A volte è capitato che mio marito abbia acceso la luce e mi abbia detto: «Stai cucendo al buio, non te ne sei resa conto».
Hai tratto ispirazione da testi, magari fantascientifici, per questo tema?
VDM: In realtà questo progetto è ispirato inizialmente alle teorie di Epicuro, all’atomismo e si ricollega poi alla meccanica quantistica, presa da me come spunto “filosofico”, affascinata da quei sui tipici meccanismi non deterministici: metafore di vita. Attraverso i materiali e la tecnica di realizzazione di queste opere, analizzo simbolicamente le capacità reattive che gli esseri umani mettono in gioco di fronte a eventi inesplicabili e il collegamento con il Tutto. Per me la vita è la somma delle scelte che si fanno quotidianamente, credo fortemente nella facoltà dell’uomo di incanalarla e portarla dove vuole, credo nella determinazione, nei percorsi prestabiliti, nella causa effetto degli eventi, ma è anche vero che esistono gli imprevisti, le ineluttabilità e la rottura di certi schemi che rendono più esaltante, affascinate e a volte anche inquietante il nostro stare sulla terra. Per questo mi avvalgo quasi sempre di materiali che non mi permettono di avere su di essi una padronanza totale.
Questo lavoro è basato sulla simbiosi tra me e la materia, sulla sua risposta ai miei input, lasciando però una percentuale di margine alla sua imprevedibilità e indomabilità.
YOG: Noto che nel tuo percorso artistico il connubio tra arte e scienza è una costante – ricordo ad esempio la tua mostra legata alla teoria dell’Entropia al Museo d’Arte di Lugano – che scaturisce innanzitutto dalla scelta e lavorazione dei materiali e tecniche impiegate. Cosa ti affascina di questo rapporto?
VDM: Nei miei lavori/progetti parlo della quotidianità, di ciò che io reputo importante e questo sta in tutto ciò che in qualche modo “tocchiamo” e che ci “tocca” sotto diversi punti di vista e avendo un corpo materico e una coscienza, la scienza non può esserci estranea.
Il protagonista del progetto al Museo di Lugano era il cibo e la ciclicità, il trasformarsi della materia in altro, il nutrimento primario, posto su una tavolata di 15 metri per due mesi sotto gli occhi di tutti. In Entropiaparlavo di scienza, è vero, di uno dei fenomeni che abbiamo costantemente sotto agli occhi, ma nella realizzazione formale decisi di fare anche un omaggio a Gabriel Garcia Marquez e al suo Cent’anni di solitudine.
Ricordo il capitolo in cui Rebeca mangiava la terra.
Questa immagine non mi fece dormire la notte, rimasi con gli occhi fissi a pensare a Rebeca che mangiava la terra, che cercava di compensare le sue mancanze prendendo nutrimento della Madre Terra. Una persona che mangia la terra! Era diventata un’immagine fissa nella mia mente.
Per questo motivo la misi nei piatti e ci infilai dei semi.
YOG: Si accennava poco fa alla tecnica. Ti va di raccontarci come procedi nella realizzazione di queste tue opere?
VDM: Utilizzo diverse tipologia di carte chimiche e diverse emulsioni. Le carte vengono tagliate e intrecciate, poi dipinte in camera oscura con l’ausilio principale di sostanze chimiche attraverso pennellate, immersioni, sovrapposizioni e variazioni di temperatura delle stesse e dei tempi di esposizione, poi vengono fissate, lavate e lasciate ad asciugare. In fine assemblo nuovamente il tutto come tasselli perfettamente combacianti e li cucio insieme.
YOG: Ultima domanda, la classica, di rito: progetti futuri? Ti va di svelarci qualche notizia in anteprima?
VDM: A questa domanda rispondo sempre che i miei progetti più concreti sono quelli di lavorare a cose nuove, poi il resto viene da se. Comunque a marzo sarò ad Art on Paper di New York con la galleria Randall Scott Projects di Baltimora con la quale ho appena esposto a Miami Project e con cui ho altri progetti in cantiere, nel mentre ricordo che Entanglement, presso la Loom Gallery di Milano, sarà visibile fino al 16 di gennaio ed è assolutamente una mostra imperdibile!
Alessia Ballabio
YOG your own guide
December, 12, 2015
Le foto di
De’ Mathà
Inside Art

A Lugano le sperimentazioni sulla carta sensibile e sulla luce dell’artista abruzzese
Valentina De’Mathà è la protagonista della nuova mostra Flashback, un viaggio tra colori e luci sempre differenti. Abbiamo scelto di affidare all’artista il racconto di questa esperienza.
Ha inaugurato Flashback, mostra accolta alla Nellimya: light art exhibition di Lugano, spazio espositivo dedicato all’arte di luce. Quanto è importate la luce per questo progetto? Vuoi parlarci un po’ del percorso espositivo?
«Si tratta di un’antologica che racchiude una varietà di 34 opere realizzate in camera oscura prevalentemente attraverso sovrapposizioni di sostanze chimiche e fonti luminose su carte emulsionate. La mia ricerca, benché segua un concetto base definito, spazia dalla scultura, all’installazione, al video, dalla pittura alla fotografia e questa tipologia di opere realizzate in camera oscura, compare quasi sempre in ogni mio progetto espositivo, è una costante. Nellimya: light art exhibition, è una galleria che nel corso degli anni si è specializzata in progetti artistici che avessero come componente principale la luce, attenendomi al concetto su cui si fonda, ho deciso di esporre qualcosa che fosse in qualche modo creata con la luce, ma che non fosse visivamente esplicita».
I lavori in mostra hanno un impatto deciso. Puoi svelarci alcuni retroscena del processo creativo?
«Come accennavo, si tratta di opere create in camera oscura attraverso sovrapposizioni di sostanze chimiche, variazioni di temperatura di quest’ultime, dell’acqua e fonti luminose su carte precedentemente emulsionate. Il processo di realizzazione è spesso lungo e complesso, richiede dinamicità ed immediatezza e la giusta sapienza, i giusti tempi. La tecnica è basata sul concetto di causa-effetto e sulla visione dialettica tra gli input che regalo alla materia e la sua capacità di reazione, lasciando però ampio margine a una percentuale di meccanismi non deterministici e sfumature tipici della fisica quantistica, altro punto cardine della mia ricerca. Narrano paesaggi luminosi, fantastici, distorsioni della psiche, epifanie, déjà vu, visioni oniriche e appunto, flashback».
Le tue opere, soprattutto la serie Rorschach, agiscono in maniera differente su ciascuno spettatore, godendo di una realtà mutevole che vive nella relazione con chi le osserva. Quanto è importante il ruolo del pubblico per te?
«Mi affascina ascoltare le percezioni che hanno i fruitori, spesse volte me le raccontano e da lì nascono nuovi confronti. In genere evito di mettere titoli troppo specifici che indirizzano e condizionano troppo chi guarda l’opera, mi piace lasciare sempre ampi orizzonti, affinché ognuno trovi le sue risposte o si ponga le sue domande. Per quanto riguarda la serie Rorschach, di evidente riferimento alle tavole dell’omonimo psichiatra svizzero, è già intriso in esse il concetto assolutamente soggettivo di ”scoprire cosa ognuno di noi ci vede”, di tirare fuori se stesso, ciò che siamo, attraverso la contemplazione di un’opera d’arte».
Guardiamo avanti, progetti futuri?
«Sto portando avanti da diversi mesi un progetto sulla mia Terra natale, la Marsica, e sulla ricchezza della sua storia. Un lavoro ampio e variegato, in continuo divenire e ciò stimola quotidianamente la mia voglia scoprire e riscoprire le mie origini. Questa per ora è la cosa più importante e necessaria».
Alessia Ballabio
Inside Art
23.11.2014
http://insideart.eu/2014/11/23/le-foto-di-de-matha/
Valentina De’ Mathà
-Entropia-
Museo d’Arte di Lugano, Limonaia di Villa Saroli
Curated by Guido Comis and Cristina Sonderegger
Texts by Ignazio Licata and Maria Savarese, Edizioni Sottoscala







Valentina
De’ Mathà
Corpi Rossi

Maria Savarese: quali sono i nuclei concettuali intorno ai quali ruota la tua ricerca? Perchè hai scelto il corpo come
soggetto per i lavori di questa mostra?
Valentina De’Matha’: la mia ricerca è basata sulla simbiosi tra Uomo, Natura e Mutamento e sulla Causa-Effetto degli
eventi. Mi interessa il comportamento dell’uomo di fronte all’imprevedibilità delle circostanze ineluttabili o causate da lu stesso e, di conseguenza, le sue instabilità emotive e reazioni di fronte agli imprevisti e ai mutamenti improvvisi e inevitabili Questa ricerca pittorica è incentrata sulla materia che prende forma da sé, sul dinamismo delle metamorfosi, su processi, sulla nascita e gestazione dei pensieri: metafore dell’Essere e delle relazioni interpersonali. I corpi che si contorcono sono solo la conseguenza di ciò che la mente gestisce.
Queste gestazioni, questi ventri gonfi, sono semplicemente la cristallizzazione di un processo, e dire qualcosa intorno all’anima è dire qualcosa di profondo sul corpo.
Siamo quello che facciamo, processi.
Il mio lavoro è basato sulla simbiosi, lo scambio e il dialogo tra quello che io posso dare alla materia (lo stimolo) e quello che la materia può darmi di risposta. Causa – Effetto. La pittura mi destabilizza e, contemporaneamente, mi rende forte. È la parte più “animale” di me e attraverso la qual mi guardo allo specchio. Il mio esser presente al mio lavoro è il mio sentirmi ancorata alla Terra, alle mie Origini, a Me stessa, in una continua catarsi.
L’Arte è una conseguenza, come l’Amore
Valentina De’Mathà
Entanglement
Loom Gallery is delighted to announce Entanglement, a solo exhibition of brand new works by Switzerland based artist Valentina De’Mathà. The opening reception will take place
Thursday, 26 November, from 7 to 9pm, and the artist will be present.
The status of entanglement reflects an actual and impossible separation, an intertwinement.
It’s a physical phenomenon, discovered by quantum physics, where two or more subatomic particles, also known as “entities”, mutually condition themselves, but at the same time communicate among themselves.Consequently, physical systems are strongly connected, they actually resonate with each other.
Subatomic particles are mutually correlated, so reflecting the Big Bang theory, according to which everything was connected at the beginning, but everything is still connected and inseparable now. Humanity consists of subatomic particles, hence the “human” entanglement is a state of nature, our day-to-day behaviour and human relationships actually originate from that connection.
The artist created a structured set of “umbilical cords”, an intertwinement of emulsified papers:
these same papers were then chemically “painted” by means of chemical procedures in the darkroom. Finally “painted” cords have been precisely embedded and sewn into each other, leading to tapestry works where painting, photography, sculpture and weaving are contained altogether.
Valentina De’ Mathà is born 1981 in Avezzano, Italy, she lives in Switzerland.
Her research is based on the interaction among man, nature and mutation, as well as on the causality principle and on the dialectic between her action on matter and its reaction to it. Her peculiar technique also gives vent to a high percentage of non-deterministic mechanisms
and to the typical uncertainty of quantum mechanics. She examines human behaviour
when people are facing the unpredictability of inescapable circumstances or events caused by themselves; consequently, she explores the human emotional instabilities and reactions of people facing the unexpected, inevitable or sudden life-changing experiences.
Loom Gallery è lieta di presentare la prima mostra personale in galleria di Valentina De’Mathà, artista di origine italiana che vive in Svizzera; il titolo della mostra Entanglement
richiama l’attenzione dell’artista sull’esistenza umana, fila di anime viventi che attraversano
i cammini della terra e si intrecciano tra di loro, in un turbinio di esperienze, emozioni
e sensazioni.
Entanglement identifica la non-separabilità, l’intreccio: un fenomeno scoperto dalla fisica
quantistica che coinvolge due o più particelle subatomiche o “entità”, che si condizionano
e comunicano a distanza. Ciò significa che non esistono sistemi isolati, ogni cosa risuona
con il tutto.
Le particelle sono correlate, così com’era tutto collegato al momento del Big Bang: ciò significa che tutto si sta ancora toccando, tutto è connesso e inseparabile. L’umanità è composta da particelle subatomiche, quindi l’entanglement umano è naturale, un legame con il tutto da cui scaturisce la nostra quotidianità e le nostre relazioni interpersonali.
Partendo da tali assunti l’artista ha dato forma a una struttura che definisce “cordoni ombelicali”, derivante dall’intreccio di carte emulsionate poi “dipinte” in camera oscura attraverso procedimenti chimici. Successivamente le carte emulsionate sono state assemblate come tasselli perfettamente combacianti e cuciti tra di loro realizzando degli arazzi; dando così vita ad opere che racchiudono la pittura, la fotografia, la scultura e la tessitura.
Valentina De’Mathà nasce nel 1981 ad Avezzano, Italia. Vive e lavora in Svizzera.
La sua ricerca è basata sull’interazione tra uomo, natura e mutamento, nonché sul principio di causa – effetto degli eventi, e sulla visione dialettica tra l’ azione dell’artista sulla materia e la reazione della materia ad essa. Le sue opere hanno fatto parte di numerose esposizioni, tra cui la 54a Mostra Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia Padiglione Italia nel 2011; recentemente ha partecipato al progetto globale non profit di arte contemporanea “Imago Mundi – Luciano Benetton Collection” presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino) e la Fondazione Giorgio Cini (Venezia).
www.loomgallery.com
Una fisicità
irrinunciabile di
Valentina
De’Mathà
Nell’ottica del marketing esperienziale, dell’emotional–business, del consumo bulimico di arti visive dell’epoca web, manca la relazione tra il corpo, i sensi, le cose, i materiali e i linguaggi plurimi che danno forma a concetti in bilico tra natura e artificio. Shakespeare osservò che << niente è bello o brutto, ma è il pensiero che lo rende tale>>, tutto nel corso del tempo perpetua la memoria. Valentina De’Mathà, classe 1981, abruzzese d’origine e nomade per vocazione, dopo un periodo di vita trascorso a Roma dove si è nutrita di classicismi si è trasferita in Svizzera dove vive e lavora. A Milano, dopo la mostra collettiva Fame di Terra tenuta da Amy-d – Arte Spazio, in cui ha presentato un’installazione ecosostenibile dal titolo L’uomo che Piantava gli Alberi, si ripresenta nella stessa galleria con un progetto diverso che ripercorre le tappe più significative della sua ricerca artistica e presenta per lo più opere inedite, scelte con la collaborazione di Annamaria D’Ambrosio, curatrice della mostra, psicologa lacaniana e autentica talent scout di artisti emergenti. Questi lavori dall’identità apparentemente instabile raccolti sotto il titolo emblematico Relationship, condotti nell’ambito della figurazione, dell’astrazione geometrica e del rigore concettuale, all’insegna della libertà esplorativa di sperimentare discipline differenti senza rincorrere uno stile o un codice riconoscibile, qui divengono un’installazione site-specific, altro da sé. Ogni singola opera è un “attore” in cerca di spettatore, che inscena un dialogo surreale sul valore dell’intreccio, della relazione, dello scambio tra l’essere e il nulla e delle dinamiche complesse tra l’io e l’altro, come presupposto per fare arte: una polifonia di linguaggi. La natura proteiforme dell’autrice s’imprime in soluzioni formali e progetti neo-concettuali dai codici diversi: basta un rapido sguardo alla varietà delle opere esposte per capire quanto, ordine e disordine, casualità e costruzione, geometria e istinto, simmetria e instabilità siano gli opposti sui quali verte la sua ricerca artistica, paradossalmente contraddittoria come le sue opere dai diversi codici formali: in talune è figurativa, come in alcuni acquerelli e disegni e in altre risulta più astratta-geometrica.
Tutte le sue opere sono impregnate di vissuti, di relazioni che sono il frutto di repentini cambiamenti e di istintivi approcci ad esperienze molteplici, di approdi a tecniche e linguaggi tradizionali, come il disegno, la pittura e la scultura o immateriali, come la fotografia e il video.
L’autrice in bilico tra organico e virtuale, negli ultimi anni ha concentrato la sua ricerca sulla simbiosi tra natura e movimento, sull’ineluttabilità della trasformazione delle cose e sul processo di cambiamento della materia, anche se in alcune scultore di forme geometriche tende a solidità ancora tutte da esplorare. Di sé dice: << Mi interessa il momento creativo, è uno scambio alla pari, una simbiosi tra quello che la materia può offrirmi e, di ricambio, quello che io posso offrire ad essa>> . Il cambiamento accade perché non può fare altro. E il nodo di tutta la mostra sta qui: nella materia come summa del fare, trama d’incontri e mezzo di scambio e intreccio di relazioni possibili: l’arte è pensiero non didascalia. Attualmente affianca alla pittura di matrice post-espressionista, una ricerca più volumetrica –scultorea, quasi minimalista in seguito al suo trasferimento in Svizzera.
Per De’ Mathà, non c’è un prima o un dopo: tutto accade nell’attimo in cui si guarda le sue opere o le installazioni in cui astrazione e istinto convivono in un alchemico equilibrio da “toccare” con gli occhi. Il fil-rouge in questa personale non cronologica ma tematica è la relazione delle opere con lo spazio e lo spettatore, incentrata sull’importanza delle materia come conduttore di energia vitale. Tra i suoi materiali preferiti c’è la carta, come erano i 308 fragili corpi aggrappati al muro, ispirati alle vittime del terremoto dell’Aquila (2009), realizzati per l’installazione intitolata Silenzio, esposta alla 53° Biennale di Venezia nel Padiglione Italiano. La carta come simbolo di vulnerabilità della vita; carta di cotone bianca o quella Nepalese, con la quale ha dato forma a sinuosità di corpi femminili, simili a drappeggi d’impatto scultoreo che evocano le statue classiche. Ricorrenti nella sua ricerca sono i nodi, i lacci e gli intrecci: tutti simboli in rapporto al gesto dello sciogliere e del legare. Il senso dei suoi lavori sta nell’intreccio di opere diverse che ha sia la funzione di tenere insieme, sia quella di allontanare, mentre nel gesto dello strappo o dello sbriciolamento di materiali cartacei adagiati in ordine sparso sul pavimento, rimanda alla tensione di liberazione dell’istinto, di rompere ciò che prima si è faticosamente costruito.
Sculture di carta e stoffa, protuberanze materiche che sembrano eruttare dal muro bianco, liberando un’energia recondita, sulla natura ambigua ed effimera di noi e delle cose. Materiali solidi o leggeri, trasversali, destinati a molteplici variazioni, quintessenze della sua ricerca artistica, in bilico tra tensione spirituale e desiderio di infinito, mentre nella tensione di liberazione dalle forme chiuse, ci riconduce alla fisicità dell’esserci, ancorandoci ai materiali stessi, come ready- made della realtà.
In questa dialettica degli opposti, la sintesi siamo noi che guardiamo cose fatte “fittiziamente ad arte”, come facticius, (feticcio che in portoghese significa miracolo).
L’io corpo–mente è determinante per “sognare” o tendere ad un modello ideale di smaterializzazione di sé nella pienezza corporea. Organico e inorganico sono inscindibili dall’arte, come la vita intessuta di sentimenti, di scelte, di cose, intrecci che sono una parte integrante dell’individuo e rappresentano il mondo come potenzialità in atto di processi di cambiamento.
De’Mathà si pone come obiettivo di abitare le opere che produce permeate di sensazioni e dubbi che si fanno corpo- habitus nel senso maussiano e come poi ripreso da Foucault e da Bourdieu .
I sensi sono parametri cognitivi del mondo e ancor più oggi, nell’epoca transgenica, della modernità liquida, diventano l’abito mentale, l’intreccio con la fisicità in cui il corpo si riscopre unità percettiva, mettendosi in relazione con l’ambiente, la società e gli altri. L’oggettivazione di processi di cambiamento, di cose che restano ma che potrebbero cambiare essenza a seconda di dove e come le si inscena, è fondamentale soprattutto nell’epoca del sex- appeal dell’inorganico all’insegna del “timore e tremore” dell’annullamento dell’io fisico nello spazio immateriale, estendibile. Materia e sensi rivendicano fisicità necessarie, rappresentandosi nel sentire il corpo, soggettivamente e sensorialmente nella concretezza di trovarsi e relazionarsi con altri. Le opere di De’Mathà contestualizzano, localizzano relazioni possibili, ambigue e transitorie come i nostri pensieri tra noi, le cose e le azioni, come cause ed effetto che determinano conseguenze imprevedibili.
Jacqueline Ceresoli
Il corpo solitario.
L’autoscatto nella fotografia contemporanea
di Giorgio Bonomi
L’autoritratto come poetica, oltre che come tecnica: questo libro offre per la prima volta una rassegna amplissima di artisti che usano la fotografia avendo come soggetto il proprio io, il proprio corpo. Vengono esaminati più di 700 artisti di tutto il mondo, dagli anni ’70 ad oggi, da quelli più famosi ed affermati ai più giovani ed esordienti: il libro infatti vuole documentare la diffusione esponenziale di questo fenomeno artistico. Attraverso la ricerca della propria identità, con il travestimento, con la narrazione, la sperimentazione, la denuncia, gli artisti pongono problemi profondi che sono psicologici ed estetici, sociali e politici. L’autore dà conto di tutti con una breve introduzione ad ogni capitolo, con un esame succinto dei singoli autori e con una selezione delle loro opere, in bianco e nero ed a colori. nlettore vedrà che l’autoscatto è una pratica soprattutto degli artisti di genere femminile e che il corpo viene definito “solitario” proprio perché tale tecnica è eseguita in solitudine, da soli o al massimo con l’ausilio di un amico che preme il pulsante della macchina fotografica, così “il corpo solitario” si impone nella società massificata come testimonianza di malessere ma anche come possibilità di evasione e di salvezza.
Editore Rubbettino Collana Rubbettino Arte Contemporanea Anno 2012 ISBN 9788849836165 Pagine 422
Elle Decor Italia n°12
Dicembre-Gennaio 2016

Mappe dell’arte nuova
Nel tempo presente delle utopie arenate, degli attacchi al patrimonio culturale, dagli attentati all’immaginazione e alla conoscenza, Imago Mundi propone a Venezia l’arte senza confini che rompe il silenzio, supera le differenze, sospinge in avanti la civiltà.
Imago Mundi/Luciano Benetton Collection
lunedì 31 agosto ore 19:00,
Fondazione Cini, Venezia – Isola di San Giorgio Maggiore
31 agosto/01 novembre 2015
Praestigium Benetton Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
“Praestigium Contemporary Artist from Italy”
Collezione Imago Mundi/Luciano Benetton a cura di Luca Beatrice
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Lunedì 18 maggio 2015
ore 19:00 – 21:00
Via Modane 16 – 10141 Torino (Italia)
Miami Project
December 1-6 2015
Deauville Beach Resort
6701 Collins Avenue
Miami, FL 33141, USA
RandallScottProjects – Baltimore. Booth R1
FLASHBACK.
A CONVERSATION WITH VALENTINA
DE’ MATHÀ
A CONVERSATION WITH VALENTINA
DE’ MATHÀ
…pensive twilight of the moonless transparent nights…
Aleksàndr S. Puškin, The Bronze Horseman
PC. What are you trying to achieve through your artistic practice, Valentina?
VDM. A higher awareness of human existence
PC. Your art is imbued with your research on the concept of the simultaneity of cause and effect. How are you narrowing down this theme in the Flashback series? Moreover, as I think that some works from this series evoke essential nocturnal landscapes — topographically ambiguous, yet cinematographically vivid —, I would like to ask you one more thing: which technique do you use in order to let their light emerge and to harness it?
VDM. These works were created in my darkroom through the mixing of chemicals, and through their temperature changes, as well as water and light temperature variations on emulsified paper. It is a long and complex creative process, which has to be realized speedily and dynamically while considering the right amount of chemicals, movements, and time. This technique is based on the concept of cause and effect and on the dialectics between my action on matter and its reaction to it, but I also give vent to a high percentage of non-deterministic mechanisms and to the typical uncertainty of quantum mechanics, which is another cornerstone of my research. These works are narrating bright, fantastic landscapes, psychological distortions, epiphanies, déjà vu, dreamlike visions, as well as flashbacks, of course. They are undecided, imbued with light, even though they are paradoxically realized in the total absence of light.
PC. Some other works resemble the widely known inkblots that Hermann Rorschach used in the homonymous psychological tests. I don’t think it’s a coincidence…
VDM. Well, it’s no coincidence, because I dedicated this series to the Rorschach test. But, in this case, the ambiguous pictures are created through chemical processes. I am fascinated by human psyche and psychology in general — even though I don’t believe in psychotherapy. In particular, I developed an interest in some inner workings that are uncontrollably sparked off in the human mind. Some time ago, while interpreting Jacques Lacan’s theory on the lack of being (manque à être) that he called béance, I created an installation and two video art works (Trip and Il godimento è una tensione che non raggiunge mai la sua realizzazione, poiché può avere luogo solo quando non ha luogo) based on mental journeys, on addictions, on loss of mental acuity, on OCD (obsessive-compulsive disorder) and on unresolved desire.
PC. Through your work, and for a long time, you have been analyzing human reactivity that individuals put into play when they are facing inexplicable and apparently inevitable events. Do you think that this series is dealing with this subject?
VDM. Absolutely, both through the technical implementation and the concept on which the whole exhibition project is based. To a certain extent, flashbacks, dreamlike visions, déjà vu, psychological tests represent the manifestation of something that already happened, the consequence of a past event that suddenly, inexplicably, and uncontrollably, comes back to the present.
PC. And to what extent do you think the theme of psychological resilience facing the increase of disorder (entropy) of the social system affects your work?
VDM. Basically, I am not a coherent person and that is one of my greatest strengths. Incoherence gives me an opportunity to put myself out there on a daily basis, and to be dynamic and grow as a person. It nourishes my need for questioning myself when necessary and to adapt to all the events that happen every day. Inevitably, those events affect me, nourish me and get me involved, despite the fact that my path has been set and my nature is well-defined. My work can make progress, enhance and grow when it keeps pace with me; it has to be resilient, as well. I generally create artworks taking into account both the available materials and the environment that surrounds me in a particular moment; never the other way around. I try to indulge myself with nature, its phases, and I try to live, as far as possible, in the present.
PC. At the end of Belye noči, White Nights, Fëdor Dostoevskij’s dreamer sums up his torments of love and gratitude to Nasten’ka with these words: “Good Lord, only a moment of bliss?” Do you think that the creative process and its outcomes could equally lead us to that moment of bliss?
VDM. I am glad that you quoted Dostoevskij’s White Nights, which is in some way related to the nocturnal landscapes featured in Flashback. I am very attached to the Russian masters, particularly Andrej Tarkovskij and Dostoevskij who are so inspirational. Yes, I think that the proper opening of the right cerebral hemisphere during the creative phase, and consequently the contemplative phase, gives us the chance to be projected into a state of bliss and ecstasy, which is only reachable when you feel connected to everything.
PC. What is the ecstasy of art, according to you? Is it leading you to new visions?
VDM. It is a bond between me and everything else. It has to do with feeling real through a sense of identity that is achievable by creating.
PC. I usually find something special in you works, a kind of sacredness or hierophany, i.e. the awareness of the presence of something sacred. Is that so?
VDM. Work is sacred and it should be handled with care. It has a soul. It has its own soul. It needs time and perfect timing; it needs to be contemplated and admired by sincere eyes, respected and preserved above everything else, because it’s the innermost part of yourself. It’s the revelation of your catharsis.
PC. You are always showing the ability to manage your practice according to the well-known motto ne quid nimis, nothing in excess. How do you reach such essentiality?
VDM. Through the rituality of work.
FLASHBACK. UNA CONVERSAZIONE CON VALENTINA DE’MATHÀ
…crepuscolo pensoso delle notte illuni trasparenti…
Aleksàndr S. Puškin, Il cavaliere di bronzo
PC. Che cosa stai cercando di raggiungere attraverso la tua pratica artistica, Valentina?
VDM. Una più alta consapevolezza dell’esistenza umana.
PC. La tua ricerca sul concetto di simultaneità di causa ed effetto intride la tua arte. Come riesci a circoscrivere questo tema nei lavori della serie presentata in Flashback? Inoltre, poiché credo che alcuni dei lavori della serie richiamino alla mente sintetici paesaggi notturni — topograficamente ambigui ma cinematograficamente vividi —, vorrei chiederti un’altra cosa: attraverso quale tecnica riesci a lasciar emergere e poi imbrigliare la loro luce?
VDM. Si tratta di opere create in camera oscura attraverso sovrapposizioni di sostanze chimiche, variazioni di temperatura di quest’ultime, dell’acqua e fonti luminose su carte emulsionate. Il processo di realizzazione è spesso lungo e complesso, ma va gestito con velocità e dinamicità, tenendo conto delle giuste dosi dei chimici, dei movimenti, dei tempi. La tecnica è basata sul concetto di causa-effetto e sulla visione dialettica tra gli input che io do alla materia e la sua capacità di reazione, lasciando però ampio margine ad una percentuale di meccanismi non deterministici e sfumature tipici della fisica quantistica, altro punto cardine della mia ricerca. Narrano paesaggi luminosi, fantastici, distorsioni della psiche, epifanie, déjà vu, visioni oniriche e, appunto, flashback. Sono ambivalenti, intrisi di luce e, paradossalmente, vengono realizzati nella quasi totale assenza di essa.
PC. Altri lavori ricordano le largamente note macchie di inchiostro utilizzate da Hermann Rorschach negli omonimi test psicologici proiettivi. Immagino che ciò non rappresenti una coincidenza…
VDM. No, non è una coincidenza; è una serie di lavori dedicati proprio alle tavole di Rorschach, ma in questo caso le figure ambigue sono ottenute grazie a procedimenti chimici. Mi affascinano la psiche umana e la psicologia in generale — anche se non credo nella psicoterapia. In particolare, alcuni meccanismi che si innescano in modo incontrollato nella mente umana catturano il mio interesse. In passato ho creato un’installazione interpretando la teoria di Jacques Lacan sulla “mancanza-ad-essere”, da lui denominata béance, e due video-art (Trip e Il godimento è una tensione che non raggiunge mai la sua realizzazione, poiché può avere luogo solo quando non ha luogo) basati sui viaggi della mente, sulle dipendenza, sulle mancanza di lucidità, sul disturbo ossessivo-compulsivo e sul desiderio irrisolto.
PC. Da tempo, attraverso il tuo lavoro, analizzi le capacità reattive che gli esseri umani mettono in gioco di fronte a eventi inesplicabili e apparentemente inevitabili. Senti che anche in questa serie il tema sia, in qualche modo, trattato?
VDM. Assolutamente, sia attraverso la tecnica di realizzazione sia attraverso il concetto su cui è basato l’intero progetto espositivo. I flashback, le visioni oniriche, i déjà vu, i test psicologici, sono in qualche modo la manifestazione di qualcosa che è già avvenuto, la conseguenza di un evento passato che torna improvvisamente e inspiegabilmente, in modo incontrollato, nel presente.
PC. E quanto il tema della resilienza di fronte all’aumento di disordine (entropia) del sistema sociale pervade il tuo lavoro?
VDM. Sono fondamentalmente una persona incoerente e reputo ciò un pregio. L’incoerenza mi dà modo di mettermi in gioco quotidianamente, di essere dinamica e sentirmi in movimento, in crescita. Alimenta il mio bisogno di rimettermi in discussione quando è necessario e di adattarmi, di plasmarmi in qualche modo rispetto agli eventi che mi circondano nel quotidiano e che inevitabilmente mi nutrono e coinvolgono, nonostante il percorso da seguire sia comunque già indirizzato e la mia indole ben definita. Il mio lavoro per andare avanti, nutrirsi e crescere, ha necessariamente bisogno di adattarsi al mio passo, di essere anch’esso resiliente. Quasi sempre creo delle opere in base ai materiali che ho a disposizione, ai luoghi che mi circondano in quel determinato momento e quasi mai il contrario. Cerco di assecondare quasi sempre i tempi della natura e di vivere, per quanto possa essere possibile, il presente.
PC. Nel finale di Belye noči, Le notti bianche, il sognatore di Fëdor Dostoevskij riassume così il suo tormento d’amore e la sua riconoscenza per Nasten’ka: “Dio mio! Un intero attimo di beatitudine!” Credi che il processo creativo e i suoi risultati possano, parimenti, portarci verso quell’attimo di beatitudine?
VDM. Mi fa piacere che tu abbia citato Dostoevskij e il suo romanzo Le notti bianche, in qualche modo riferibile ai paesaggi notturni presentati in Flashback. Sono molto legata ai grandi maestri russi e, in particolare, Andrej Tarkovskij e Dostoevskij sono annoverabili tra i miei punti cardini fondamentali. Sì, credo che questa totale apertura dell’emisfero destro durante la fase creativa e, successivamente, quella contemplativa, ti porti a toccare determinati punti che ti proiettano in uno stato di totale estasi e beatitudine che si raggiungono quando si entra in contatto con il Tutto.
PC. Che cosa è per te l’estasi artistica? Verso quali visioni ti conduce?
VDM. È un legame tra me e il Tutto. È il sentirsi concreti attraverso il senso di identità che si raggiunge tramite il fare.
PC. Vi è spesso nei tuoi lavori un quid che rimanda, a mio giudizio, a una sorta di sacralità o comunque a una ierofania, cioè alla coscienza della presenza di qualcosa di sacro. È così?
VDM. Il lavoro è sacro e va maneggiato con cura. Ha un’anima. Un’anima propria sommata alla tua. Ha bisogno dei giusti tempi, di essere contemplato e toccato da occhi sinceri e rispettato e difeso sopra ogni cosa perché è la parte più intima di te, è la rivelazione della tua catarsi.
PC. Dimostri sempre la capacità di gestire la tua pratica secondo il motto ne quid nimis, niente di troppo. Come raggiungi questa essenzialità?
VDM. Attraverso la ritualità del lavoro.
Paolo CappellettiValentina
De’Mathà
Entropia
Curated by Guido Comis and Cristina Sonderegger.
Texts by Ignazio Licata and Maria Savarese
Museo d’Arte di Lugano, Limonaia di Villa Saroli
“Les liaisons”
di Valentina De’Mathà
La mostra di Valentina De’ Mathà (1981) da Amy-d Arte Spazio è un percorso attento e sostenuto dedicato al tema delle relazioni, focus della ricerca dell’artista che, in una continua sperimentazione di materiali e linguaggi, tuttavia sempre condotta con coerenza e sensibilità, oggi vuole mostrarci una selezionata antologica del suo lavoro.
Ed è qui che i fili rossi si scoprono, stringendo in un’unica trama di senso la ricerca di De’Mathà, presentata nello spazio milanese di Annamaria D’Ambrosio e introdotta da un denso testo di Jacqueline Ceresoli che, analizzando la metamorfica tensione delle sue opere, sottolinea come «il cambiamento accade perché non può fare altro. E il nodo di tutta la mostra sta qui: nella materia come summa del fare, trama d’incontri e mezzo di scambio e intreccio di relazioni possibili: l’arte è pensiero non didascalia».
Un pensiero che si esprime con la pancia, con il corpo, con una mano stretta in quella della persona amata. Un pensiero che è verifica dei limiti dell’individuo rispetto ai confini dell’umanità. Un pensiero che è atto d’amore verso il mondo e le sue imprevedibili relazioni.
E se è vero che ogni esposizione deve essere il momento in cui l’artista, e le sue opere, si es-pongono al mondo e in esso prendono posto, staccandosi dal cordone ombelicale che al creatore le legava e nutriva, mai come in Relationships di Valentina De’Mathà questo fatto, puro, vero, crudo, avviene, e la mostra diventa un uscire dalla propria pelle, per scivolare in quella dell’altro, dell’altro come sé: ex-peau-sition, aveva giocato con le parole il filosofo Jean Luc Nancy.
Incontrandosi con l’altro, le sue opere segnano quella struggente ed eterna incompletezza che è necessaria perché esse stesse esistano: una mancanza-ad-essere che De’Mathà, da sempre sostenuta da una vasta messe di letture e di conoscenze, riconduce a Lacan e mette in campo ora attraverso la visualizzazione della rottura del rapporto tra madre e figlio, necessaria quanto dolorosa; ora traccia in embrioni di inchiostro bitumoso; altrove costruisce, tavola su tavola, riproducendo l’idea di piazza, luogo dell’incontro e dell’addio, dove trovarsi e salutarsi. Entra la sua vita personale, in ogni opera raccontata e fatta a pezzi con la consapevolezza femminile di una donna-artista di trent’anni. E i messaggi d’amore della coppia diventano la maglia frusciante di un arazzo contemporaneo, triturati dal tempo che scorre.
Altrove due ganci si rincorrono a mezz’aria, danza metaforica che esprime, in un video di 16 minuti, «un moto oscillatorio, un corteggiamento, una proiezione concettuale sulla fatalità di un’apparizione. Un incontro tra la cosa, la natura e l’artista che trasmigra il suo sentire all’estetica casuale – dipinta dal vento – di due ganci danzanti», ha scritto acutamente Valentina Piccinni.
Il video si intitola “Il godimento è una tensione che non raggiunge mai la sua realizzazione, poiché può avere luogo solo quando non ha luogo”.
Tesi l’uno all’altro, i lavori di De’Mathà tendono a noi con un moto analogo a quello dei due sottili ganci ripresi nel video: ci chiamano a sé, in una danza coinvolgente e liberatoria, segreta e pubblica. La danza dell’arte con la vita.
Ilaria Bignotti
Espoarte
23 ottobre 2013 http://www.espoarte.net/arte/les-liaisons-di-valentina-de-matha/#.VHs-ZWSG8kUGround Zero #05
/Frontiere
/ottobre
/2013
The Naked Pact
Our problem is not “eating”. Eating is always here and now, but we are not made for the instant. We need the nourishment which is our relationship with Mother Earth and with the Spirit, conscious of the intimate link between the two. Food is the same for everybody, it keeps us going. An animal life, which sometimes borders on the vegetal. Nourishment is different. It is the awareness of what is right for us, and for us only. It’s a pact with the world in its inflexible concreteness. It is to live, but also to accept that each act of nourishment is an exchange for time, time which takes us towards death, where ultimately entropy takes over
and we are dispersed as dis-organised matter. Those who eat will live until they stop eating, while those who nourish themselves accept life also within death, transforming the organic pact of the great cycle into new forms of life: love and passion, art, science, music. In the end we nourish ourselves with meaning, and we die of meaning. And the meanings remain, somehow, like our works or children, to testify that we were not parasites, but donors of Sense.
Il Patto Nudo
Non è “mangiare” il nostro problema. Mangiare è sempre qui e ora, e noi non siamo fatti per l’istante. Abbiamo bisogno di nutrimento, che è il rapporto con la Madre Terra e con lo Spirito,
nella comprensione dell’intimo legame tra le due cose. Il cibo è uguale per tutti, ci tiene in piedi. Una vita animale che a volte sfiora il vegetale. Il nutrimento è diverso. E’ consapevolezza di ciò che è giusto per noi, e solo per noi. E’ un patto con il mondo nella sua irriducibile concretezza. E’ vivere, ma anche accettare che ogni atto di nutrimento si trasforma in tempo e il tempo ci conduce alla morte, alla fine l’entropia ha il sopravvento e ci disperdiamo come materia dis-organizzata. Chi mangia vive solo finché non smette, chi si nutre accetta la vita fin dentro la morte trasformando il patto organico del grande ciclo in nuove forme di vita: l’amore e gli amori, l’arte, la scienza, la musica. Alla fine, noi ci nutriamo di significati, e moriamo di significati. E i significati restano, in qualche modo, come opere o figli, a testimoniare che non eravamo parassiti, ma donatori di Senso.
Ignazio Licata
“Entropia” curated by Guido Comis and Cristina Sonderegger.
Museo d’Arte di Lugano – Limonaia di Villa Saroli
Switzerland
ENTROPIA
From its beginnings, Valentina De’Mathà’s research has investigated the dynamic and unstable relationships between man and nature, through the perspective of mutation, inquiring into the laws of cause and effect which govern the fluctuations between these two poles and their metamorphosis.
In this installation presented at the Limonaia di Villa Saroli, the artist once again focuses her attention on nature, borrowing its materials: earth, fruit, wine, water, and bread, are neatly arranged onto plates in a meticulously thought-out composition which delivers highly effective relationships of form, light and colour, capable of transporting the observer into a state of secluded contemplation and, at the same time, generating a synesthesia involving the various perceptive areas, relating senses of smell, touch and vision. It is a table of the senses, therefore, where the notions of caducity and transience suggested by the decay of the fruit are blended with the concept of rebirth offered by the fragile shoots which inhabit the plates. Built on binary associations, between life and death, the beginning and the end, but principally on the metamorphosis of the elements and the eternal dance of entropic disorder, this work suggests an awareness of the processes which are fundamental to us all.
Almost a counterpart to the “still life” genre, De’ Mathà’s nature is alive, expressing the sense of life, respect for nature’s cycles and its temporality, the total acceptance of the eternal wheel of life and death. The dichotomy between “food” and “nourishment”, alimentation and nutrition, body and soul, is investigated here with an attentive and disturbing look, and a reference to Lucretius who, in his De rerum natura exorcised the fear of death through a reference to a culinary image: “Those about to die”, Lucretius explains, “must think like a guest who is sated when the banquet ends: if life has been full of joy, then you can retreat from it like a guest who is full and happy after a rich banquet; while if life was marked by pain and sadness, there can be no sense in hoping for it to continue, dragging oneself through new sufferings”.
This is an invitation to a lavish banquet of nourishment, more than simply food: we nourish ourselves with symbols and meanings, passions and emotions, transforming them into the joy of living, which is then
donated once again to mother earth who feeds us with her fruits. As Ludwig Feuerbach said:“We are what we eat”, but more importantly, we are what we nourish ourselves with, and what we nourish the world with.
La ricerca di Valentina De’Mathà sin dagli esordi indaga i rapporti dinamici e instabili dell’uomo e della natura nella prospettiva del mutamento, andando a ricercare quelle leggi di causa ed effetto che regolano le oscillazioni e le metamorfosi di questi due poli.
In quest’installazione presentata alla Limonaia di Villa Saroli, l’artista ancora una volta focalizza la sua attenzione sulla natura, chiedendone in prestito i materiali: terra, frutta, vino, acqua, pane, ben disposti nei piatti di cui studia meticolosamente la disposizione, caratterizzata da rapporti di forme, luce e colore. Riesce così a condurre lo spettatore in uno stato di raccolta contemplazione, producendo al tempo stesso
una condizione sinestetica fra i diversi ambiti percettivi, quello olfattivo, tattile e visivo.
Una tavola dei sensi, dunque, dove i concetti di caducità e transitorietà legati alla marcescenza dei frutti, si fondono al concetto di rinascita rievocato dai fragili germogli che abitano i piatti. Costruita su gruppi binari, fra la vita e la morte, l’inizio e la fine, ma soprattutto sulla metamorfosi degli elementi e l’eterna danza del disordine entropico, quest’opera ci riavvicina ai processi che ci sono fondamentali. Quasi un contraltare al genere della “natura morta”, quella della De’Mathà è una “natura viva” che
esprime il senso della vita, il rispetto per la temporalità naturale e i suoi cicli, l’accettazione totale dell’eterna
ruota della vita e della morte.
La dicotomia tra “alimento” e “nutrimento”, alimentazione e nutrizione, corpo e anima viene qui indagata con sguardo attento e perturbante e un rimando alle parole di Lucrezio che nel De rerum natura esorcizzava la paura della morte con un’immagine culinaria: “Chi si accinge a morire – spiega Lucrezio – deve ragionare come un convitato sazio quando finisce il banchetto: se la vita trascorsa é stata colma di gioia, allora ci si può ritirare da essa come un convitato sazio e felice dopo un lauto banchetto; se, al contrario,
é stata segnata da dolori e tristezze, non ha senso desiderare che essa prosegua, trascinandosi tra nuove sofferenze”. Un invito a un lauto banchetto del nutrimento più che dell’alimento, quindi: ci nutriamo di simboli e di significati, di passioni ed emozioni, trasformandoli in gioia di vivere, che poi viene ridonata a madre terra che ci ha alimentati con i suoi frutti. Perché come sosteneva Ludwig Feuerbach:“Siamo ciò che mangiamo”, ma soprattutto siamo ciò di cui ci nutriamo, e ciò di cui nutriamo il mondo.
Maria Savarese
The Washington Post
Beguiling photographs at Randall Scott; neon sculpture, paintings at Heurich; Kurdish themes at Foundry
For his first group exhibition at his temporary space, Randall Scott selected painters, mostly from New York and Los Angeles; his second is of photographers, and includes several from Europe. Neither lineup was chosen to highlight a particular theme, but some emerged nonetheless. Among the nine artists in “Untitled No. 2,” three address female identity and self-image.
Julia Fullerton-Batten depicts young women in several series, all of them a little ominous. For “Teenage Stories,” she photographed girls at European theme parks that feature model buildings. The results make her characters look normal in everything but scale, and prominent in a way that most adolescents struggle to avoid. The German-born British photographer’s “In Between” images depict dancers in mid-fall, with various props and safety devices digitally removed to make her subjects appear more at risk than they really were. Eeriest of all are the “School Play” photos, in which girls in matching blond wigs pose in such places as a library and a locker room. The faces are different, but the identity is communal — except for one woman in “Changing Room,” who abashedly stands out because blood is running down her leg.
Jen Davis photographs plus-size women, also young and blond, in wistful scenes of attempted glamour or erotic longing. To add to the sense of alienation, the New York photographer sometimes poses her models with women who are conventionally alluring, such as a bikini-clad beach lounger in “Pressure Point” or a woman applying lipstick in “Primping.” Chris Anthony’s digitally compiled portraits are less psychological; the women the L.A. artist places in vast expanses are more visual motifs than characters. Still, there’s an implicit critique of classical art’s use of the female form in the white-on-white “Rebellion,” in which a woman in a voluminous dress imitates a sculpture, complete with plaster on her face.
There is one transvestite, but no women, in Marco Delogu’s“Cardinals and Criminals,” which puts clerics in the lineup with thugs. The Roman artist’s black-and-white Polaroids are stark and shadowy, but there’s a friskiness to the way he correlates the faces, all very serious about their respective callings. If John Waters doesn’t already collect Delogu’s work, he’ll probably start soon.
Christopher Griffith and Jenny Okun take very different approaches to landscape. The former’s black-and-white images of an industrial site and car-dealer pennants are so high-contrast that they suggest engravings. The latter’s collages of architectural details, composed in the camera but sometimes digitally enhanced, yield compositions that suggest such pattern-oriented miniaturists as Paul Klee, especially in more flat-seeming works such as “Olymbos Chapel, Karpathos, Greece.”
All but one of these artists shoot on film, although they may use digital technology to refine and print their work. The exception is Valentina De’ Mathà, who doesn’t shoot at all. The Italo-Swiss artist hangs sheets of emulsified photo paper, streaked in chemical shades of gold, tan and gray. Her sculpture (which happens to be called “Untitled no. 2”) revels in form and shadow, but also laments what will be lost when all photography is digital: the lucky mistakes that yield beautiful metallic hues.
Mark Jenkins
Washington Post
Friday, August 17, 2:02 AM
Valentina
De’Mathà
in mostra
a Milano
ACL: La scintilla creativa è una vocazione, gli artisti lo sanno bene…Ricordi la tua ” Chiamata”?
VDM: Non credo che ci sia mai stata una vera e propria “chiamata”.
Ciò che è il mio presente è sempre stato anche in passato da quando ho memoria.
ACL: Avviene spesso che stile e intenzioni crescano di botto nell’esperienza di un artista, che mutino improvvisamente nello slancio di evolvere. Riconosci nella tua opera questi salti in avanti, sapresti ricordane per ognuna le cause della detonazione?
VDM: Il mio lavoro formale subisce spesso cambiamenti improvvisi e totali, benché la ricerca su cui si basa rimane sempre la stessa anche se in continua evoluzione e consolidamento.
Sono state e sono tutt’ora diverse le motivazioni: gli incontri, gli spostamenti, le intuizioni improvvise, la scoperta di nuovi materiali, ma credo soprattutto i cambiamenti radicali che ho fatto nella mia vita, come quando ho lasciato l’Abruzzo per trasferirmi a Roma e, successivamente, ho lasciato Roma per trasferirmi in Svizzera. Tutte scelte e occasioni improvvise avvenute dall’oggi al domani, istintive e non meditate.
Di conseguenza, le nuove culture, i nuovi incontri e scambi, il cibo, gli odori, il clima, i territori e mio marito Roger Weiss (fotografo), hanno influenzato enormemente il mio stile di vita e, di conseguenza, la mia ricerca ha trovato e trova periodicamente nuovi percorsi per esprimersi.
ACL: Quel che colpisce nel tuo lavoro è anche la tua delicata presenza materiale, quale fondamentale elemento dell’Opera al pari dei pigmenti o dell’acqua, dai l’impressione di essere uno dei medium pittorici, ne hai percezione?
VDM: Sono molto tattile e olfattiva, sono molto “animale”, mi piace il Fare e il vivere concretamente le cose, per questo sono fisicamente molto presente al mio lavoro e, spesse volte, non in modo così “delicato” come percepisci.
Mi interessa il momento creativo, è uno scambio alla pari, una simbiosi tra quello che la “materia” può offrirmi e, di ricambio, quello che io posso offrire ad essa. È molto stimolante e sorprendente.
Il mio lavoro non può prescindere da me, benché porti con se messaggi universali e riesca a stare in piedi con le sue gambe e vivere di vita propria.
ACL: I bambini disegnano per spiegarsi il mondo… qual’è la tua lezione? Cosa spiegheresti ad un’ipotetica classe?
VDM: Tarkovskij diceva che il compito dell’Arte è quello di spiegare a se stessi e a chi ci sta intorno perché vive l’uomo, qual è il significato della sua esistenza, o, se non di spiegarlo, quantomeno di porre loro delle domande. La funzione dell’arte consiste nell’idea della Conoscenza, dove la percezione si esprime nella forma dello svolgimento, della catarsi. Questo è quello che vorrei comunicare, vorrei che le persone si ponessero delle domande e trovassero delle risposte dentro se stessi.
ACL: Si dice che quello dell’Arte sia un cammino, un tragitto fra due mete, collegato da un ponte. Com’è il tuo ponte e cosa vedi di fronte a te?
VDM: Nell’arte spesse volte ci sono dei percorsi che cominciano in un modo e poi cambiano radicalmente durante lo svolgimento. È pura ricerca e sperimentazione.
Mi piace immaginare più mete indefinite e in movimento…. e vari percorsi.
ACL: Raccontami quel che vedremo a Milano.
VDM: L’installazione “L’Uomo che Piantava gli Alberi” è un progetto tratto dall’omonimo racconto di Jean Giono. Una parabola sulla simbiosi tra Uomo – Natura e Mutamento, i tre punti fondamentali su cui è basata tutta la mia ricerca artistica, incentrato su un incondizionato e sconfinato gesto di amore, generosità e immutabile costanza.
Assolutamente pertinente con la Permacultura, tematica su cui si basa “Fame di Terra” presso Amy-d Spazio Arte di Milano, nel senso più genuino del termine:
È un progetto basato sull’amore incondizionato verso la Madre Terra e le generazioni a venire, sulla condivisione delle risorse della Terra e la cura della stessa. Tematiche verso le quali ognuno di noi dovrebbe avvicinarsi, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo.
“Fame di Terra” ha come sottotitolo “Il secondo mondo si sta mangiando il terzo mondo”, la mia installazione, “L’Uomo che Piantava gli Alberi”, vuole essere una risposta a questa avidità di potere.
Alice Lenaz
Il nostro Giornale
5 luglio 2012
Fame di Terra
Fame
Se ho voglia, è soltanto
di terra e di pietre.
Il mio pranzo è sempre aria,
roccia, carbone, ferro.

Scrivere un testo che analizzi criticamente la ricerca di nove artisti contemporanei, dai linguaggi diversi, dalle esperienze anche lontane, provenienti da paesi e culture distanti, riuniti in una mostra che fin dal titolo è disperatamente attuale, Fame di terra, implica diversi rischi: innanzitutto, quello di indirizzare l’analisi dal punto di vista socio-politico, interpretando così ciascuna opera esposta quale manifesto ideologico. Oppure, e al contempo, quello di rinunciare alla specificità dei vari lavori, leggendoli come un unicum teso alla esplicazione del tema espositivo, senza mettere in luce la peculiarità dei singoli linguaggi.
Per questo motivo c’è Arthur Rimbaud in apertura, e scorrerà durante lo svolgersi del testo: laddove il tema è dichiarato e necessario, acutamente contemporaneo, come anche l’indirizzo della galleria, il dovere di chi scrive è sottolineare il livello estetico e semantico delle opere selezionate, riconoscerne sinestesie e metafore.
Da questa analisi, anche l’etica del progetto sarà rafforzata.
Se un’opera d’arte è tale, essa sempre rivolge problemi e pone domande; non è accomodante e non è decorativa.
Fame di terra: materia pura e fertile alla quale tornare, in una ricerca che riparte dagli elementi naturali, da ciò che compone l’instabile suolo sul quale calchiamo i nostri corpi, le nostre esistenze e sussistenze.
Terra come materiali naturali ma anche artificiali che i nove artisti sanno scegliere, intrecciare, mettere in relazione, alla ricerca di una diversa alchimia che permetta loro di dire, mediante l’opera, il legame con il luogo in cui sono nati e cresciuti, naturale e antropizzato, violentato e sfruttato, abbandonato e salvato in extremis grazie alla speranza e alla volontà che nutre e s’annida nella loro ricerca artistica.
Eredi delle camminate della Land Art, provano il dissolvimento dell’oggetto artistico con azioni e materiali destinati a mettere a repentaglio le regole codificate dell’arte, a non durare in modo permanente e in forma stabile.
Fanno dell’opera un processo, e al contempo un monito-monumento: una denuncia.
Credono ancora all’opera come dato messo drammaticamente al mondo, come presenza che ci chiama a scegliere attraverso il guardare.
Nel grande murales di Federico Unia, che invade lo spazio esterno della galleria, l’ironia è graffiante sberleffo gettato in faccia ad un’umanità ancora scimmiesca, sorda e cieca che diligentemente spazza via i propri rifiuti, nascondendoli con idiota leggerezza sotto un manto erboso.
Benvenuti, dice Il più furbo di Federico Unia, guardandoci dritto negli occhi attraverso lo sguardo sbieco e ottuso del primate che persevera nella messa in ordine del dramma futuro, immagine a noi consegnata quale biglietto d’ingresso.
Le metamorfosi di Emanuele Magri, raccolte nella serie Botanico robotizzato, sono alchimie di ingegneria genetica complici di un processo “digerente” che dall’uomo va alla terra e da questa riparte: con una iconografia pop-surrealista, Magri assembla e con-fonde immagini umane e vegetali, animali e meccaniche, creando bucrani del XXI secolo, fitomorfi cadavres exquis passati sul tavolo anatomico e sotto i ferri della sua stridente pittura.
….
Girate, mie fami. Brucate
il prato dei suoni.
Succhiate il gaio veleno
delle campanule.
Questi artisti credono alla terra, la loro necessità di ricerca li spinge a tornarvi: non bloccano il ciclo delle cose, ma lo rincorrono famelici, lo attendono speranzosi, nel trascorrere lento, e incontrollabile, della vita che scorre nelle loro opere, nei materiali scelti, mettendo a repentaglio anche la stabilità di quelli artificiali attraverso il contatto con quelli naturali.
Così è nell’opera di Lisa Van Bommel, tedesca trasferitasi in Olanda, nell’opera Fallen into nothingness: le due grandi foglie di aloe diventano le sponde di un telaio, accolgono l’incessante movimento dei fili colorati che tracciano tessiture lievi come le relazioni tra uomo e natura.
La pianta dell’aloe, dai poteri benefici sull’uomo, è strumento e despota di un ricamo vitale.
Il fuso era lo strumento con il quale le tre Parche tessevano le nostre vite. Le loro decisioni erano immutabili: nel mito l’uomo mascherava la paura per la natura.
Lisa Van Bommel rimette in scena il rimosso: il mito torna natura. L’uomo torna alla grande madre .
Così anche Alberto Gianfreda: non so se i due artisti si conoscevano, prima di questo incontro, ma certo è che le loro due opere dialogano.
Assi di legno grezzo o riutilizzato e tessuti sono i materiali della grande scultura Ella si pungerà il dito con il fuso di un arcolaio e morrà che si impone nello spazio, chiedendo, come le morali delle favole alle quali allude il titolo, un rispetto riverente, e al contempo invitando a superare la barriera del divieto di non toccare il fuso. L’opera ci chiede di meditare, anche a costo di pungerci – di pungere le nostre coscienze – sul tema sociale del lavoro analizzandone illusioni ,crisi e pericoli .
Le sculture di Gianfreda mettono da sempre in luce tensioni spaziali, sfidano le leggi della gravità, fanno dialogare materiali diversi e spesso recuperati, in un gioco spietato che esaspera gli equilibri e le strutture delle opere, metafora del nostro incosciente sfidare la capacità di rigenerarsi della terra e delle sue energie.
….
Mangiate i ciottoli infranti,
le vecchie pietre di chiesa;
i sassi dei vecchi diluvi,
pani sparsi nelle valli grigie.
Arthur Rimbaud.
Nidi e culle di un segreto sapere, di una lotta eterna, sono le forme cui rimanda l’opera The Eternal Struggle di Cyryl Zakrezewsky, giovane artista polacco che nell’abbraccio di legno e resina affastella i pezzi del gioco degli scacchi, alfieri, torre regine e re, ammassati nello scacco matto della natura che li stringe in un abbraccio ribelle. Attraverso gli elementi che compongono l’opera, il giovane artista chiama in causa quella mossa del cavallo che Viktor Sklovskij definì strategia perfetta, azione laterale che scarta e obliquamente sorprende il lettore, l’avversario, lo spettatore; ma in Cyryl è anche la freschezza del linguaggio di un giovane artista che ammassa pezzi di un gioco nel cavo resinoso di un albero, nascondendo e svelando al contempo il tesoro, rivendicando la possibilità di creare, ancora, a partire dalla negazione di tutte le regole diligentemente apprese.
Daniele Salvalai, altro scultore presente in mostra, indaga sulle forme in natura e sulle forme create dall’uomo, misura del corpo e quella della terra: terra refrattaria, ferro saldato, legno, corde e chiodi sono i materiali dei suoi Cocoons, installazione che attraverso una forte espressione di violenza, manifesta i gesti di una civiltà aborigeno-primitiva.
I “bozzoli” di grillotalpa hanno il cuore trafitto da lunghi pali di legno, a testimoniare quella crudeltà inflitta ad un animale dannoso per le colture.
“Abitare” la natura-terra e confrontarsi quotidianamente con essa e con l’uomo è una sfida incessante . A intraprenderla sono questi piccoli animali che si trovano a lottare per la sopravvivenza.
Raffinatissima è la metafora di The origin of things -01 China con la quale Ren Ri, cinese, riesce a parlare della propria terra, del lavoro e della operosità del proprio popolo, ma anche delle barriere che questo ancora tende e non riesce ad abbattere. La dolcezza e la perfezione del materiale utilizzato e lavorato da Ren Ri, i favi delle api, stride con l’intensa drammaticità del messaggio lanciato che al problema delle nuove colonizzazioni unisce la questione della cultura di una civiltà millenaria carica di contraddizioni. Il pattern, nel muto e diverso ripetersi delle forme, contribuisce a creare nel pubblico un senso di ipnotica tensione e attrazione verso l’immagine-denuncia.
Diversamente ma con un’analoga forza ammaliante è il lavoro di Antonio Piga, lavoro minuzioso che rimanda al viaggio e all’identità primordiale. L’artista di origine sarda ricama a suon di colpi chirurgicamente sottili il supporto, cercando l’emergere di Paesaggi che sono corpi, di terre che sono epidermidi, di colline che sono seni e gambe mollemente stesi, primi uomini e prime donne di un mondo appena (ri)sorto, complice il fare dell’artista che, manualmente, ripercorre la tradizione elaborando il proprio futuro.

In ciascuno di questi linguaggi, è allora racchiusa la possibilità di un ritrovamento della relazione tra uomo e spazio, attraverso la riappropriazione della terra – ciascun opera vuole impossessarsi nuovamente dello spazio, quello fisico e psicologico, prenderne-esserne parte.
Valentina De’ Mathà ci racconta una storia: quella de L’uomo che piantava gli alberi, traendo ispirazione dall’omonimo racconto di Jean Giono. I nidi di carta cotone nei quali adagia i semi di fagiolo, innaffiandoli quotidianamente fino a vederne la trasformazione in piante, vengono infine decontestualizzati e ambientati in un bosco: l’opera processuale diventa parabola della simbiosi tra Uomo-Natura e Mutamento, i tre punti fondamentali sui quali si fonda la ricerca artistica di De’ Mathà, animata da uno sconfinato gesto di amore verso la Madre Terra, con dedizione e costanza assolute rivolta alle risorse e alle future generazioni che Essa accoglierà.
Un gesto d’amore che diventa processo creativo.
In tempi di crisi, di minaccia globale, di colonizzazione selvaggia, i nove artisti tornano alla terra, in essa creando.
Ilaria Bignotti
Valentina
De’Mathà
at the 54th
Venice Biennale

We are thrilled to report that Valentina De’Mathà has been invited to show in the Italian Pavilion at the 54th Venice Biennale. Her installation, “Silenzio” was featured in Issue One of See.7, which released in December 2010. She was also featured in one of our first blogs, where she describes her work.
Silence. White bodies that merge with the ground in a random order, as if nothing had a logical meaning. All bodies were born from a single array as we all were born from Mother Earth. I chose a neutral color, white, symbolizing a collective identity rather than individual. I chose paper because it is organic, like the human body it goes back to the earth that saw its birth. The silence after the earthquake of L’Aquila.
“Only when you drink from the river of silence shall you indeed sing. And when you have reached the mountain top, then you shall begin to climb. And when the earth shall claim your limbs, then shall you truly dance.” -Khalil Gibran, The Prophet
Silenzio. Corpi bianchi che si fondono con la parete in un ordine casuale. Tutti i corpi sono nati da un’unica matrice come noi nasciamo tutti dalla Madre Terra. Ho scelto un colore neutro, il bianco, a simboleggiare un’identità collettiva e non individuale. Ho scelto la carta perché è organica, come il corpo umano torna nella Terra che lo ha visto nascere. Il silenzio dopo il terremoto di L’Aquila.
“Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete davvero cantare. E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire. E quando la terra esigerà il vostro corpo, allora danzerete realmente.” -Khalil Gibran (Il Profeta)
See 7 Magazine
May 9.2011
Padiglione Italia:
L’Aurum di Pescara
ospita l’evento
Ideato e creato in onore dei 150 Anni dell’Unità d’Italia. L’arte italiana protagonista assoluta della Biennale. Valentina De’ Mathà presenta “Silenzio”, opera commemorativa delle vittime del terremoto dell’Aquila Photo Roger Weiss
Photo Roger WeissIl 5 Maggio è stato presentato il progetto “Padiglione Italia”, una straordinaria rassegna d’arte contemporanea nell’ambito della Biennale di Venezia, che non avrà sede soltanto all’Arsenale di Venezia, ma sarà allestita in molte regioni italiane, tra cui naturalmente l’Abruzzo. L’iniziativa è stata ideata e curata dallo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi, nata soprattutto come manifestazione celebrativa dei 150 Anni dell’Unità d’Italia.
Un evento che punta a rappresentare perfettamente la vitalità e il dinamismo dell’arte italiana, e ad incoraggiare l’investimento nei giovani artisti che spesso sono costretti a rinunciare ad un percorso artistico a causa delle pochissime opportunità professionali e agli ostacoli economici che ne scaturiscono. Il “Padiglione Italia” inoltre sarà ospitato in molti istituti di cultura italiani nel mondo, per abbracciare tutti coloro che amano l’arte del Belpaese e far sentire i nostri connazionali residenti all’estero vicini alla loro Terra nell’anno che celebra l’Anniversario dell’Unità.
Non mancheranno spazi appositi per gli artisti stranieri operanti in Italia. Anche la nostra Regione sarà protagonista di questo evento, il “Padiglione Italia” prenderà vita in tre sedi distinte: la Fortezza di Civitella del Tronto, l’Aurum di Pescara, e il Museo Santo Spirito di Lanciano, con cui si riaffermerà un’identità artistica abruzzese nell’ambito della Biennale di Venezia.
Tra i tanti artisti invitati sarà presente Valentina De’Mathà, che da sabato 25 Giugno esporrà un’istallazione scultorea intitolata “Silenzio”, un’opera dedicata alla sua Terra natale, l’Abruzzo. Un lavoro cui l’artista ha dedicato due anni di lavorazione, e che è composto da 308 corpi bianchi realizzati da un’unica matrice, che si fondono con la parete in un ordine casuale. Un’opera commemorativa delle 308 vittime del sisma che ha scosso L’Aquila, ma che ha devastato centinaia di famiglie.
L’abbiamo intervistata in quanto sarà certamente una delle protagoniste del “Padiglione Italia” – Regione Abruzzo:
Sig.ra Dé Mathà, quest’anno in occasione dei 150 Anni dell’Unità d’Italia, la Biennale di Venezia include una mostra dedicata agli artisti italiani e alla loro arte nel mondo. Quanto è apprezzata nel mondo l’arte italiana secondo la sua personale esperienza?
R – Quando si parla del mondo dell’arte ormai ci si riferisce solo ad artisti che hanno valenza internazionale e, di conseguenza, sono gli unici che vengono considerati internazionalmente. Gli artisti italiani che operano solo sul territorio italiano non sono presi in considerazione all’infuori di esso.
Vivendo in Svizzera da diversi anni, cosa le manca maggiormente dell’Italia dal punto di vista professionale?
R – Quando penso alla mia Italia penso con amarezza ad una Nazione che negli ultimi decenni è sempre meno in grado di valorizzare le proprie bellezze ed il proprio potenziale. Non dimentichiamo che il più grande esodo migratorio della storia moderna è stato proprio quello degli italiani. Del Bel Paese amo la varietà della sua sconfinata bellezza, soprattutto quella di Roma, il cibo, il calore delle persone, in alcuni casi il loro modo di arrangiarsi, gli incontri, il sole, la mia famiglia., è questo quello che mi manca della mia bellissima Italia.
In una cornice politica piuttosto frammentaria che in questo momento circonda il nostro Paese, l’Anniversario dell’Unità d’Italia è una grande occasione per riunire sotto le stesse emozioni un intero Popolo, quelle del nazionalismo e dell’amore per la propria patria. Quanto dell’arte che esprime nelle sue opere è frutto dell’amore verso la sua terra?
R – Credo fortemente nelle radici, nelle tradizioni e non mi sento di appartenere a nessun altro luogo all’infuori della mia Terra d’origine e questo, ovviamente, dà ulteriore linfa alla mia arte.
La sua opera è dedicata alle vittime del terribile terremoto che ha devastato L’Aquila, cosa ha provato nel realizzarla?
R – Quale artista italiana/abruzzese, mi sono sentita in dovere di commemorare le persone che hanno perso tragicamente la vita in un evento così imprevedibile e tremendo avvenuto proprio nella mia Regione. È stato un progetto molto sofferto, ma necessario. Ho cercato di trovare un senso alla tragedia, di capire, ma non è stato facile. Poi ho letto una frase di Khalil Gibran tratta da Il Profeta in cui parla della morte e ho cercato di mettere da parte il terrore che provavo. La frase in questione dice: “Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete davvero cantare. E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire. E quando la terra esigerà il vostro corpo, allora danzerete realmente”. È diventata la colonna portante del mio progetto.
La sua opera si intitola “Silenzio”, potrebbe descriverne la lavorazione e la realizzazione?
R – Ho lasciato che un’unica matrice di gesso abbia dato vita a 308 opere di carta, ognuna con un’ identità propria.
In quegli interminabili secondi che hanno scosso L’Aquila, che hanno strappato la vita a 308 persone, rovinandone migliaia ad amici e parenti, e lasciando un vuoto nell’anima di ognuno di noi, lei dove si trovava?
R – Ero in Svizzera, mio marito al mattino presto ha letto la notizia su internet ed è venuto a svegliami. Sono corsa immediatamente davanti al computer per vedere se era stata colpita anche la città dove si trova la mia famiglia, proprio a 50 km da L’Aquila, poi ho provato a contattare mia madre, ma sono riuscita a parlare con lei solo dopo qualche ora perché le linee telefoniche erano ancora isolate. All’inizio non mi ero ancora resa conto della gravità dell’evento. I giorni e i mesi a seguire sono stati peggiori. Per otto mesi ho vissuto nel terrore, non riuscivo più a dormire, avevo sempre il telefono vicino e passavo ore su internet per seguire gli svolgimenti. Non ho visto la mia famiglia per un anno perché mia madre ha voluto che rimanessi in Svizzera al sicuro dato che in Abruzzo non si capiva l’evolversi delle cose. I miei cari hanno avvertito ogni scossa e hanno dormito in macchina diverse notti a causa della loro continuità e del terrorismo che veniva diffuso tramite notizie fasulle. Non ho mai avuto tanta paura in vita mia e, per la prima volta, mi sono sentita davvero sola e impotente.
Il “Silenzio” che vuole descrivere è quello che ha immediatamente seguito gli attimi del terremoto? O è anche un silenzio che invita l’uomo alla riflessione del suo stato naturale, come essere a volte impotente di fronte alla forza della natura, che ci rende vulnerabili e che ridimensiona il nostro volere di onnipotenza?
R – Entrambe le cose. È sicuramente un silenzio di riflessione. Di fronte a certi eventi tutto cambia di significato ed è impossibile non ascoltare se stessi e mettere in discussione quanto ci circonda. Questo evento ha cambiato la mia vita, ho smesso di dare per scontate tante cose, ho ripercorso mentalmente il mio passato e ogni insegnamento e gesto della mia famiglia mi sono tornati in mente legandomi ancora più saldamente alle mie origini. Da lì sono nati anche altri progetti artistici come “Béance”, un lavoro che parla della teoria del filosofo e psicanalista francese Jacques Lacan sulla Mancanza-ad-essere, ovvero dei processi che avvengono nella vita di ogni essere umano dopo il distacco dal cordone ombelicale. Oppure “My House” in cui documento fotograficamente la mia casa dove sono nata in Abruzzo, uno spaccato tra passato e presente attraverso oggetti che hanno cambiato il loro uso, come i giocattoli che si sono trasformati in soprammobili, le foto della comunione vicino a quelle del matrimonio, l’immagine di Cristo poggiata su una poltrona e non appesa al muro, il tavolo intorno al quale si sono riunite tre generazioni.
Insieme a Lei moltissimi altri artisti Abruzzesi prenderanno parte a questa splendida manifestazione. Vi sentite espressione diversa di una stessa arte?
R – Sinceramente conosco ben pochi degli artisti invitati e, di conseguenza, non conosco il loro lavoro. Mi piace comunque pensare che tutti siamo diversi e sono curiosa di vedere il messaggio che gli altri partecipanti hanno deciso di inviare al mondo.
Quanto ad oggi la cultura estera influenza la sua ispirazione artistica?
R – Più che l’ispirazione io preferisco dire che alimenta il mio percorso artistico. È sicuramente cambiato il mio modo di vedere le cose e di esprimermi, è come se il mio lavoro vivesse una seconda fase. Prima la mia arte si nutriva delle persone, degli incontri, ora traggo nutrimento principalmente dalla natura, dai luoghi che esploro ma la base del concetto non è diverso, si evolve solamente. Mi affascina la simbiosi tra uomo, natura e mutamento. Il mio lavoro è una ricerca continua sul comportamento dell’uomo di fronte all’imprevedibilità ed ineluttabilità degli eventi e, di conseguenza, alle sue instabilità emotive e reazioni di fronte agli imprevisti e ai mutamenti improvvisi e inevitabili.
Oggi nel nostro Paese crede che ci sia una crisi di vocazione artistica oppure una mancanza di occasioni e di mezzi per esprimerla?
R – Al contrario, al giorno d’oggi in Italia più che in ogni altra Nazione, tutti “fanno gli artisti” ed è così saturo che manca di qualità. Oltretutto chi ha davvero qualcosa da dire non può farlo in Italia perché non viene ascoltato né capito e, di conseguenza, sostenuto come invece avviene in altre Nazioni, come ad esempio in Germania. Ripeto, gli artisti sono quelli che riescono ad avere consensi a livello internazionale e sono davvero pochi. Oltretutto l’Italia è molto indietro e di conseguenza, i presunti artisti che hanno visibilità nel territorio italiano non lo hanno internazionalmente perché non sono al passo con i tempi.
Se oggi dovesse esprimere un pensiero per le popolazioni colpite dal terremoto, a due anni di distanza, cosa direbbe?
R – Credo che tante parole non servirebbero o, più realisticamente, non basterebbero a dare un senso alla catastrofe, a dargli una colpa, a consolare i cuore di chi è sopravvissuto e ad infondergli nuovo coraggio e nuova speranza. Ognuno deve riuscire a trovare la propria verità.
L’Italia in questo 150esimo Anniversario dell’Unità ha riscoperto la voglia di essere una Nazione unita, con la stessa identità e senza divisioni. Quando all’estero si trova a collaborare con altri artisti italiani nota uno spirito patriottico, oppure assiste inesorabilmente ad una fuga di italiani all’estero in cerca di occasioni professionali e di vita migliori?
R – “Nemo propheta in patria sua”. Purtroppo è solo una fuga in cerca di migliori occasioni professionali anche se, a prescindere dal mal contento, è importante viaggiare molto e fare esperienza di diverse culture. In questo lavoro è fondamentale il confronto.
Oltre ad essere un’Opera in omaggio alle vittime del terremoto di L’Aquila, “Silenzio” rappresenta un’espressione spirituale di un certo spessore, in quanto richiama sculture di carta che si fondono con la parete in un ordine casuale, tutti i corpi sono nati da un’ unica matrice come noi nasciamo tutti dalla Madre Terra. L’opera è interamente in carta, materiale organico che subisce i cambiamenti del tempo e, come il corpo umano, torna nella Terra che lo ha visto nascere. Nella sua Opera vuole esserci anche un richiamo all’ecologia?
R – Se dovessi dire di lavorare esclusivamente con materiali ecologici mentirei perché non sempre è possibile. Lavoro molto anche con la fotografia e si avvale di processi chimici. Prediligo comunque materiali organici come la carta di cotone e i colori a base d’acqua. In concomitanza all’evento ho deciso di donare una delle sculture alla città di L’Aquila dove verrà posta in uno spazio all’aperto fino al suo completo deterioramento.
Se dovesse descrivere in un termine lo stato attuale dell’Arte in Italia, quale userebbe?
R – Potrei solo dire, con amarezza, che in Italia l’arte contemporanea rispecchia perfettamente la situazione politica della Nazione stessa.
Sign.ra De’ Mathà, le piacerebbe fare dei ringraziamenti particolari?
R – Ringrazio moltissimo mio marito Roger Weiss che cammina con me in ogni passo, ringrazio tutta la mia famiglia e Alessandro Allisio che mi sostengono e hanno collaborato per l’organizzazione, la città di L’Aquila che ha accettato l’Opera che ho voluto donargli, Gianluca Marziani che mi ha segnalata per la Biennale di Venezia e Abbiglieria di Avezzano che si è gentilmente offerta di curare il mio styling per il giorno dell’inaugurazione.
Un’ultima domanda: Lei ha votato negli ultimi quesiti referendari su acqua, nucleare e legittimo impedimento come cittadina residente all’estero?
R – Assolutamente si. Il nostro Inno Nazionale ci insegna che dobbiamo essere uniti, che solo in questo modo possiamo davvero cambiare le cose. Questo referendum è deplorevole, bisogna solo indignarsi e reagire!
L’inaugurazione della mostra avverrà sabato 25 giugno alle ore 21.00 presso l’Aurum di Pescara. Un’occasione imperdibile per apprezzare opere artistiche che danno un sapore particolare a questo assaggio d’estate abruzzese.
Juri Cardone
L’Opinionista
21.06.2011
http://www.lopinionista.it/notizia.php?id=702
Conversazione
con
Valentina
De’Mathà
photo by Sonia Ritondale
Maria Savarese: Sei nata ad Avezzano, poi ti sei spostata a Roma dove hai studiato all’Università La Sapienza, “Scienza della Moda e del Costume”, approfondendo contemporaneamente lo studio della scultura, fotografia, sceneggiatura cinematografica e incisione. Cosa hai conservato di quegli anni nel tuo percorso successivo?
Valentina De’Mathà: Uno dei tanti insegnamenti preziosi di mio nonno materno e di mio padre è quello di apprendere e saper fare molte cose e bene.
Tutto quello che ho imparato e che continuo a imparare serve a dar consistenza alla mia ricerca di vita. Ho studiato sceneggiatura cinematografica, anche se i miei video parlano di suoni, rumori, odori e immagini senza voce. La mia pittura è istintiva, veloce, immediata, eppure ho studiato cinque anni di iperrealismo. Tutto quello che ho fatto e che faccio serve ad arricchire il mio percorso, ma anche a capire meglio cosa voglio e dove voglio andare.
Tutto torna sempre utile in un modo o nell’altro, anche se in forme diverse.

MS.: A Roma sei stata assistente di un noto artista, come ti ha influenzata quell’esperienza?
VDM: Non sono stata una vera e propria assistente, è stato un incontro e uno scambio durato un breve lasso di tempo, assolutamente tra i più preziosi e rilevanti che io abbia mai vissuto e che custodisco gelosamente.
Ero molto ricettiva a ogni suo input. Ogni cosa, ogni parola erano dei forti stimoli che mi aprivano mondi nuovi e che esploravo con le pupille dilatate e la determinazione di un animale. Mi ha caricata di forte energia ribaltando completamente il mio stile di vita.
Tutto è diventato possibile e tutto è diventato più limpido.
Cambiando la mia vita e le mie abitudini è cambiato radicalmente anche il mio lavoro e, la forma espressiva che mi aveva avvicinata a lui poi, paradossalmente, è diventata completamente estranea e lontana da me. Quello che mi ha insegnato è stato importante umanamente, a prescindere da come lui me l’abbia insegnato e da come io l’abbia appreso.
Quando penso a lui penso alla sua energia più che alla sua arte.
Quello che sono e sto divenendo è la somma degli incontri e scambi che ho vissuto e che vivo e questo è stato uno dei più importanti.
MS: Ci sono state delle persone che ti hanno supportata nella ricerca del tuo talento, che ti sono state da stimolo?
VDM: Sì, moltissime, ma senza saperlo, sono io che ho catturato ciò che mi nutriva e stimolava.
MS: Quale artista ha influenzato in qualche modo il tuo immaginario, la tua ricerca? Chi è il tuo prescelto se dovessi fare un nome…
VDM: Non ho mai avuto dei veri e proprio punti di riferimento, mi capita semmai di apprezzare alcuni progetti, alcune opere singole, o più nello specifico, l’energia che una determinata Opera emana, che sia musicale, visiva, tattile, olfattiva, sonora… non ha importanza. La mia ricerca si nutre del quotidiano.
Le persone, la Terra, gli incontri, i cambiamenti del corpo, i tempi… sono questi i miei punti di riferimento.
MS: Quali i tuoi registi preferiti?
VDM: La poesia e l’arte pura di Andrej Tarkovskij.
MS: L’ultimo libro che ti ha rapita?
VDM: Mi interessa la cultura latina americana in generale, dalla musica, alle tradizioni, al cibo, i colori… la scrittura di Gabriel Garcia Marquez rimane una delle cose più belle e visionarie che io abbia letto, ma credo che uno dei libri che abbia sentito più intimamente mio è “L’insostenibile leggerezza dell’Essere” di Milan Kundera.
MS: Spazi dalla pittura, alla scultura, dall’ installazione al video: quale di questi media senti a te più congeniale, quello che meglio riesce a veicolare il tuo “sentire” in questo momento?
VDM: In genere parto da un concetto, scrivo una stesura iniziale e poi comincio a elaborare il progetto e a realizzarlo con il media o i media più appropriati. Lavoro tutti i giorni tutto il giorno e lo faccio con estrema passione e impeto, ma anche in modo lucido.
Quando abbiamo deciso di rivoluzionare il progetto che avevo inizialmente studiato per questa esposizione da e incentrare tutto sulla pittura ho cominciato un po’ a vacillare.
Non mi sono sentita insicura ma vulnerabile, in qualche modo emozionata. La pittura ha bisogno di tempi diversi, di energie diverse, di grandi conflitti e intimità. Con la pittura non riesco a essere completamente distaccata perché mi destabilizza e, contemporaneamente, mi rende fortemente energica. È la parte più “animale” di me e attraverso la quale mi guardo allo specchio.
MS: Dinamismo, metamorfosi, mutamento, sono alcuni nuclei concettuali intorno ai quali ruota la tua ricerca artistica, forme in divenire. Non sei interessata alla forma chiusa, determinata una volta per tutte, bensì alla capacità metamorfica che la stessa acquisisce nel tempo. Quale importanza ha la dimensione temporale nei tuoi lavori?
VDM: La mia ricerca è basata sulla simbiosi tra Uomo, Natura e Mutamento e sulla Causa-Effetto degli eventi. Mi interessa il comportamento dell’uomo di fronte all’imprevedibilità delle circostanze ineluttabili o causate da egli stesso e, di conseguenza, le sue instabilità emotive e reazioni di fronte agli imprevisti e ai mutamenti improvvisi e inevitabili. Non escludo le forme chiuse, basta che abbiano delle linee curve. Mi piace aprire parentesi veloci ascoltando i tempi lenti della natura.
MS: Ma veniamo a questa tua prima personale napoletana che è conseguenza della tua partecipazione al Premio Internazionale Arte Laguna.
Innanzitutto raccontami la tua esperienza nell’ambito di questa partecipazione.
VDM: Ho partecipato con un’installazione intitolata “L’Uomo che Piantava gli Alberi”, un progetto tratto dall’omonimo racconto di Jean Giono. Una parabola sulla simbiosi tra Uomo – Natura e Mutamento, i tre punti fondamentali su cui è basata tutta la mia ricerca artistica, incentrato su un incondizionato e sconfinato gesto di amore, generosità e immutabile costanza. Il progetto è stato selezionato per far parte dei finalisti e, durante la serata di premiazioni presso le Nappe dell’Arsenale di Venezia, mi sono stati conferiti due premi speciali da Amy-d Arte Spazio di Milano e Dafna Home Gallery di Napoli.
MS: Tra i lavori presenti in questa mostra dal titolo Corpi Rossi hai scelto di presentare l’installazione a parete Untitled #09. Un’opera ottenuta grazie alla manipolazione della carta Nepalese. Perché hai scelto proprio questo materiale? Per te cosa rappresenta? Quali sono le sue caratteristiche? Come si accorda con i lavori in acquerello?
VDM: Il 90% del mio lavoro è incentrato sulla carta.
Spazio dalla carta di cotone a quella Nepalese, a quella emulsionata, dipende da quale mi permette di risolvere al meglio il progetto.
In questo caso sulla carta di cotone bianca ho dato forma alle linee dei corpi e alla loro carne attraverso l’uso del colore, la carta Nepalese invece ha già in sé infinite striature e particolari che sono in grado di simulare la pelle del corpo umano. Nell’installazione Untitled #09 la parete è il foglio bianco e con la stoffa e la carta Nepalese ho tirato fuori tridimensionalmente quello che ho rappresentato con l’acquerello sulla carta di cotone.
Lo sfondo non fa parte di una narrazione, preferisco non dare dei riferimenti precisi, ma pongo il corpo al centro dell’universo affinché ottenga maggiore potere.
MS: Il caso e l’imprevedibilità giocano un ruolo determinante nella tua prassi artistica, o procedi in maniera controllata, sai già aprioristicamente cosa otterrai, e quel che ottieni poi coincide perfettamente con ciò che avevi in mente?
VDM: Questo lavoro è basato sulla simbiosi, lo scambio e il dialogo tra quello che io posso dare alla materia (lo stimolo) e quello che la materia può darmi di risposta.
Causa – Effetto.
Una goccia di colore che cade su un foglio bagnato si propaga creando degli schemi frattali che si susseguono l’un l’altro e che a volte si schiantano in forze opposte e si scompongono diversamente, altre volte ancora stagnano fino a creare delle corrosioni, delle cicatrici, dei segni, delle cancrene. La vita di ogni essere umano ha delle tappe prestabilite: nascere, mangiare, camminare, parlare, crescere… A me interessano gli imprevisti, la causa-effetto degli eventi, la rottura di questi schemi frattali, ciò che si trova tra due punti fissi in movimento.
MS: Quale distinzione c’è tra caso e casualità?
VDM: In spagnolo ci sono 2 modi per definire il “Caso”. La parola “causalidad ” si riferisce a qualcosa che in qualche modo viene indotto da noi (Causa-Effetto), quindi, paradossalmente, la vera casualità è nulla. Con la parola “Azar” invece viene definito qualcosa di ineluttabile. Evidentemente il mio lavoro è incentrato sulla prima definizione. La seconda mi terrorizza.
MS: Perché per i lavori che qui presenti, hai scelto la tecnica dell’acquerello ed il rosso? Che tipo di colore specifico e il perché di questa scelta?
VDM: L’acquerello perché è strettamente legato al concetto di casualità e mutamento, il Perylene Maroon e il Rosso d’Oriente per avvicinarmi il più possibile al sangue e alla carne dei corpi.
MS: questi corpi sono senza testa. Sfaldati, amputati, deformi ma vibranti di energia. Per te cosa rappresentano?
VDM: Sono come degli involucri che racchiudono una miriade di informazioni e di input, come degli Haiku che concentrano un’infinità di significati attraverso un procedimento formale apparentemente essenziale.
I corpi che si contorcono sono solo la conseguenza di ciò che la mente gestisce. Queste gestazioni, questi ventri gonfi, sono semplicemente la cristallizzazione di un processo, e dire qualcosa intorno all’anima è dire qualcosa di profondo sul corpo. Siamo quello che facciamo, processi.
MS: Quand’è che decidi che un’opera è finita, e non continui a lavorarci con la materia, con il colore, per non rischiare di cesellare eccessivamente e quindi, appesantire…
VDM: Non esiste un momento preciso, definito, è lei che te lo dice. A volte però non puoi fare a meno di non continuare a lavorarci su fino a “cesellare” la carta, fino a vedere cosa succede quando decidi di spostare il tempo. Come in un rapporto interpersonale o come quando si spinge se stessi oltre per vedere cosa succede e come ci si sente. A volte i risultati sono sorprendenti.
MS: Questi lavori mi ricordano gli acquerelli di Schiele, deformi, imperfetti, vibranti, intensi; così come certa pittura cinese, secondo la quale il tratto, la forma, la figura devono riuscire subito al primo gesto, per non rischiare di compromettere il fragile supporto, per cui essa è concisa, immediata, densa.
Quale rapporto hai con il pensiero orientale?
VDM: Ascolto molto il mio corpo e la natura delle cose che mi circondano. Cerco di assecondare i giusti tempi di ogni cosa. Credo nel divenire delle cose, nel percorso naturale delle cose, anche se a volte creo delle fratture, degli scontri o sovrapposizioni infilandomi dentro ad alcuni percorsi dando vita a qualcosa di nuovo attraverso una visione dialettica
MS: Un progetto ambizioso che ti piacerebbe realizzare?
VDM: Moltissimi! Ho quaderni interi di progetti già studiati nei minimi particolari e che continuo a elaborare. Usciranno fuori quando sarà il tempo giusto.
Uno di questi lo realizzerò la prossima primavera durante la mia personale presso la Limonaia di Villa Saroli del Museo D’Arte di Lugano.
MS: Perché sei andata a vivere in Svizzera?
VDM: Perché avevo voglia di vivere altro e perché ho sposato un fotografo svizzero,
MS: Quale pensi sia la funzione dell’arte oggi? E quale la funzione dell’artista?
VDM: Mi piace citare Tarkovskij che diceva che il compito dell’Arte è quello di spiegare a se stessi e a chi ci sta intorno perché vive l’uomo, qual è il significato della sua esistenza, o, se non di spiegarlo, quantomeno di porre loro delle domande. La funzione dell’arte consiste nell’idea della Conoscenza, dove la percezione si esprime nella forma dello svolgimento, della catarsi.
MS: Se dovessi scegliere tre parole che possano descrivere il tuo modo di stare al mondo?
VDM: Pancia, Terra, Me Stessa.
Maria Savarese
Biennale di Venezia. Valentina De’ Mathà al Padiglione Abruzzese: l’intervista

Ecco cosa vedete, nascosti dietro al vetro a specchio. In una stanza metafisica, bianca come uno spazio espositivo, io e l’artista Valentina De’Mathà ci sediamo ad un tavolo candido, sul quale è adagiato un niveo foglio.
Io scrivo una domanda, e in silenzio passo il foglio a Valentina. Lei scrive la risposta, piega la parte superiore della carta in modo che non sia leggibile e mi ripassa il foglio.
Alla ventesima domanda Valentina si alza ed esce. Anche io faccio lo stesso, ma prima apro il foglio e ve lo attacco, dal verso leggibile, al vetro specchio.
C’è scritto questo:
Cosa c’è sotto?
Il caso che non esiste.
Perché vivi in Svizzera?
All’inizio perché ho improvvisamente sentito la necessità di staccarmi dall’Italia e soprattutto da Roma, verso la quale avevo un attaccamento morboso. Quindi, al culmine di questa morbosità, ho deciso di tagliare il cordone ombelicale e fuggire via senza guardarmi indietro, ma soprattutto perché mi sono resa conto, con estrema lucidità e amarezza, che l’ Italia non sarebbe stata in grado di darmi le opportunità professionali, il sostegno e i confronti di cui avevo bisogno, e che avrei trovato solo viaggiando.
Non era mio obiettivo trasferirmi in Svizzera, anzi, ma dieci giorni prima di partire verso Berlino ho conosciuto Roger Weiss, fotografo svizzero, colui che poi è diventato mio marito.
Ho visto artisti che sulla carta d’identità hanno scritto “artigiano”, tu invece?
Ho solo il passaporto.
L’hai mai presa la carta d’identità?
Mai.
Ti piace, intendo proprio come parola, “identità”?
Assolutamente sì. Credo fortemente nelle origini.
Cosa ti interessa di più nel tuo fare arte, la sincerità o la mistificazione?
Questo lavoro è così intimo che non si può non essere sinceri.
Il corpo, il tuo, quello degli altri, la natura e la banda degli dei. Come entra tutto questo nel tuo lavoro?
Il mio lavoro è una ricerca continua sul comportamento dell’uomo di fronte all’imprevedibilità ed ineluttabilità degli eventi e, di conseguenza, alle sue instabilità emotive e reazioni di fronte agli imprevisti e ai mutamenti improvvisi e inevitabili.
Il corpo riprodotto è solo la conseguenza di ciò che la mente gestisce.
Quanto di sociale e quanto di glamour c’è in quello che fai?
Mi interessa la simbiosi tra uomo, natura e l’eterno mutamento.
C’è un criterio unico che il tuo fruitore ideale dovrebbe adottare, al di là dell’apertura dell’opera, nell’interfacciarsi con i tuoi lavori?
I miei lavori nascono per essere lasciati liberi di creare intrecci slegati da me in quanto artista.
Veniamo alle note dolenti: la Biennale d’Arte di Venezia, il Padiglione Italia… Quanto riesci ad essere diplomatica parlandone?
È così facile far polemiche su questa Biennale che lascio siano gli altri a farle.
Per quanto mi riguarda posso solo dire che lo spazio e l’allestimento del Padiglione abruzzese all’Aurum di Pescara siano i migliori di tutto il Padiglione Italia. Purtroppo in Italia è prassi che si focalizzi l’attenzione solo sulle cose che non vanno anziché valorizzare ciò che c’è di positivo.
Raccontami un po’ il lavoro che hai portato. Senza descriverlo, possibilmente.
È un opera commemorativa delle 308 vittime del tragico terremoto che il 6 aprile 2009 ha devastato L’Aquila.
È un’installazione scultorea intitolata Silenzio e parla del silenzio dopo il boato del terremoto e delle case che sono crollate frantumandosi in macerie, il silenzio dopo le grida di terrore, ma anche un silenzio di riflessione.
Davanti a queste catastrofi non si rimane indifferenti e tutto assume un altro valore, tutto cambia di significato. L’opera invita al silenzio come segno di rispetto, ma anche ad un silenzio meditativo.
L’intento principale di questo lavoro è stato che tutti i corpi nascessero da un’unica matrice come noi nasciamo tutti dalla Madre Terra, che fossero composti da un materiale organico che, come il corpo umano, subisce i cambiamenti del tempo e torna nella Terra che lo ha visto nascere e, per questo, ho scelto la carta. Oltretutto ho ritenuto importante usare un colore neutro come il bianco a simboleggiare un’identità collettiva e non individuale. È un’installazione su cui sto lavorando da circa due anni per via del numero elevato – 308 – di sculture e dei tempi di lavorazione.
In concomitanza alla Biennale ho donato una delle sculture dell’installazione alla città di L’Aquila con l’Assessore Pierluigi Pezzopane a rappresentare la città e Dario Pallotta come padrino d’eccezione, rugbista dell’Aquila Rugby e colui che, nella tragica notte del terremoto, ha salvato la vita a diverse persone.
L’opera è stata posta sotto i Portici di corso Vittorio Emanuele, angolo Piazza Duomo e sarà presente fino al suo completo deterioramento, alla base è stata posta una targa commemorativa.
Che relazione ha con la tua produzione precedente?
Tutti i miei lavori sono legati l’un l’altro da un filo conduttore, questo esposto alla Biennale di Venezia è un ulteriore passo avanti della mia ricerca di vita.
Cosa significa per te la Biennale adesso?
Ho creduto che l’invito al Padiglione Italia in Abruzzo della 54a Biennale di Venezia e il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, quale titolo del Padiglione stesso, fossero l’occasione migliore per dare il giusto peso a questo progetto incentrato sulla mia Terra e che era mio obiettivo esporre proprio in Abruzzo.
Per quanto mi riguarda non intendo sminuire questa Biennale, anzi, provo un grande rispetto per quello che rappresenta e mi fa piacere che Gianluca Marziani mi abbia segnalata.
Ti esprimi con vari mezzi. Al quale ti sei avvicinata prima, e come?
Ho iniziato a 4 anni a dipingere e lavorare con l’argilla, a 11 a fotografare. Dei primi due mi stregava e attraeva l’odore e la matericità. Invece sono assolutamente ossessionata dalla fotografia ed è l’unico mezzo di cui non credo che potrei fare a meno.
Con quale di questi ti trovi più a tuo agio?
Dipende da quale di questi mezzi mi permette di esprimere in modo più efficace i progetti che costituiscono la mia ricerca. Quello che mi interessa è la qualità del risultato finale, per questo cerco di non pormi mai dei limiti.
Come vivi i luoghi?
Con viva curiosità e alcuni con totale chiusura e ostilità, di conseguenza con vie di fuga.
Come vivi il tempo?
Di corsa e con impazienza.
Come vivi il vivere qualcosa?
Con tanta fame.
L’estetizzazione della vita. Molti ci cadono e diventano stranieri. Tu?
Sono alla ricerca dell’Essenza.
E poi, in fin dei conti, perché?
Per una più alta consapevolezza dell’Essere.
di Naima Morelli
Art a Part of cult(ure)
22 Luglio 2011
Valentina
in Venice
We last updated you that Valentina de’Mathà had been chosen to participate in the 54th International Art Exhibition Venice Biennale Pavilion Italy/Abruzzo. Her piece, Silenzio, was featured in the first print edition of See.7. We were thrilled to get a few images from the actual show, including a few behind-the-scene looks at putting the installation together. Congratulations!
See.7 Magazine NY
July 6.2011
“Il Padiglione Italia?
Mi interessa esporre
la mia opera
e in Abruzzo”
Il sì “a prescindere”
di Valentina
De’Mathà
Photo Roger Weiss
Una nuova chiave di lettura, nella querelle cresciuta sulle pagine di Artribune fra gli artisti che all’invito di Vittorio Sgarbi per il Padiglione Italia alla Biennale hanno detto no – la maggior parte degli intervenuti -, e quelli che invece parteciperanno, e spiegano il perché. C’è anche chi sceglie di non entrare nelle polemiche, per far parlare la sua arte. È Valentina De’ Mathà, che ha visto nell’invito un’occasione per presentare la sua opera dedicata al terremoto che ha devastato il suo Abruzzo. Sgarbi o non Sgarbi…
Il mio percorso verso la 54a Biennale di Venezia è iniziato quando, mesi fa, sono stata contattata da Arthemisia Group e segnalata dal critico e curatore Gianluca Marziani per far parte del Padiglione Italia/Regione Abruzzo.
All’inizio pensavo che mi avessero contattata per affidarmi lo spazio dell’Istituto di Cultura Italiano a Zurigo, visto che ormai abito in Svizzera da diverso tempo, ma ho accettato con piacere la dislocazione in Abruzzo e ho trovato nella 54a Biennale di Venezia e nel 150° dell’Unità d’Italia, tema del Padiglione, l’occasione ideale per poter ricordare, attraverso l’installazione scultorea intitolata “Silenzio”, il tragico terremoto che ha devastato il 6 aprile 2009 la città di L’Aquila. “Silenzio” vuole essere un’opera commemorativa delle 308 vittime del terremoto. Un progetto che parla della mia Terra, l’Abruzzo.
Mi è sembrato importante e doveroso per me, artista italiana/abruzzese, ricordare un avvenimento così grave che ha scosso l’ intera Nazione… e non solo. Certi eventi non ti lasciano indifferente e tutto cambia di significato, tutto assume un altro valore. Il mio lavoro è una ricerca continua sul comportamento dell’uomo di fronte all’imprevedibilità degli eventi e, di conseguenza, alle sue instabilità emotive e reazioni di fronte agli imprevisti e ai mutamenti improvvisi.
In “Silenzio” ho voluto raccontare la drammaticità della catastrofe attraverso fragili sculture di carta nate tutte dalla stessa matrice. Un lavoro molto lungo che ho iniziato circa due anni fa e sul quale ancora sto lavorando, infatti ogni scultura ha bisogno di 2-3 giorni di lavorazione. L’installazione completa comprende 308 corpi bianchi (93x28x12) che si fondono con la parete in un ordine casuale. Tutti i corpi sono nati da un’unica matrice come noi nasciamo tutti dalla Madre Terra. Ho scelto un colore neutro, il bianco, colore dell’assenza e, in contrapposizione, della pienezza, a simboleggiare un’identità collettiva e non individuale. Ho scelto la carta perché è organica, perché subisce i cambiamenti del tempo e, come il corpo umano, torna nella Terra che lo ha visto nascere.
È un’installazione che incita al silenzio, al rispetto e ad ascoltarsi. Il silenzio, appunto, dopo il terremoto di L’Aquila. Per motivi di spazio purtroppo l’installazione è stata frammentata e sarà presente solo una parte di essa. L’opening sarà sabato 25 giugno alle ore 21 presso l’Aurum di Pescara in via D’Avalos angolo Luisa D’Annunzio.
In concomitanza all’evento è mia intenzione donare una delle sculture alla città di L’Aquila dove, la scultura, verrà esposta in uno spazio esterno subendo le intemperie e lo scorrere del tempo fino al completo deterioramento.
Artribune
31.05.2011
http://www.artribune.com/2011/05/%E2%80%9Cil-padiglione-italia-mi-interessa-esporre-la-mia-opera-e-in-abruzzo%E2%80%9D-il-si-%E2%80%9Ca-prescindere%E2%80%9D-di-valentina-de%E2%80%99-matha/
Valentina
De’Mathà
Il disfacimento della natura
Photo Roger Weiss
“Entropia”, la nuova mostra (15 aprile–14 giugno 2013) alla Limonaia di Villa Saroli è visibile, annusabile, e potremmo dire anche commestibile. Valentina De’Mathà presenta un tavolo sontuosamente imbandito e decorato con fiori e frutta…in attesa di invisibili commensali.
« La ricerca di Valentina De’ Mathà sin dagli esordi indaga i rapporti dinamici e instabili dell’uomo e della natura nella prospettiva del mutamento, andando a ricercare quelle leggi di causa ed effetto che regolano le oscillazioni e le metamorfosi di questi due poli.
In quest’installazione presentata al Museo d’Arte di Lugano, l’artista ancora una volta, focalizza la sua attenzione sulla natura, chiedendone in prestito i materiali: terra, frutta, vino, acqua, cibo, ben disposti nei piatti e di cui ne studia meticolosamente la composizione, caratterizzata da efficaci rapporti di forme, luce e colore, riuscendo così a condurre lo spettatore in uno stato di raccolta contemplazione, e al tempo stesso producendo uno stato sinestetico fra i diversi ambiti percettivi, quello olfattivo, tattile e visivo.
Una tavola dei sensi, dunque, dove i concetti di caducità e transitorietà legati alla marcescenza dei frutti, si fondono al concetto di rinascita rievocato dai fragili germogli che abitano i piatti.
Costruita su gruppi binari, fra la vita e la morte, l’inizio e la fine, ma soprattutto sulla metamorfosi degli elementi e l’eterna danza del disordine entropico, quest’opera suggerisce un riconoscimento dei processi che ci sono fondamentali.
Quasi un contraltare al genere della “natura morta”, quella della De’Mathà è una “natura viva” che esprime il senso della vita, il rispetto per la temporalità naturale e i suoi cicli, l’accettazione totale dell’eterna ruota della vita e della morte. » Scrive Maria Savarese sul catalogo della mostra “Entropia” edito da Sottoscala Edizioni.
E continua Ignazio Licata, fisico teorico «Non è “mangiare” il nostro problema. Mangiare è sempre qui e ora, e noi non siamo fatti per l’istante. Noi abbiamo bisogno di nutrimento, che è il rapporto con la Madre Terra e con lo spirito, nella comprensione dell’intimo legame tra le due cose. Il cibo è uguale per tutti, il nutrimento è diverso. E’ un patto con il mondo e con la terra. E’ vivere, ma anche accettare che ogni atto di nutrimento si trasforma in tempo e il tempo ci conduce alla morte, alla fine l’entropia ha il sopravvento e ci disperdiamo come materia dis-organizzata. Alla fine, noi ci nutriamo di significati, e moriamo di significati. E i significati restano, in qualche modo, come opere o figli, a testimoniare che non eravamo parassiti, ma ciclo vitale…»
Valentina De’Mathà non è nuova a provocazioni capaci di lasciare gli spettatori attoniti e confusi. È stato così, per esempio, in occasione della 54° Biennale di Venezia 2011, quando lei, di origine abruzzese, ha presentato un’opera commemorativa delle 308 vittime del tragico terremoto che il 6 aprile 2009 ha devastato L’Aquila. Un’installazione scultorea intitolata “Silenzio” che parla del silenzio dopo il boato del terremoto e delle case che sono crollate frantumandosi in macerie. Il silenzio dopo le grida di terrore, ma anche un silenzio di riflessione. «Davanti a queste catastrofi – spiega Valentina – non si può rimanere indifferenti e tutto assume un altro valore, tutto cambia di significato. L’opera invita al silenzio come segno di rispetto, ma anche ad un silenzio meditativo».
Quali sono le tematiche intorno a cui ruota principalmente il tuo lavoro?
« La mia ricerca è basata sulla simbiosi tra Uomo, Natura e Mutamento e sulla Causa-Effetto degli eventi, sul comportamento dell’uomo di fronte all’imprevedibilità delle circostanze ineluttabili o causate da egli stesso e, di conseguenza, sulle sue instabilità emotive e reazioni di fronte agli imprevisti e ai mutamenti improvvisi e inevitabili. Mi interessa tutto ciò che è in divenire e che si muove, anche se poi cerco di fermarlo e catturarlo attraverso il mio lavoro…»
Come è nata la tua decisione di trasferirti in Svizzera?
«Ho abitato nel cuore di Roma fino a 5 anni fa, città alla quale mi sento ancora fortemente legata, ma ad un certo punto ho sentito il bisogno di staccarmi e confrontarmi con altre realtà più da vicino. Non avevo progettato di trasferirmi proprio in Svizzera, ma tutto è venuto in modo naturale dopo l’incontro con mio marito Roger Weiss, fotografo svizzero. Roma è una città piena di stimoli, di input, la qualità della vita, del cibo, il contatto umano con le persone, la ricchezza artistica che la caratterizzano sono introvabili in altri luoghi. La realtà qui in Svizzera è molto diversa, così come lo sono gli input e questo ha cambiato radicalmente il mio lavoro, il quale è diventato più contemplativo e concettuale e più leggero e pulito nella forma. »
Fame di Terra
Visiti la collettiva Fame di terra negli spazi espositivi di Amy-D Arte Contemporanea e pensi a Joseph Beuys. A quel valore politico, nel senso originario del termine, che è il valore aggiunto di un’esperienza artistica. Che non si ferma all’approccio con l’opera fatta e finita, sia essa un oggetto bidimensionale, tridimensionale, un video o una performance, ma la supera a partire da essa e per mezzo di essa, essendo l’oggettivazione di un pensiero complesso che utilizza il linguaggio dell’arte visiva per farsi percepire sensibilmente.
L’arte può essere “impegnata” oppure no. Paradossalmente, l’approccio metateorico – cioè critico – all’esperienza artistica ha da essere avalutativo: tutte le produzioni artistiche stanno sullo stesso piano e gli scatoli di Andy Warhol non sono meno importanti della video installazione Terremoto in palazzo di Joseph Beuys. Differenti approcci al contemporaneo, tutto qui. Lo stesso raffronto vale, per parlar dei vivi, fra la produzione di un Alfredo Jaar e una qualsiasi mostra da Francesca Minini. Perché l’arte è sempre contemporanea, per chiosare l’impopolarissimo – almeno qui, nel piccolo mondo antico dell’arte contemporanea – Littorio Sgarbi.
Tutta l’arte parla a noi di noi, perché l’arte è fedeltà al presente (e, nel caso dei superdotati, preconizzazione del futuro). Se così non fosse, sarebbe una pratica autoreferenziale e a noi, degli egotisti, non ce ne frega un cazzo.
La collettiva in corso da Amy-D risponde a un quesito che solo da pochi anni si fa strada nel dibattito politico e in senso lato culturale: dopo il boom dell’economia globalizzata, che fare?, come disse il compianto Lenin. Le risorse, finanziarie ma anche naturali, non sono inesauribili e per evitare l’assalto alla diligenza una strategia da seguire potrebbe essere quella suggerita recentemente dal sociologo Mauro Magatti. Il quale parla specificatamente della terra nell’era della tecnica – la famigerata tecnica con cui Martin Heidegger non fu certo tenero – intesa come comunità culturale che ricompone la tecnica con la cura dell’umano, il dinamismo dell’economia con lo sviluppo sostenibile, l´efficienza con l´affettività, la crescita con il limite (che è il limite determinato dalla libertà di tutti, ça va sans dire). Il punto della situazione è insomma questo: nel contesto di una crisi – e in sé la crisi denota trasformazione, cambiamento – urge una nuova produzione di valore che trascenda l’aspetto meramente economico, per fermarsi su quello che, in un mondo aperto e dinamico, è invece il bene comune. Scrive Mauro Magatti:
«Nel mare tecnico la terra “emerge” là dove si rende di nuovo possibile la vita umana associata, mettendo la tecnica al servizio dei suoi abitanti» (La Repubblica, 23 maggio 2012)
Del resto, come disse Henry Ford, idealtipo del padrone delle ferriere:
«It is well enough that people of this nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe that would be a revolution before tomorrow morning».(Se il popolo comprendesse il nostro sistema bancario scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina).
Fame di terra è dunque una collettiva che risponde in pieno a un’urgenza pressante del contemporaneo e ciascuno degli artisti coinvolti nel progetto ha fornito il proprio mattone per edificare quella che è non una protesta ma una proposta, secondo la specificità e l’originalità di ognuno dei mezzi espressivi individuati e singoli utilizzati. Fra le opere in mostra – e senza con ciò stesso mancar di rispetto ai non citati: la critica sarà pure avalutativa, ma è fatta anch’essa di carne e sangue – vale sicuramente la pena segnalare la proposta di Lisa van Bommel, fatta di elementi organici e inorganici (filo e agave) che come un telaio si dipanano sulla parere dello spazio espositivo ricordando per certi versi le sperimentazioni di Christiane Löhr con le sue crine di cavallo, e quella di Daniele Salvalai, che usando ferro, terra e legno ha realizzato un’installazione che ci fa riandare col pensiero a Mp & Mp Rosado. Per non parlare di Valentina De’ Mathà, autrice di un’installazione a parete in cui microcosmo e macrosocmo si fondono in un’unica opera, e di Emanuele Magrì, che nel suo apparato iconografico interpreta in maniera scanzonata il mainstream relativo alle derive delle pratiche transgeniche odierne.
Una mostra coraggiosa, con opere non facili e nella più parte dei casi “impegnative”, diciamo, destinate a una collocazione museale o aziendale piuttosto che alle stanze di un appartamento privato. Del resto, l’arte in sé, come la filosofia, mica è un pezzo facile.
Lisa van Bommel, Valentina De’Mathà, Alberto Gianfreda, Emanuele Magri, Antonio Piga, Ri Ren, Daniele Salvalai, Federico Unia, Cyryl Zakrzewski – Fame di Terra. Riflessione a più mani
Progetto economART di AMY d arte spazio & Laboratorio Alchemico – Milano
dal 7 giugno al 21 luglio 2012
Emanuele Beluffi
ArtsLife
10/07/1012
http://www.artslife.com/2012/07/10/fame-di-terra-da-amy-d-arte-spazio/
Quando scienza e arte… non si guardano in cagnesco
Se qualcuno vi dicesse che l’artista contemporaneo può essere solo di due tipi, l’ispirato dalle chiome scapigliate (un Tranquillo Cremona postmoderno) oppure uno scienziato metodico che prende una notevole distanza di sicurezza dalle opere (tra i reduci della fu scuola di Piazza del Popolo, Roma anni ’60, abbiamo un Sergio Lombardo, per esempio), non dovete credergli.
Egli mente, oppure semplicemente non considera la poderosa gamma di sfumature tra i due estremi.
Si dal caso che sfogliando la palette cromatica, incappiamo in Valentina De’Mathà, oltre a dipingere e bere tè in nazionalistiche tazze con una croce svizzera sopra, nelle sue svizzere latitudini, è anche vincitrice di un concorso chiamato Research in Art, bandito dalla belga Atonium Culture.
Per spiegarvi di che si tratta prenderò un tono serio e compito: “Atonium Culture è una piattaforma che riunisce 26 università, più di 100.000 ricercatori, più di un milione di studenti, 17 quotidiani, circa 10 milioni di lettori europei al giorno, e alcune delle più importanti aziende in Europa con un fatturato complessivo di 720 miliardi di Euro.”.
A tesi del fatto che scienza e arte possono avere un rapporto più articolato di una semplice avversione o totale concordanza, Atonium ha bandito un questo concorso, basato su 5 attuali ricerche scientifiche a scelta.
Chiedo a Valentina se aveva già lavorato in passato con un dato scientifico che abbia costituito una base su cui costruire.
“Questo progetto è stato un un tassello in più per mia ricerca artistica che si basa sulla simbiosi tra uomo-natura-mutamento. La cosa più sorprendente del Progetto Genoma Umano, è che geneticamente le differenze razziali sono insignificanti, ciò significa che con probabilità siamo nati tutti da un’unica madre. Ho raccolto capelli di tutte le etnie da ogni parte del mondo, infeltriti e intrecciati alla lana di pecora appena tosata. In questo modo ho creato una struttura in grado di raccogliere il DNA di tutte le etnie. Ho trovato in questo concetto un anello di congiunzione al progetto “Silenzio” che ho esposto alla 54a Biennale di Venezia, basato su 308 corpi nati tutti da un’unica matrice.”.
L’effetto pare essere alquanto spettacolare: una specie di vello d’oro o mappa geografica disegnata nelle nuvole.
“La cosa sorprendente” continua Valentina “ è il numero elevato di persone che hanno contribuito alla realizzazione di “Hair and Wool” donando una propria ciocca di capelli. Una parte molto intima di ognuno di noi, così sottile, ma attraverso la quale si può leggere chi siamo.
Ho cominciato a documentarmi, ho fatto ricerche, ho scoperto anche che esiste un procedimento inverso, ovvero che attrevaerso il DNA di una persona si può risalire al suo colore di capelli….”.
“Per mesi ho raccolto capelli attraverso annunci tramite mailing list, passaparola e social network. Facebook mi è stato di grandissimo aiuto. Poi ho creato un fermoposta dove far arrivare le lettere con le ciocche. Alcuni le hanno inviate in forma anonima, altri hanno scritto un biglietto, altri ancora hanno lasciato solo il mittente. Sicuramente è un progetto che porterò avanti. Mi piacerebbe creare qualcosa con queste lettere….”
Un po’ come Michelangelo Pistoletto che trovandosi tutti quegli stracci in giro usati per lustrare i suoi famosi vetri, decide di utilizzarli nelle sue opere future.
Chiedo all’artista quando sarà in mostra questo lavoro:
“Verrà esposto prima a Palazzo Farnese a Roma il 21 gennaio per una serata di gala privata, poi dal 23 sarà esposto a La Sapienza fino a marzo.”
di Naima Morelli
Women in the city
20 Dicembre 2011
Varatio 02.
Photography
Museum
& Galleries
Valentina De’Mathà bases her exploration as an artist on matter that takes shape by itself, the trasformation of things, the everlasting mutations, the dynamism of metamorphosis, the becoming, the fullness and the emptiness of fife, the macro and microcosm.
Through her work she creates tension, dissonances when interiority and exteriority correspond, contraction and expansion in the balance between form and formlessness.
She works with water and organic materials (such as paper), that are subject to undergoing changes in time.Liminal States of Being
“He who has come only in part to a freedom of reason
cannot feel on earth otherwise than as a wanderer-though not as a traveler;
there must be something wandering within him,
which takes its joy in change and transitoriness.”
F.W. Nietzsche – Human, All Too Human (1878).
For Anaximander (Miletus 610/609-547/546 BC), Greek scientist, astronomer, politician, and philosopher of the Ionian School, a follower of Thales, ápeiron, namely the indefinite, is the source of the universe. Ápeiron means the original, eternal and boundless mixture of all things. The elements are generated from it as a result of the progressive separation and contrast of opposites in a cosmology revealing its own sense in the parting from the indefinite granted to humankind through the burden of conflict, the struggle among beings as definite entities – which vanish and return to the indefinite Whole which they will be recast from. Ápeiron is the boundless mass of matter in which every single thing first breaks down and then dissolves at the end of a cycle set forth and governed by law and its inevitability, governed by an immortal, indestructible and even divine principle. However, said property does not comprise a blend of elements (merged into it, each with its own peculiar features), but it is rather a substance in which said elements are not yet what they are (i.e., facts not already defined).
The concept of Ápeiron is a response to the questions raised by Valentina De’Mathà’s art because it fully captures the definition of an unaccomplished reality as hinted to by the artist. The indefinite nature of primeval matter concerns the transformation into shape, which hence becomes style dense in meaning without identifying with the sensuality of any bodily element (albeit dealt with and even seducing and manifest). On the contrary, the elements can be sensed with an impetus leading to a farther, inner dimension lying on the edge of any reference to the content of corporeity and hence leaving a formalistic legacy, shells void of any bodily weight, and spurious blots or shapes. The mass of matter seems to be quantitative in nature, but it can be traced to orders of anthroposophical value.
A matter of philosophical anthropology, then…
The idea of «body» escapes the need for recognition. It is the relinquishment of the restoring mimesis to take the system of knowledge beyond the threshold of the pleasure of physical comfort: within the triumph of an entirely theoretical, almost aprioristic, and even ontological nemesis. It is the foundation of a sort of corporeity, which descends from and yet leaves aside the particular through a knowledge prior to determination: a restless formal genesis void of the appropriate repose to reassure truth, a deaf reality in a mental form, not ideal yet spiritual.
Through the unsettled sensitivity of a space bordering on the incorporeal, Valentina De’ Mathà investigates into the body, an open body, a body which, through its own extension, lends itself to a declared extensibility: freed yet constrained by the sacred sense of the cycle. The body is determined by the potential of matter even though space and time are locked within the fractal of their entity, while a boundary exists only as a limit, as the quiver of matter: ready, troubled and already dismantled. Because the being is infinitely strewn in things, opening itself to the absence of an end and to the existence of impossible definitions.
The artist’s work inevitably tends to the transcendent. What the body encircles is always distant, external, outside: beyond what is encircled. Beyond mythology, mystical iconology is almost touched starting from matter, almost by a sort of physical make-up, which may nonetheless encounter religion, as every single thing that contemplates endlessness is exposed to the imminence of divinity. This dimension is still naturalistic yet governed by the laws of the universe, of the intrinsic universal. Everything is the fruit of a certain unrest: prime and eternal motion, unique in its kind, is the dynamic stage of evanescent bodies, capable of fading away until they become transparent (in the memory and dream of a shared universal belonging). Those bodies struggle to solve what they are, as they approach matter, which immediately becomes something else. It is both past and future; a faulty and fulfilled entity: atom, quark, quid, yuga… To reveal the way!
The body never gains a complete and fully enunciated sense, but, slave to its own being; it stands out of its imperfect anonymity, for the balance of its very opposites: first and foremost, formality and informality. It serves the logic of infinite worlds, which follow one after the other in an endless cycle (of birth, duration, and end). The opening of the body becomes the cosmic law of conflict, the application of duality in a change, which does not change, because conflict is implicit in the material perfection granted to humanity: both in the fortuitousness of the antimony between life and death and in the impossibility of escaping it. The body becomes the symbol of the original yet perturbed unity: the fruit of a break, which was first of all separation, namely a contrast based on the diversity from the endless stasis, from homogeneity and harmony, determining the condition typical of finite multiple beings different from one another, inevitably bound to break away from the Whole yet equally bound to return to it.
De’ Mathà’s art is based on this, on the unity, on the Oneness of this original content, which erupts into matter and shapes it albeit never fully, revealing boundaries that are unseemly so, scattered in the surrounding void, fascinatingly liquid, casually diluted. The flood – the witness of matter fresh in form – becomes the rule emanating from an iconography yearning to define it, to capture it in the pragmatic tension of a functional language because it is archeosophical, organic to the point of becoming the symbol of an absolutely contemporary cosmography. After all, it is an abstract propensity of empirics by which a sort of panic gnosis (made of matter representing truth) pertains to the flesh as an ethereal path for the rest – diluted in the nothingness surrounding it, always as light as thought, breaking through all limits by a predetermined variation unstable in essence. Whence the metamorphosis, in a becoming of plain gestural expressiveness, neither hot nor cold, simply neutral as biology; always immature, without any emotional excesses or dramatic hyperboles. Just a trace: the physiological tragedy of life – that immediately brings to mind Nietzsche’s «lucid lunacy» – with its spontaneous rhythm of full or void masses vaguely evoked in the journey towards the unknown, from the micro- to the macro-world, at the pace of contraction or expansion.
Everything and nothing alternate in penetrating one another, in a sort of chase to fill or empty the work: man (with his corporeity) on the one hand, and the world (in the white of the painted paper or the air surrounding the sculpture) on the other. The color of the figure, caught between the immaculate paper and the deserted air, in a pattern of interconnected repetitions: an imperfect subject along the borders, between insidious spaces about to blend what they perceive along the edges. One thing senses another and suffers from it. Always!
It is dependence in the eternal return (of every individual to the nothingness of the whole). Here lies the technical display, in the celebration of the cyclical expressiveness yearning for an unknown narrative, which, however, is knowledge. It is the narrative of the origin of order: from unfathomable yet undeniable chaos to entropy. It returns eternally. It is the eternal return as expounded by the German philosopher F.W. Nietzsche: a role of time in reality; from dreaming (freedom as possibility and fate as will), to nihilism (passive or active senselessness of life). Human happiness means redemption here – because of the salvific omen of circular time. Every instant of our lives is bound to return for always at the very moment of presence (if all things necessarily recur for eternity). The sense of time referring to the chaos which existence consists of is a curved trail in which every single thing perpetually tends to an infinite number of times without any metaphysical rule determining the linearity, the becoming of the past, present and future of moments depending on others. Time, the eternal return, sets the will of vital action, the commitment of human decision: in a chaotic reality of urges, vainly ordered by the deceit of a culture of morality. From a physical perspective, the measure of the universal force is assumed to be definite, but the time in which the cosmos exerts it is infinite: a cosmic rationale, which does not allow time to create anything immutable, but rather yields itself to the continual force of deliberate creativity.
This is the expressive narrative of Valentina De’ Mathà, who employs said energy for art. She is drawn in her necessity and lost in a deep feeling, towards the source and together with the barrier of complex constants. Valentina both charming and ritual. With orientalist charm, she dreams of modern solutions to ageless problems, while with an alchemical aura enshrined in the beauty of secrecy and research, she uses an art consisting in the cult of paper for the supreme ceremony of Matter. All of her works pulse with modern animism, alive by the continuity of each and true for the transience of all: the enchanting whisper of a shared intimism, which first permeates the obscure chemistry of an enraptured woman, then the enthralled taste of those who know how to understand her.
This is the eternal return over Valentina De’ Mathà’s path of the sublime…
The eternal return of morphology as the liminal state of being.
Fabio Migliorati
Arezzo, November 2009
Personale
“In realtà do poca importanza alle mie possibilità di essere veramente appagato (vorrei anzi non averne).Ciò che invece, indistruttibilmente, continua a risplendere, è la volontà di appagamento. Attraverso questa volontà, io derivo: io formo dentro di me l’utopia di un soggetto sottratto alla rimozione: io sono già questo soggetto”.
R. Bathes
da Frammenti di un discorso amoroso
© Roger Weiss
Un moto oscillatorio, un corteggiamento, una proiezione concettuale sulla fatalità di un’apparizione. Un incontro tra la cosa, la natura e l’artista che trasmigra il suo sentire all’estetica casuale – dipinta dal vento – di due ganci danzanti.
Un crocevia ha generato l’opera in video di Valentina De’Mathà, dal titolo “Il godimento è una tensione che non raggiunge mai la sua realizzazione, poiché può avere luogo solo quando non ha luogo”.
Una camera fissa, un’unica inquadratura all’interno della quale assistiamo alla ballata di due soggetti/oggetti che si palesano come attori intenti ad improvvisare un dialogo sulla metafora del non luogo del godimento. Sedici minuti durante i quali ci ritroviamo immersi in quella stessa dimensione temporale che il godimento occupa: il tempo del non compimento.
In questa temporalità aperta, in questo avvicendamento sempre in procinto di risolversi, si avverte l’impossibilità di raggiungere un sentire circoscritto, finito, impossibilità che ci permette di rimanere sospesi e transitanti in quello spazio che si situa tra il piacere e il godere: quello del desiderio.
Carnale o estetico che sia il godimento sta in una sorta di coazione a ripetere che ritarda costantemente il suo compimento. Se un fine e una fine fossero concepibili, piacere e godimento si equivarrebbero e lo scenario al quale saremmo chiamati ad assistere sarebbe la scomparsa del desiderio e l’esaurimento di questo moto perpetuo, di quella che Barthes chiama “volontà di appagamento”, ghermita con intuizione da Valentina De’Mathà.
E’ proprio nella spazialità e temporalità del desiderio, nella sottile lacerazione incolmabile che separa dall’altro e dall’altro da me, che si situa questa poetica dell’io desiderante, di un godimento privo di un definibile e definitivo telos, che ci permette di vivere come esseri colpiti da una disposizione cronica e insanabile all’eccitazione, spinti da una ricerca in continuo divenire che se appagata ci condurrebbe alla morte.
Non vi è risoluzione in questo video, non si vuole rispondere ad una domanda.
Si rimane con la sensazione che ciò che si è appena visto ancora sussiste.
Valentina Piccinni
Giugno 2012
Fame di Terra
Terra: responsabilità collettiva
Si crede che una mostra sia progettata e presentata avendo unicamente come scopo degli interessi culturali, artistici ed estetici. Allo sguardo del pubblico si presentano allora carrellate e serie di lavori della produzione recente di un artista, oppure un insieme di opere scelte per una sua possibile revisione storico-antologica o, altrimenti nel caso di giovani artisti, si cerca l’affermazione, a volte esasperata, della voce di una nuova generazione di talenti. Nel caso di una collettiva si riunisce un coacervo di personalità differenti e disparate (se non disperate!) con le scuse più svariate e, talora, davvero assurdamente pretestuose. Tralasciamo poi, per decenza, da tale novero tutte quelle circostanze che hanno il sapore di mere e semplici operazioni mercantilistiche che, per questa vile ragione, non meritano alcuna considerazione e, credo, nemmeno l’appellativo di mostra. Non possiamo considerare quindi una mostra – il cui apparato anche se ridotto ai minimi termini deve mantenere un minimo di scientificità e dovere intellettuale – quelle speculazioni che cercano solo l’arricchimento nella soddisfazione di un esibizionismo modaiolo. Di chi espone e di compra.
Una mostra, esibendo un linguaggio – ma anche più linguaggi la volta – che è variamente codificato come quello dell’arte, deve avere un impegno, in ogni ordine e grado. Deve incidere sulla visione, offrire spunti e riflessioni, aprire o soddisfare interrogazioni. Deve essere motivo di indagine e di conoscenza che porti ad una consapevolezza maggiore lo sguardo, ora edotto, dell’osservatore.
La contemplazione delle opere, con la loro iconicità rappresentativa e rappresentante, lascia accedere ad un livello superiore di arricchimento interiore. Questa ricchezza cognitiva e conoscitiva diventa la rivelazione del potere forte delle immagini e il loro essere tramite comunicativo. Sono le opere, e per questo le mostre che ne sono il contenitore e l’occasione, ad incidere sull’animo di chi le partecipa e le vive. Ogni occasione espositiva deve implicare, in chi la organizza e in chi espone, tanto quanto in chi le supporta criticamente, un grande fattore di responsabilità. Una responsabilità tanto importante quanto trascurata nella prassi attuale.
Anche i musei – lasciamo volutamente fuori dal discorso le gallerie private – ormai propongono mostre blockbuster finalizzate solo a questioni di immagine e di budget. Mostre da copertina che portano il museo ad abdicare al suo ruolo determinante nella vera promozione culturale e scientifica. La macchina complessa dell’insieme opere-mostra, per funzionare, deve tornare ad essere intesa come una palesamento su un contenuto preciso, inatteso magari, per il pubblico. La mostra deve lasciare, per un tempo prolungato ben oltre la sua durata, qualcosa di permanente. Un segno tangibile su chi ne ha seguito e compreso il percorso.
Fame di terra, progetto personalmente studiato e creato dalla generosa dedizione e dalla grande sensibilità di Anna D’Ambrosio, diventa un caso espositivo che ha le caratteristiche cui vorremmo sempre vedere visitando ogni mostra perché orientando l’attenzione, già fin dal titolo, su un tema-contenuto preciso e chiaro, inopinabile, ci guida ad un’attenzione inderogabile. Fame di terra ha un intento rigoroso che è nobile motivo per discutere su questioni di stringente attualità. Un’attualità che diventa non speculazione intellettiva, ma urgenza sociale e collettiva cui l’arte può adempiere grazie all’immediatezza comunicativa e assertiva delle proprie immagini. Come dicevamo le opere parlano, più di ogni elaborazione testuale o verbale.
Introdurre una mostra di questo tipo – come ben rileva Ilaria Bignotti nel suo intenso testo a seguire in cui si dedica specificatamente alle poetiche dei singoli artisti – non pare essere affatto cosa semplice. Non è semplice proprio per l’impegno e la valenza socio-culturale che questo progetto implica. Diviene un atto di responsabilità riuscire a tracciare, a parole, la nobiltà degli intenti programmatici che questa esposizione sottintende ed evidenzia nel peculiare percorso espositivo.
Fame di terra nasce come possibilità di riflessione su un tema socio-economico attualissimo: si è voluto capire ed evidenziare come, negli imperscrutabili disegni del sistema economico mondiale, la terra (nel senso agro-economico) stia ritornando ad essere oggetto di nuove speculazioni colonialiste. Colonialismo più subdolamente spietato di quello ormai consegnato agli annali della storia. Oggi la terra è un bene in via di accaparramento da parte di vecchie e nuove potenze che, ipocritamente, acquistano infinite e sbalorditive quantità di terreni lontani dai propri confini nazionali, per arroccarsi poi il diritto di sfruttamento di questi suoli per i propri fini. Ad uso e vantaggio esclusivo della propria popolazione, emarginando ed escludendo quelle locali che, di questi, ne avrebbero naturalmente diritto. Avere terra significa poter disporre di risorse per il proprio popolo e la possibilità di esercitare un controllo sugli altri. Una fame futura sfamata con la fame attuale di terra. Un meccanismo in atto da tempo. Questa è un’acquisizione legalmente debita ma che, alla lunga, inciderà negativamente sulle dinamiche demo-economiche dei paesi coinvolti.
Il colonialismo selvaggio, che nelle epoche passate si era generato dalla società occidentale legittimando uno sfruttamento per una presunta e supposta superiorità culturale, morale e tecnologica, diventa oggi pratica allargata e globalizzata in ogni latitudine e da diversi sistemi di governo e nazioni. Senza distinzioni, senza sconti.
Ecco allora che, per indurre un livello maggiore di sensibilità su questo tema, sono stati selezionati un gruppo di artisti diversi per esperienze, linguaggi e visioni, ma tutti accomunati dall’aver posto, in tempi non sospetti e quindi rendendo autentica e vera la loro dichiarazione, al centro delle loro opere la natura e la terra come elementi originanti. Da questo assunto di partenza si comprende come la mostra viene costruita su presupposti precisi e coerenti, non forzosi e faticosi nel delineare e declinare opere adattate e costrette nella circostanza dal tema. La verità espressa dalla loro voce si fa allora testimonianza e messaggio valido, attendibile e credibile. Chi le osserva può accedere ad autonomi spunti di riflessione e suggestione, senza avere lo sguardo costretto sull’inattendibilità di scelte obbligate. Le opere, nella loro autonomia, aprono accessi a territori opportuni perché frutto della consapevole considerazione di una ricerca che ha già svolto e dato esiti su temi pertinenti il soggetto vasto della natura e di cui la terra rimane oggetto cardine, risolto nel suo rapporto con l’uomo.
Fame di terra è allora una grande scommessa lanciata al pubblico, alla sua sensibilità e al suo grado di giudizio e all’affinità elettiva che saprà accogliere la visione proiettata dalle opere di questi bravi e sensibili artisti. Questa mostra diventa esempio significativo e, direi senza ipocrisie, coraggioso che rilancia all’arte il suo potere comunicativo, coinvolgente e trascinante, rivendicandole il pieno diritto di parlare oltre i confini abituali e stereotipate del proprio settore. L’arte, per l’universalità del suo comunicare, ri-torna, in questa circostanza, al suo compito di sensibilizzazione della collettività. Ri-torna al suo ruolo sociale.
Affrontare un tema di questo tipo potrebbe, come detto, risolversi nella retorica della circostanza, ma la mostra si pone ed ha dei doveri e assume ruoli e compiti ben precisi: non si vuole in alcun modo persuadere il visitatore-spettatore forzosamente e, concetto da ribadire con forza, deve essere intesa come il solito manifesto pseudo ecologista e alla moda. Qui si rincorrono valori reali, preoccupazioni e paure, pensieri e ipotesi, che scaturiscono dall’impegnata intuizione degli artisti e dalla pertinenza delle loro poetiche. Parlare di terra oggi deve diventare una problematica intesa e considerata come un fatto accertato che non deve precludere, anzi deve implicare, una responsabilità collettiva. Responsabilità che si produce da una particolare individualizzazione della comprensione della situazione e, legandosi ad altre sopraggiunte, diviene condivisione collettivamente estesa e simmetrica. Uguale per tutte le persone, specifica per ciascuna di esse per sentimento e sentire.
Tornare alla terra significa ritrovare un equilibrio orizzontale tra il ritmo e le dinamiche dell’uomo contemporaneo e i valori e le armonie naturali, che sono stati soppiantati nella contemporaneità dall’artificialità del nostro progresso. Gli interventi degli artisti, ciascuno con la sua peculiare e individuale voce, apre uno spazio di riflessione e indagine unico. Bisogna rendere consapevole lo sguardo e stare ad ascoltare la visione che queste opere ci suggeriscono singolarmente e nella totalità del loro complesso, di cui la mostra resta fedele trasposizione.
Dobbiamo superare e vincere in maniera coesa e senza distinzioni la fame di terra che sta serpeggiando nei cinque continenti. La terra, pare ovvietà rimarcare questo concetto, rimane il nostro bene in assoluto più prezioso, da lei deriva tutto quello che abbiamo. Un bene che non deve essere consumato, trascurato o, peggio, esaurito. Da lei deriviamo noi stessi.
Quanto tempo ci resta per riuscire ad essere consapevoli di questo processo che, tenuto scientemente silente per questioni politiche dai potenti, pare essere irreversibile? Quanto tempo ci resta prima che la nostra consapevolezza di uomini semplici si spenga in un inutile quanto tardivo tentativo di intervento? Oggi quando le tensioni sembrano già emergere in tutta la loro drammatica urgenza. Deve riflettere il pubblico, deve comprendere prima che sia tardi, anche attraverso queste opere, che la fame di terra non può, nè deve, essere taciuta a lungo.
Torniamo allora al merito della mostra: qui si dimostra e testimonia un problema che affligge l’oggi e al dovere che ci attende, fatto che le opere degli artisti testimoniano, svelando le potenzialità versatili dell’arte e restituendole la sua efficace forza persuasiva. Per questo un dovere di coscienza prima ancora che di conoscenza.
Matteo Galbiati
Maggio 2012
Valentina
De’Mathà
o il corpo
dell’artePhoto Roger Weiss
Ci si può perdere tra le foto presenti sul sito di Valentina De’Mathà, su Facebook o su MySpace cliccando da un’immagine all’altra, navigando di album in album. E’ un viaggio visivo e mentale in cui sembra di entrare nel suo studio e di poter vedere, toccare, sentire, partecipare come in un reality senza la necessità di sporcarsi con la realtà, essendoci già chi lo fa per noi.
Nella grande quantità di immagini a disposizione di chi guarda avviene uno sdoppiamento di senso: quello che a prima vista può essere preso per esibizionismo diventa da un lato estetica, dall’altro azione. Body-art e action painting dis/unite, tendenti all’oltre, alla creazione non di un’icona, né di un idolo, ma di un feticcio: sia che si tratti di immagini che ritraggono l’artista nel suo studio mentre lavora e si riposa, sia che ci si trovi di fronte alle sue opere, sculture, disegni, acqueforti, fotografie, video, abbiamo la sensazione di avvicinarci a qualcosa che si trova più in là. Basta prendere una foto qualsiasi per trovarsi di fronte al dilemma, di caputiana memoria, “se il feticcio sia arte oppure no” o il suo contrario: se l’arte sia un feticcio. Gillo Dorfles ha ampiamente riflettuto sulla questione nel suo libro Il feticcio quotidiano, dando diverse chiavi di lettura, ma lasciando ai posteri l’ardua sentenza, ovvero se sarà vera arte: “alcune grandi invenzioni concettuali come quelle di un Duchamp potranno sopravvivere (…) ma non c’è dubbio che in altri casi queste opere vedranno esaurirsi la carica feticistica e idolatrica che ne sanciva il valore artistico e commerciale”. Tuttavia credo che sia comunque importante cercare di capire questa carica feticistica per poter interpretare l’arte contemporanea e la nostra società. Ormai è appurato che il feticcio non appartiene solo alle società “incivili”, ma che è parte integrante anche delle civiltà progredite che si proclamano anti-feticiste. Così non credo di fare un torto a Valentina De’ Mathà se parlo della sua arte in senso feticista: i suoi media artistici sono molteplici, ma sicuramente quello che per primo appare è l’uso del suo stesso corpo, con i suoi tatuaggi, con il suo macchiarsi di vernici, in una sorta di body art che ha le sue origini nelle performance delle modelle-pittrici di Yves Klein, ma che si arricchisce della potenzialità dell’immagine digitale, ovvero versatilità e velocità. Il corpo è un medium artistico come gli altri: sempre chiamando in causa Dorfles “è altrettanto importante e decisivo del colore per la pittura, del suono per la musica, della parola per la poesia”. È importante evidenziare che non si parla più di una questione meramente freudiana di un corpo feticcio e quindi sessuale, come avviene ad esempio nel fenomeno delle Suicide Girls: ci troviamo davanti a ciò che Bruno Latour chiama fatticcio, ovvero l’unione delle parole fatto+feticcio, termine che mescola insieme le loro simili etimologie: “La parola fatto sembra rinviare alla realtà esterna, la parola feticcio alle folli credenze del soggetto. Entrambi dissimulano, nella profondità della loro radice latina, il lavoro intenso di costruzione che permette la verità dei fatti come quella degli spiriti. (…) Il fatticcio propone un comportamento radicalmente differente: è perché è costruito che è così reale, così autonomo, così indipendente dalle nostre stesse mani”. Il gesto artistico, la pennellata, la posizione accovacciata nell’atto di stendere la carta, i piedi intrisi di colore, lo stare seduti nudi sulla chaise longue guardando in macchina, non si congela nell’immagine, ma si fa nell’immagine. È un po’ come nel caso della passione dei giapponesi per la fotografia: immortalare qualsiasi cosa, tutte le persone che si incontrano in vacanza, tutti i luoghi notevoli, ma anche i soggetti più insignificanti, come il tabellone degli orari dei treni alla stazione o il piatto di lasagne ordinato al ristorante, altrimenti è come se il viaggio non fosse mai avvenuto. L’ossessione di Araki Nobuyoshi per lo scatto, è infatti un problema di tempo perché è la quantità che dà la misura dell’esistere e quindi dello scorrere della vita. L’atto stesso di dipingere è importante quanto il suo risultato, lo scegliere di muoversi quanto il movimento stesso. Complice di Valentina De’ Mathà è l’artista e fotografo di moda Roger Weiss che costruisce delle immagini appositamente voyeuristiche ammantate di un’aura amatoriale: l’artificio è però evidente sia nell’uso del colore, sia nelle scenografie così ricche di richiami, a cavallo tra il gusto beatnik di Lennon e Ono e le pagine di moda di Vogue. Anche negli scatti “privati”, mescolati spudoratamente insieme agli altri album, dove si vedono Valentina e Roger come visitatori alla Biennale di Venezia 2009, in una camera di albergo o in vacanza al mare come una coppia qualsiasi di innamorati su Facebook. Come conferma Mario Perniola in La società dei simulacril’aspetto feticistico pervade, invade, dilaga ovunque ed “è sempre stato presente nella fruizione artistica, si estende nell’arte contemporanea a tutti gli aspetti e i momenti del processo e qualifica lo statuto dei suoi prodotti.”
Davanti agli occhi ho una foto che ritrae Valentina De’Mathà in una stanza lilla, lei accovacciata, non al centro della foto, ma un po’ più a destra, con le calze blu e le scarpe rosse, le ginocchia che tendono le calze, schiarendole, e il mento posato sulla mano, la bocca socchiusa, lo sguardo fuori macchina, l’occhio destro forse leggermente divergente, i due fiumi di capelli neri che le ricadono a destra e sinistra del volto coprendole il petto. Ma la fotografia continua, l’artista occupa solo una parte dello spazio: un rotolo di cavo elettrico, una prolunga, sta lì al centro della foto, un cavo giallo che passa davanti a lei esce dal campo visivo, rientra e si infila in una presa elettrica alla sua destra; un cavo nero invece esce dalla prolunga e si perde nel fuori campo a sinistra. Una scenografia quasi metafisica, dotata di musa inquietante e oggetti estranianti. Altre foto potrebbero ricordare le muse-modelle di Vanessa Beecroft che de-erotizza il nudo moltiplicandolo e freddandolo nel tempo e nello spazio; tuttavia, mentre nella Beecroft la costruzione dell’immagine è scientifica e calcolata con precisione maniacale nel tentativo di arginare il caos, la De’ Mathà lascia una finestra aperta verso l’ignoto, la magia, il sacro e quindi verso il feticismo pervadente tutto il suo lavoro: le sculture in cartapesta sono corpi disfatti girati verso il muro (di nuovo le statue di spalle di De Chirico), i disegni ad inchiostro sempre di corpi costruiti a grandi gesti, gli astratti che sono dei dettagli di un mondo invisibile ad occhio nudo. Oppure i video dove gli inchiostri diluiti nell’acqua si scompongono lentamente creando figure surreali, o il movimento continuo e senza logica apparente di un lenzuolo che crea forme e allo stesso tempo deforma la percezione. Lo sdoppiamento è visibile anche qui: il corpo nel suo mostrarsi all’occhio voyeuristico che guarda, ma anche la sua totale assenza nel suo celarsi dietro forme astratte e casuali. Tra questi poli sta il corpo dell’arte: il corpo di Valentina De’ Mathà, che si trova al di là di qualsiasi estetica o estatica visione.
http://www.adgblog.it/2010/03/09/valentina-de-matha-o-il-corpo-dell-arte/
NY Arts Magazine
Vol. 16
Winter 2011
The discomforts of skin The scabs of life are revealed. Their presence in the world presses on the flesh, so that the surface of the skin cannot restrain the bursting interior
Drive is a project which uses symbols of repressed sexuality that feeds off the mentality of the abject deniers of life. The images reflect the Christian icons where the rabbit symbolizes the absence of reasoning just as the halo symbolizes the spirit of denial—a confrontation where the sexual drive, deprived of its rightful consciousness, is stifled in full flower in men whose grudge is characteristic of our times. This castration is the continuing source of why today people cannot be happy.
Incapable of being sufficient unto themselves people adopt the idea of an entity capable of absorbing any responsibility through the figure of God, or of surrogates of His, that help them choose not to choose a life worth living.
The nudity of the protagonist reveals a body disputed between Dionysus and Apollo as site of the self and at the same time the self’s own means of expression. As human beings we are always apprehensive about anything that might harm our body. And revealing the body can threaten our security by imposing a vulnerable intimacy. Once our defensive clothing is removed, we are left to be seen only through our physicality. This revelation of our physicality is only allowed to lovers and most people are uncomfortable in such situations. For this reason, human beings create special rituals to control nudity. In medicine, to take one example, a separate domain is set up to symbolize the transition of the body from being the site of the self to being a mere object for examination. Thus transforming the person into a patient. And disembodying the body.
Here, on the other hand, undressing is not a common gesture, arranged by custom within specific rules of interaction to assume a carefully staged façade. Life histories can’t be taken off like clothes. The protagonist does not avoid/reject the “scents” of her own life. She does not shed her skin, as if the skin were a sort of nylon stocking, to confuse and domesticate perception, to smooth away the scars of existence. Rather, she deliberately displays her body with a powerful, even raw/natural/crude vitality. The scabs of life are revealed. Their presence in the world presses on the flesh. So that the surface of the skin cannot restrain the bursting interior. And the body becomes essential to the communication of the feelings experienced.
Freud coined the term “Drive” to denote the sexual urges and the aggression as distinct from other psychological processes. The term was then changed to the German word “Trieb” and in English to “Instinct”, “Motivation” … and “Drive”. “Drive” means impulse but literally has also the meanings of “driving a car, conducting, leading…” In this case “Drive” means “Leading to deprivation, to castration… to masochism…”

















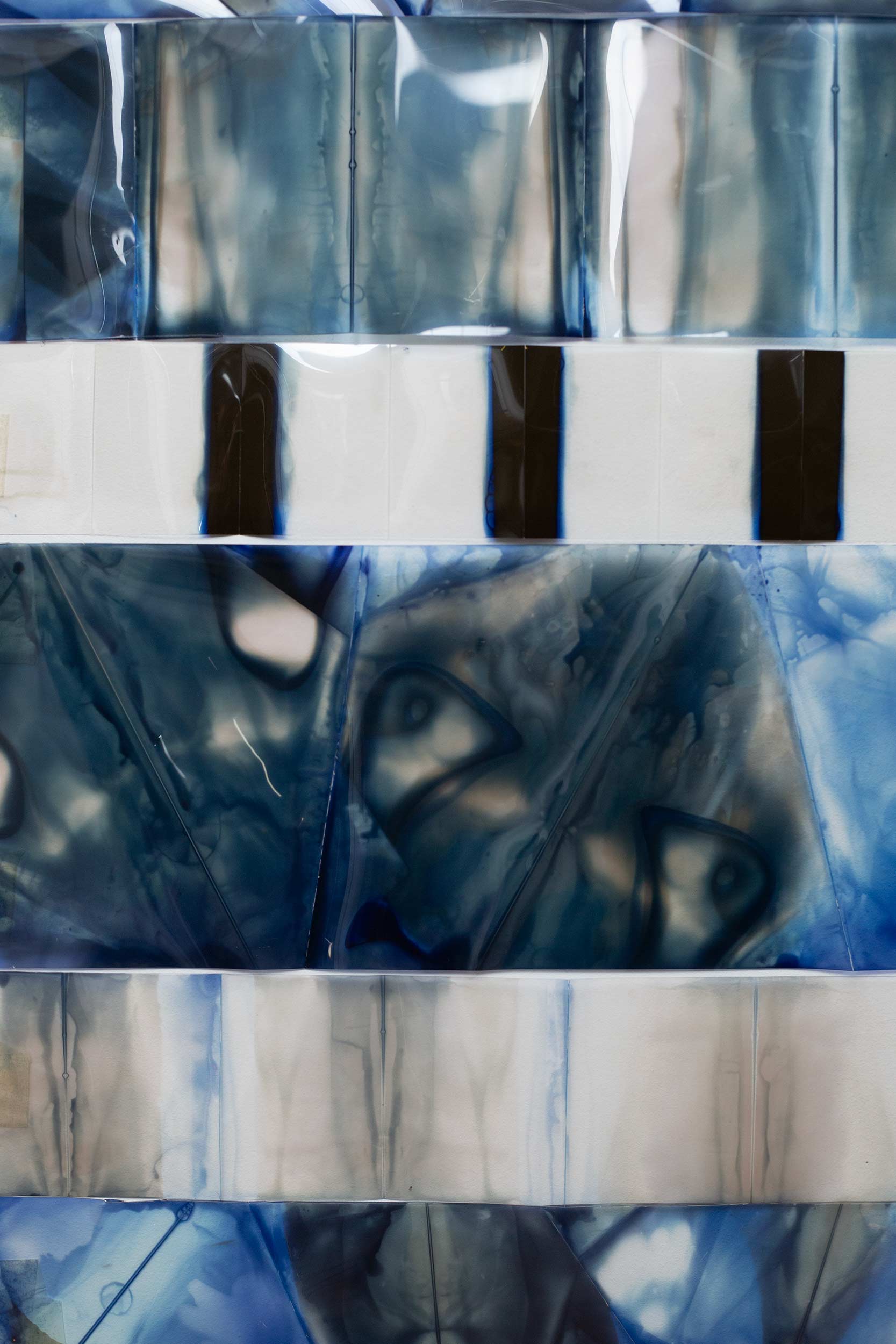










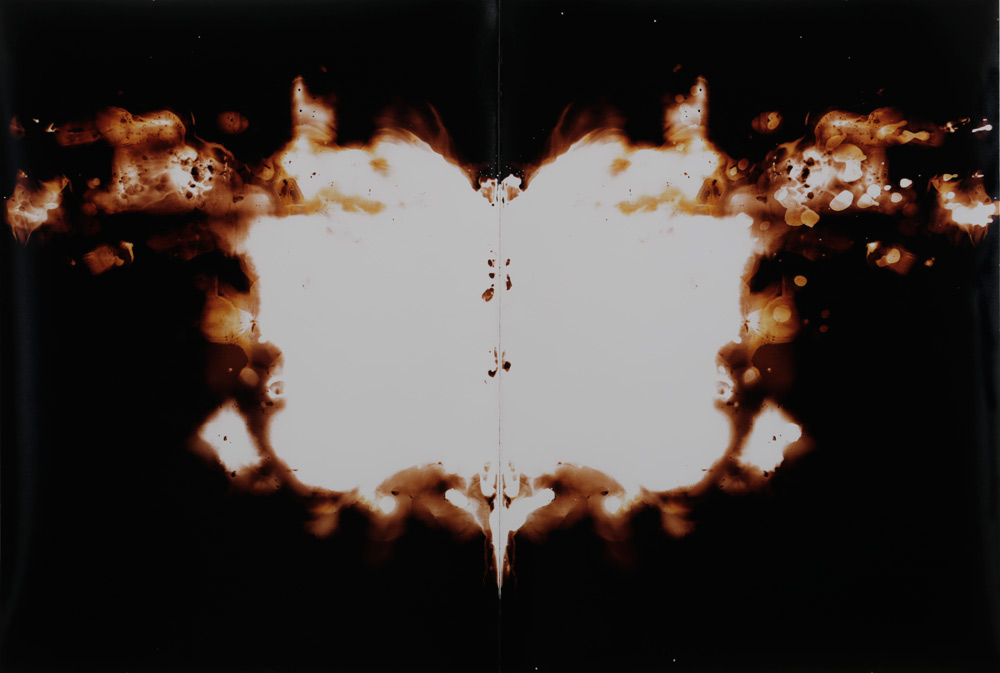




 -Guardando i tuoi profili sui social network non è difficile intuire il forte legame tra la materia e il tuo corpo. Si vede chiaramente dalle tue foto che hai bisogno di sperimentare, di sporcarti con quella stessa materia con cui plasmi i tuoi lavori e di creare un percorso tangibile che probabilmente fa parte anch’esso della stessa opera d’arte nella sua propria forma. Ti capita mai di riguardare queste foto a opera ultimata? Se si cosa provi mentre ti guardi?
-Guardando i tuoi profili sui social network non è difficile intuire il forte legame tra la materia e il tuo corpo. Si vede chiaramente dalle tue foto che hai bisogno di sperimentare, di sporcarti con quella stessa materia con cui plasmi i tuoi lavori e di creare un percorso tangibile che probabilmente fa parte anch’esso della stessa opera d’arte nella sua propria forma. Ti capita mai di riguardare queste foto a opera ultimata? Se si cosa provi mentre ti guardi?
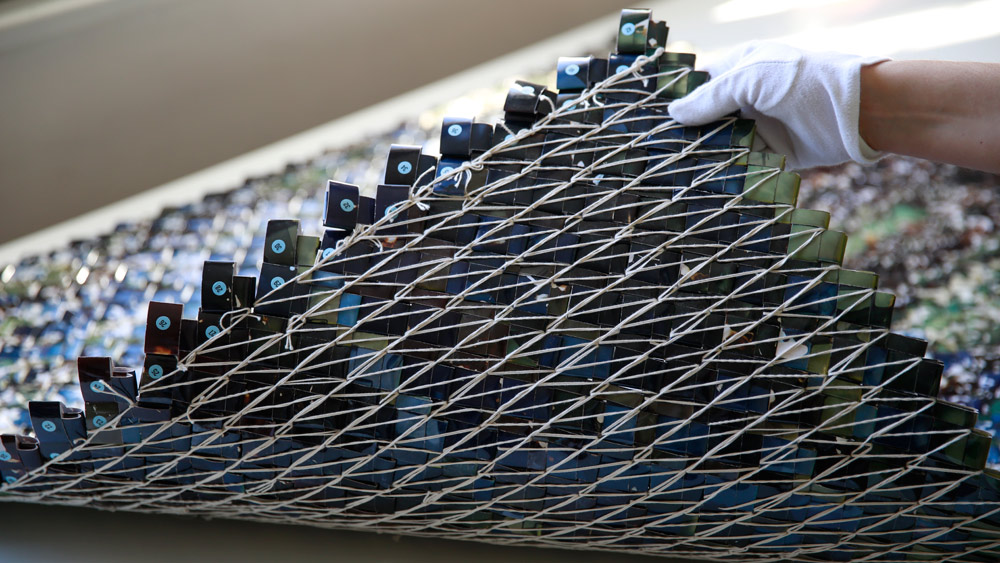



















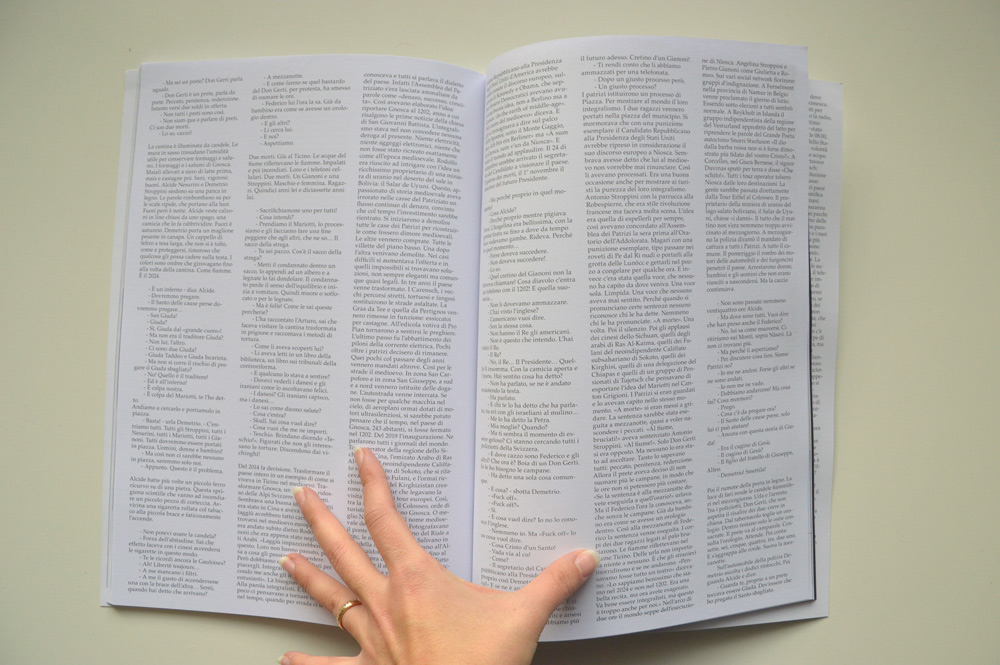




 For his first group exhibition at his temporary space, Randall Scott selected painters, mostly from New York and Los Angeles; his second is of photographers, and includes several from Europe. Neither lineup was chosen to highlight a particular theme, but some emerged nonetheless. Among the nine artists in “Untitled No. 2,” three address female identity and self-image.
For his first group exhibition at his temporary space, Randall Scott selected painters, mostly from New York and Los Angeles; his second is of photographers, and includes several from Europe. Neither lineup was chosen to highlight a particular theme, but some emerged nonetheless. Among the nine artists in “Untitled No. 2,” three address female identity and self-image.


 Photo Roger Weiss
Photo Roger Weiss


 Valentina De’Mathà bases her exploration as an artist on matter that takes shape by itself, the trasformation of things, the everlasting mutations, the dynamism of metamorphosis, the becoming, the fullness and the emptiness of fife, the macro and microcosm.
Valentina De’Mathà bases her exploration as an artist on matter that takes shape by itself, the trasformation of things, the everlasting mutations, the dynamism of metamorphosis, the becoming, the fullness and the emptiness of fife, the macro and microcosm.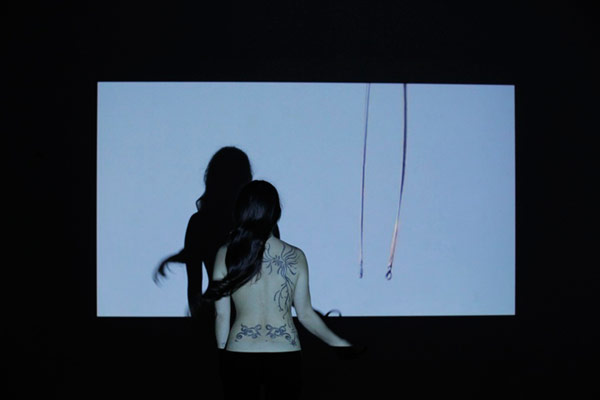 © Roger Weiss
© Roger Weiss



 Photo Roger Weiss
Photo Roger Weiss